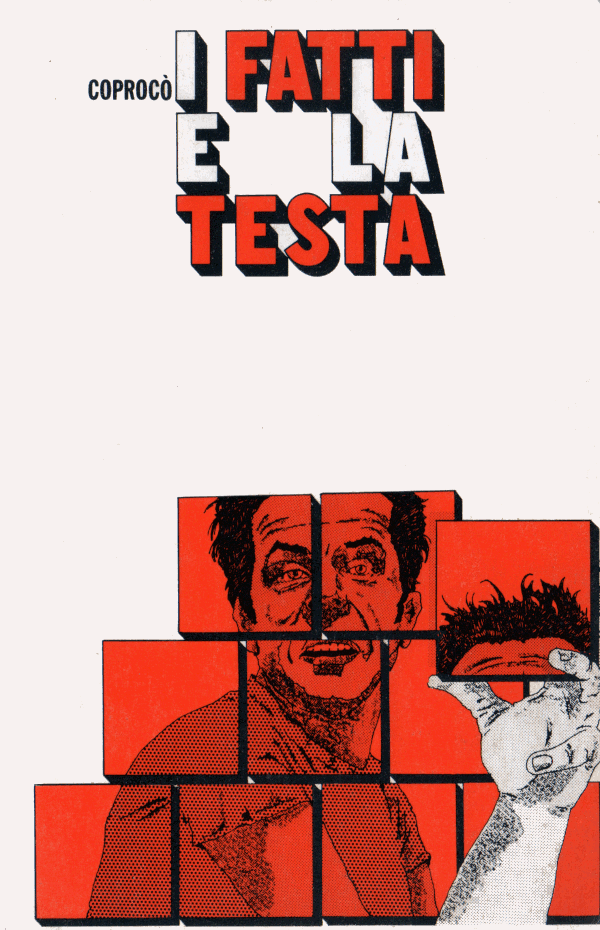
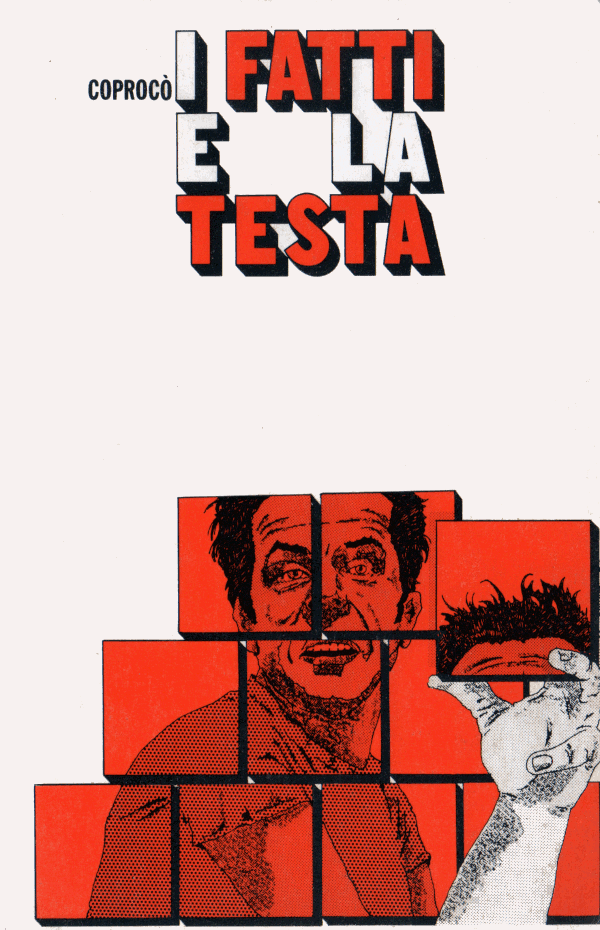
GIUSEPPE MAI Editore
via Sauli, 7 - 20127 Milano (02) 2859751/6173990
Stampa: Arti Grafiche Decembrio S.r.l., Via Decembrio, 26 20137 Milano - Tel. 5462536
Fotocomposizione e montaggio: Videostena s.n.c., Via Decembrio 26 - 20137 Milano - Tel. 598043
Copertina e Grafica: LaManoVale
Finito di stampare nel mese di Aprile 1983.
Tutti i diritti riservati.
I fatti hanno la testa dura
Più i problemi si aggravano e meno
si lasciano soggiogare dalle parole
COPROCO’
I FATTI E LA TESTA
L’aristocrazia
proletaria dei paesi imperialisti, la transizione dal capitalismo al
comunismo, la rivoluzione comunista e le teorie soggettiviste
Potete scaricare il seguente testo in versione Word e Open Office
Indice
Una «proposta di ricerca» diversiva
2. Rapporti di produzione ridotti al processo lavorativo immediato.
Concessioni all’operaismo soggettivista
Lotta politica e rivoluzione sociale
1. Autonomia della politica dall’economia.
2. Autonomia della politica dal sociale.
3. Leggi oggettive e azione soggettiva nella società borghese e nel movimento rivoluzionario.
La centralità della classe operaia nel processo rivoluzionario
Il socialismo: transizione dal capitalismo al comunismo
1. Togliere la natura di merce ai prodotti e alla capacità lavorativa umana.
2. Limitazioni alla natura di merce dei prodotti e della capacità lavorativa durante la transizione
3. Compiti di trasformazione nella transizione.
4. Problemi della transizione: alcuni esempi.
5. Dimensione mondiale della transizione.
Partito, organizzazioni di massa, stato
Vecchi bisogni e «nuovi bisogni»
2. Per l’analisi di classe dei paesi imperialisti.
3. L’aristocrazia proletaria dei paesi imperialisti e la rivoluzione comunista
Nota 1 - La «verità dei prezzi» nei paesi del «socialismo reale»
Nota 2 - Rapporti di produzione e mezzi di produzione
Nota 3 - Le basi economiche dell’espansionismo sovietico.
NOTA - Tutti i rimandi nel testo (per esempio, "vedi pag. 141") si riferiscono all'edizione cartacea.
Ai compagni caduti
lottando per il comunismo
Presuppongo naturalmente lettori che
vogliano imparare qualcosa di nuovo e
che quindi vogliano anche pensare da sé.
(K. Marx)
Le considerazioni delle pagine seguenti furono svolte discutendo del documento Vada il calzolaio oltre la scarpa inviatoci da Giuliano Naria nell’estate 1981 da uno dei tanti carceri in cui lo stato borghese lo ha tenuto rinchiuso dal 1976.
Lo scritto venne studiato nel suo contenuto, in relazione al dibattito teorico in corso nel movimento rivoluzionario italiano; venne lasciato in secondo piano ciò che l’evidente spostamento di Naria da posizioni marxiste-leniniste verso posizioni operaiste faceva intravvedere quanto alla evoluzione della sua collocazione politica nell’ambito delle misure di annientamento della personalità fisica e politica dei prigionieri attuate dal Ministero di Grazia e Giustizia e della parallela campagna per la dissociazione portata avanti, d’intesa con la Magistratura e il Ministero degli Interni, da alcuni illustri intellettuali con alla testa il prof. Antonio Negri.
L’evoluzione politica di Naria è stata dallo stesso precisata in un successivo documento, posteriore alla stesura di gran parte di queste considerazioni, pubblicato con ampio favore da Il Manifesto in data 22 aprile 1982.
Nonostante questa evoluzione politica, che rientra tra le miserie individuali prodotte dalla politica carceraria dello stato, riteniamo utile pubblicare queste considerazioni perché riguardano alcuni temi fondamentali di analisi e di orientamento.
L’origine polemica di queste considerazioni esclude ogni pretesa di aver trattato di tutti gli argomenti rilevanti nell’attuale fase del movimento rivoluzionario (basti dire che non si parla della crisi economica del capitalismo). Intendiamo solo aver sottoposto a critica alcune delle tesi contenute nei due scritti presi in esame e che sono oggetto di dibattito nella attuale fase in Italia.
Lo scritto di Naria è in risposta alla Proposta di ricerca collettiva - Classe operaia, etica del lavoro, proletariato pericoloso pubblicata su Controinformazione, maggio ’81 e riportata in appendice’ (Appendice A).
Anche lo scritto di Naria è stato pubblicato su Controinformazione, dicembre ’81 ed è qui riportato in appendice (Appendice B).
A parte la difficoltà del linguaggio fantasioso, esoterico, involuto, la proposta di ricerca di Controinformazione e lo scritto di Naria riguardano i seguenti argomenti:
- analisi delle classi della società borghese metropolitana, cioè delle metropoli imperialiste;
- bilancio del movimento rivoluzionario proletario internazionale;
- programma politico generale (fase di transizione).
Questi scritti danno però per scontati anche tesi e giudizi su una serie di altri argomenti che invece è necessario portare alla luce: anche questo si è cercato di fare in queste pagine
Partiamo da Controinformazione.
La proposta di Controinformazione è un misto di confusioni teoriche e di argomentazioni ideologiche e politiche che deviano l’attenzione, la riflessione e il dibattito dalle questioni reali indirizzandoli verso problemi intellettualistici e luoghi comuni anticomunisti.
Se la si accetta per buona e si parte dai problemi come li pone l’autore della proposta, non si può arrivare a niente di buono.
In cosa consiste il carattere diversivo della proposta?
L’autore della proposta dichiara di voler rivisitare criticamente la storia del movimento operaio fin dal passato remoto. In realtà presenta come movimento operaio aspetti del tutto secondari del movimento operaio, limiti transitori da cui questo si è liberato nel corso del suo sviluppo.
Quali sono infatti le tappe fondamentali del movimento rivoluzionario del proletariato? La costituzione di organizzazioni di classe in tutto il mondo, la Comune di Parigi, la Rivoluzione d’Ottobre, le lotte antimperialiste di liberazione nazionale, la Rivoluzione Culturale Proletaria Cinese.
A cosa fa invece riferimento l’autore della proposta?
Al socialismo governativo francese del secolo scorso (con puntate addirittura fino alla grande rivoluzione borghese del 1789), agli utopisti pre-marxisti, al tradeunionismo inglese, a Turati, Verga, Zola, Owen, Saint-Simon, al Gramsci del periodo 1919-21, ai socialisti riformisti e ai revisionisti.
In questa proposta come in tanti scritti di questi mesi vi è una forma di dissociazione che è la più diffusa, generale e subdola tra le tante in voga.
1. La dissociazione dalla storia del movimento proletario rivoluzionario, dal suo reale patrimonio di esperienze, di tentativi di ‘assalto al cielo’, di lotte, di successi e di sconfitte che viene cancellato dalla memoria o frettolosamente liquidato in qualche accenno. Chi può sostenere che per rivisitare criticamente la storia del movimento operaio sia più importante dilungarsi su Turati, su Owen o sul Gramsci del 1919/21 anziché sulla Rivoluzione d’Ottobre, sul tentativo storico di transizione dal capitalismo al comunismo cui essa dette luogo o sulla Rivoluzione Culturale Proletaria Cinese?
2. La dissociazione dalle lotte dei popoli oppressi del Terzo Mondo che costituiscono più del 75% dell’umanità e in genere dalle lotte delle classi e degli strati più sfruttati e oppressi degli stessi paesi imperialisti. La realtà della condizione umana dell’epoca imperialista, da cui non può prescindere nessun movimento pratico teso a trasformarla, è che oltre 500 milioni di uomini soffrono quotidianamente la fame, oltre 1 miliardo di uomini sono sottoalimentati, 30-40 milioni di uomini muoiono ogni anno di fame, mentre miliardi di uomini impiegano la loro esistenza lottando per soddisfare bisogni elementari quali cibo, vestiario, casa, salute, cultura, ecc. Ogni discorso che, prescindendo da questo, è rivolto unicamente ai bisogni ‘superiori’ di rapporti sociali, umani, ecc., diventa o una beffa o una fantasticheria imbelle di una minoranza sazia.
Ripercorriamo passo passo le critiche del nostro autore al ‘movimento operaio’.
a) Vi è tutto un periodo storico in cui il proletariato è impegnato a distinguersi dalle altre classi oppresse, costituendosi come classe distinta anche soggettivamente, cioè nella coscienza di sé. L’autore della proposta misconosce questo passaggio storico del proletario che, mentre viene materialmente sempre più costituendosi come ruolo sociale distinto dall’artigiano, dal garzone di bottega, dal servo della gleba, dal coltivatore diretto, dal vagabondo, dal povero, è impegnato anche a distinguersi soggettivamente, nella coscienza di sé.
L’autore prende per significativi e rappresentativi i riflessi opportunistici di questo sforzo, le concezioni che cercavano di cristallizzare teorie unilaterali riflesso di tappe di questo processo e di erigere una barriera tra il proletariato e le altre classi oppresse: la tesi di Lassalle che nella prima metà del secolo scorso in Germania proclamava che tutto il resto della popolazione al di fuori degli operai costituiva ‘una unica massa reazionaria’; il disprezzo per le ‘plebi meridionali’ di quei socialisti italiani che restarono inerti o presero posizioni ostili rispetto ai movimenti dei contadini meridionali (il ‘Brigantaggio’ degli anni 1860-1870, i Fasci Siciliani degli anni 1893-1894); le esaltazioni del ‘ruolo civilizzatore’ del colonialismo fatte da vari opportunisti sotto vari pretesti fino allo schieramento del Partito Comunista Francese contro la lotta di liberazione del popolo algerino.
L’Autore addebita ai comunisti in generale queste posizioni ignorando la politica di alleanza del proletariato delle metropoli imperialiste con i contadini, con le altre classi oppresse delle metropoli imperialiste e con i popoli oppressi dalle colonie che fu il lato rivoluzionario della III Internazionale e che si è sviluppato nelle posizioni dell’attuale movimento rivoluzionario delle metropoli imperialiste (teoria del proletariato metropolitano).
Sarebbe meglio che l’autore invece di ripescare Danton e Robespierre (ma che c’entrano costoro col movimento operaio?) si rivedesse Analisi delle classi nella società cinese di Mao - certo più interno al movimento operaio - o gli scritti di Lenin sulla guerra partigiana del 1905-1907 per poter criticare l’atteggiamento del movimento operaio verso il ‘proletariato pericoloso’.
Certo le cose cambiano se l’autore vuole imbrancarsi con quegli intellettuali che dal caldo dei loro studi esaltano e idealizzano la ‘scelta di vita’ dei vagabondi e dei proletari extralegali, che in realtà e notoriamente non hanno fatto alcuna scelta di vita essendo, come altre categorie, un prodotto del modo di produzione capitalista e li confondono con il giovane di buona famiglia anticonformista. Per i primi vagabondaggio ed extralegalità sono una condanna, per i secondi sono una più o meno transitoria ‘esperienza di vita’.
b) Del movimento sindacale degli operai l’autore vede solo l’assetto corporativo, nasconde l’aspetto di scuola di attività e coscienza rivoluzionarie e di organizzazione di classe.
c) Dell’operaio professionale l’autore trascura il ruolo rivoluzionario, d’avanguardia che ebbe per tutta una fase (quella della sussunzione formale del lavoro nel capitale) rispetto agli altri operai (basti ricordare il ruolo degli operai professionali in tutto il movimento dei Consigli in Europa e in Russia negli anni 1917-1921), per vedere solo il lato conservatore (diventato predominante solo nella fase successiva della sussunzione reale del lavoro nel capitale con conseguente affermazione dell’operaio-massa, laddove il capitale riuscì a contrapporre l’operaio professionale all’operaio massa: ha mai sentito il nostro autore parlare della teoria leninista della aristocrazia operaia?).
d) Dell’affermazione del diritto al lavoro e dell’obbligo di tutti al lavoro l’autore vede solo la trasformazione che ne ha fatto la borghesia di vario genere e tipo (compresi i revisionisti moderni) in esaltazione del lavoro come elemento principale, in eterno e in ogni circostanza, di formazione, di estrinsecazione e di sviluppo della personalità umana, delle potenzialità fisiche e psichiche degli individui, della libertà e della socialità degli individui (etica del lavoro) e ne tace il profondo contenuto rivoluzionario: la spinta alla fine del sistema del lavoro salariato, cioè dell’uso della capacità lavorativa umana come merce. Il movimento operaio rivoluzionario è stato così consapevole che il lavoro da una parte è una necessità e dall’altra è una condanna che schiaccia la maggior parte degli uomini, che una delle prime misure prese da ogni rivoluzione proletaria è stata la riduzione dell’orario di lavoro.
e) La emancipazione e la centralità operaia nel processo rivoluzionario l’autore le vede e le critica come controllo e capacità di controllo degli operai nel processo lavorativo immediato, secondo la scuola (certo non centrale nel movimento rivoluzionario) di Sorel e in parte del primo Gramsci e di alcuni suoi epigoni.
f) L’Autore contrappone il non-lavoro al lavoro, nascondendone la connessione dialettica, cioè il fatto che l’uno sorge necessariamente solo dall’altro, che il lavoro produce le condizioni che rendono possibile agli uomini liberarsi gradualmente dalla necessità del lavoro. L’Autore si attesta ancora, in un periodo in cui disoccupazione e cassa integrazione colpiscono milioni di lavoratori, alla esaltazione della cassa integrazione e del non lavoro come linea di lotta rivoluzionaria.
Di queste ‘scuole’ via via battute nel movimento rivoluzionario ed espulse da esso (che sorsero come parte di quel confuso balbettio con cui incomincia a farsi la coscienza di sé di una realtà nuova e poi diventarono un foruncolo infetto aderente ma antagonista alla realtà nuova), l’autore non scorge le basi materiali, collocate 1) in aspetti della non ancora completa sussunzione reale del lavoro nel capitale, 2) nella formazione di una aristocrazia proletaria nei paesi imperialisti, 3) nella permeabilità reciproca delle varie classi in cui è divisa la società che non sono per nulla separate da alcuna muraglia cinese, 4) nell’essere i concreti individui punti di scontro di vari rapporti sociali e in concreto sintesi di molte determinazioni formali, 5) nella ‘normale’ oppressione ideologica della classe dominante la cui ideologia è dominante nell’intera società, 6) nell’azione attiva e cosciente svolta dalla borghesia contro il proletariato nell’ambito della controrivoluzione preventiva. L’autore considera queste ‘scuole’ degli errori ideali, nati autonomamente nella coscienza degli uomini, che egli ora vuole correggere.
Insomma la proposta è un miscuglio di critiche delle concezioni reazionarie ed anarchiche (concezioni marginali nel movimento proletario e da cui esso si libera e si è liberato, con un processo ininterrotto di divisione in due termini antagonisti di ciò che fino ad un certo punto è unito), presentate come aspetto principale del movimento rivoluzionario del proletariato onde poter concludere che tutto il movimento rivoluzionario del passato fu merda, sbarazzarsi così della necessità di fare un bilancio dell’esperienza di quasi duecento anni di movimento rivoluzionario del proletariato e accreditare la ‘nuova’ concezione rivoluzionaria nata nell’intelletto dell’autore.
Critiche che per di più vengono condotte restando interamente sul terreno delle stesse tesi reazionarie e anarchiche o della loro negazione intellettualistica, cioè presentando le stessi tesi rovesciate (ad es. all’etica del lavoro si contrappone l’abolizione del lavoro), perché la ‘nuova’ concezione rivoluzionaria dell’autore non è in realtà che una raccolta delle correnti culturali sviluppatesi negli ambienti universitari e intellettuali europei ed americani che (nella loro maggioranza), quando non sono direttamente al servizio della borghesia imperialista e quindi fanno cultura ‘critica’, riflettono la condizione contraddittoria della aristocrazia proletaria delle metropoli imperialiste.
Riassumendo, il nostro autore manca di ‘senso storico’, ignora la relazione tra materia e coscienza e infine ignora la dialettica che insegna ad andare oltre la fotografia dell’esistenza e a distinguere ciò che è in sviluppo e in crescita da ciò che sta morendo ed è ormai solo di ostacolo.
L’autore della proposta riduce i rapporti di produzione al processo lavorativo immediato (l’attività concreta svolta dal lavoratore), anziché seguire e vedere il processo di unità e di lotta tra i due termini.
L’analisi delle classi non discende dal processo lavorativo immediato che può anche essere comune a varie classi: ad es. il bracciante agricolo e il coltivatore diretto svolgono spesso lo stesso lavoro, così pure un commesso di negozio e un dettagliante in proprio, un artigiano e un operaio; esistono innumerevoli lavori immediati che sono svolti egualmente da individui di classi diverse, cioè sono eseguiti eguali nell’ambito di rapporti di produzione diversi.
L’analisi delle classi va condotta sulla base dei rapporti di produzione in cui gli individui sono inseriti e nell’ambito dei quali compiono il loro lavoro. I rapporti di produzione comprendono: il sistema di possesso dei mezzi e delle condizioni di produzione,(*) i rapporti tra gli individui nel lavoro e il sistema di distribuzione.
(*) Cioè chi ne dispone l’impiego, assume l’iniziativa di impiegarli ad un dato scopo, decide tempi e modi del loro impiego. Un aspetto particolare ma non essenziale del possesso dei mezzi e delle condizioni della produzione è la capacità di trasformarli in equivalente generale (danaro), cioè di venderli e comperarli, di commerciarli, di usarli come merci: aspetto che bisogna considerare a sé, perché questo aspetto del possesso è quello più limitato nelle società a capitalismo monopolistico di stato. Va da sé che ogni possessore è lungi dall’essere astrattamente e assolutamente libero nell’esercitare il possesso in tutti i suoi vari aspetti, ma è invece limitato dalla azione coercitiva dello stato e da rapporti economici, culturali e di fatto.
Tra i due termini (processo lavorativo immediato e rapporto di produzione) vi è un rapporto di unità e lotta, che in termini teorici generali è rapporto tra contenuto e forma.
Dati rapporti di produzione determinano lo sviluppo di certi processi lavorativi immediati e la morte di altri. Dati processi lavorativi immediati frappongono ostacoli alla loro sussunzione sotto certi rapporti di produzione, al loro essere espletati nell’ambito di certi rapporti di produzione. Il rapporto sociale di valore (produrre per vendere, produrre merci) e il rapporto sociale di capitale (produrre comperando capacità lavorativa altrui) hanno determinato la trasformazione dei processi lavorativi immediati in quasi tutti i settori lavorativi perché richiedono 1) aumento illimitato della produttività del lavoro dei lavoratori dipendenti (del resto dei lavoratori il singolo capitalista se ne sbatte) e della quantità di merci prodotte da ogni singola frazione di capitale, 2) regolarità delle lavorazioni, delle forniture e degli sbocchi commercialmente più favorevoli, 3) incorporazione massima della abilità lavorativa negli strumenti di lavoro, nel macchinario e in genere nelle condizioni di esplicazione del lavoro (che sono del capitalista) e di converso indebolimento del potere contrattuale e del patrimonio professionale del singolo lavoratore, 4) massima divisione tra lavoro intellettuale e lavoro fisico, tra attività di direzione, organizzazione, progettazione, regolazione, sorveglianza da una parte e lavoro esecutivo dall’altra, 5) divisione sociale del lavoro, 6) divisione tecnica del lavoro, 7) standardizzazione della produzione e una serie di altri aspetti connessi alla ineliminabile contrapposizione tra lavoratori da una parte e padroni dei mezzi e delle condizioni della produzione dall’altra.
Il rapporto di capitale ha trovato maggiore difficoltà ad imporsi in alcuni settori produttivi proprio per la natura del processo lavorativo immediato (date colture agricole, settori di servizi, ecc.), in particolare 1) in quei settori dove, per la natura del processo lavorativo stesso, è più complesso espropriare il lavoratore della creatività e dell’iniziativa e predisporre rigorosamente tempi e modi del suo lavoro e controllarlo efficacemente (in questi settori il rapporto si instaura spesso in forme diverse: cottimo, appalto, decentramento produttivo, ecc., che mantengono alcune apparenze e alcuni tratti del produttore autonomo); 2) in quei settori che per la loro natura stessa non si prestano alla riduzione illimitata del tempo di lavoro speso per un singolo prodotto perché produzione e consumo avvengono contemporaneamente (il capitalista ad es. non può ridurre quasi a zero il tempo di servizio di un pranzo, la cui durata è per forza il tempo del pranzo del banchettante, con facilità analoga a quella con cui può ridurre quasi a zero il tempo di lavoro necessario per trasformare un tondino di acciaio in bulloni); 3) in quei settori in cui la esplicazione della capacità lavorativa, la prestazione di lavoro è condizionata da fattori che il capitalista, al livello dato di sviluppo delle forze produttive, non controlla ancora (l’andamento stagionale in agricoltura, ad es.).
Il rapporto di valore ed il rapporto di capitale hanno determinato la modificazione di una serie di mestieri e di alcuni prodotti (le modificazioni dei prodotti a scopo puramente commerciale, la sostituzione di alcuni combustibili ad altri - del petrolio al carbon fossile e alla legna, di alcune fibre tessili ad altre, ecc. per la maggior facilità di adattare i relativi modi di produzione e lavorazione, i quantitativi prodotti e le modalità di impiego alle esigenze del modo di produzione capitalistico e mercantile).
In questo come in altri campi si conferma il rapporto dialettico contenuto-forma. La lotta del contenuto con la forma e viceversa. Rigetto della forma, rielaborazione del contenuto (Lenin, Quaderni Filosofici, Ed. Riuniti, 1976, pag. 206).
Esiste quindi tra i due termini (processo lavorativo e rapporto di produzione) un rapporto di unità e lotta che determina la trasformazione di entrambi (un rapporto dialettico), in cui il termine dominante è in generale il rapporto di produzione. Orbene l’autore della proposta (come in generale tutti gli intellettuali abbagliati dall’informatica, dalla cibernetica, dalla telematica, dalla robotica, ecc. cioè da ciò che oggi è l’innovazione principale del processo lavorativo immediato nel campo della produzione di merci, nel campo della circolazione e in altri settori) cerca di dedurre le ‘nuove figure sociali’ direttamente dalle modificazioni subite dal processo lavorativo immediato, di costruire una analisi delle classi sulla analisi del processo lavorativo immediato. Questi teorici restano nell’ambito quindi di quelle scuole teoriche secondarie che hanno accompagnato, fiancheggiato e ostacolato la crescita del movimento rivoluzionario del proletariato riflettendo gli aspetti arretrati di questo; scuole che hanno teso a vedere nella posizione occupata dagli individui nel processo lavorativo immediato, nel lavoro immediato da essi svolto, la causa diretta, unica o principale della collocazione sociale e politica degli stessi e della formazione della loro coscienza; che su analisi del processo lavorativo immediato hanno fondato tesi di centralità della classe operaia o di integrazione della classe operaia o di scomparsa della classe operaia.
Quanto qui sostenuto non implica che le trasformazioni del processo lavorativo immediato, delle condizioni immediate di ‘esplicazione della capacità lavorativa’, non modifichino l’abito e quindi la ‘natura umana’ dei soggetti. L’operaio della manifattura, l’operaio professionale, l’operaio-massa, il lavoratore a domicilio, l’operaio delle piccole imprese, l’operaio delle grandi fabbriche, il portuale dei containers e il portuale dello scarico manuale, l‘operaio dei campi petroliferi e il minatore dei bacini carboniferi, ecc. sono figure sociali distinte per mille aspetti; come il manager alla Massacesi e alla Romiti, il finanziere alla Sindona e alla Carli, il finanziere-industriale alla De Benedetti e alla De Tomaso, il padrone delle ferriere di Balzac, il concessionario di miniere di stagno della Malesia e l’appaltatore mafioso di lavori pubblici sono figure sociali distinte per mille aspetti.
Ma è stupido al riguardo perdersi in una sterile e intellettualistica contrapposizione tra continuità e discontinuità, quando da cento cinquant'anni già la teoria borghese (Hegel) ha mostrato la unità dialettica di continuo e discontinuo.
Riassumendo, il nostro autore riduce i rapporti di produzione al processo lavorativo immediato.
Naria nel suo scritto oppone a questa riduzione dei rapporti di produzione al processo lavorativo immediato che l’analisi e il concetto di classe operaia non possono essere riferite solo alla produzione in quanto produzione immediata. (pag. 141)
Tutto bene, salvo che per quel solo che è una concessione indebita ai riduzionisti!
La stessa concessione che Naria fa anche alla fine del suo scritto (pag. 158). Egli riporta la tesi illuminante di Marx ‘il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna: si trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria… Al di là di esso comincia lo sviluppo delle capacità umane, che è fine a sé stesso, il vero regno della libertà, che tuttavia può fiorire solo sulle basi di quel regno della necessità’. Ma anziché usarla nella sua parte rilevante ai fini della polemica contro la posizione unilaterale della proposta di Controinformazione (‘… che tuttavia può fiorire solo, ecc.’), la sua nella parte che, mutilata e resa quindi unilaterale, dà ragione all’unilateralismo dell’autore della proposta (alla tesi della ‘abolizione del lavoro” per intenderci!).
Il passo di Marx preso per intero (Il Capitale, libro 3°, Ed. Riuniti 1965, pagg. 932-933) ha invece tutt’altro senso:
Pluslavoro in generale, inteso come lavoro eccedente la misura dei bisogni dati, deve sempre continuare a sussistere. Nel sistema capitalistico come in quello schiavistico ecc., assume semplicemente una forma antagonistica ed è completato dall’ozio assoluto di una parte della società. Una determinata quantità di pluslavoro è necessaria per l’assicurazione contro le disgrazie, per il necessario e progresso ampliamento del processo di riproduzione corrispondente allo sviluppo dei bisogni ed all’incremento della popolazione, che dal punto di vista capitalistico si chiama accumulazione. Uno degli aspetti in cui si manifesta la funzione civilizzatrice del capitale è quello di estorcere questo pluslavoro in un modo e sotto condizioni che sono più favorevoli allo sviluppo delle forze produttive, dei rapporti sociali, e alla creazione degli elementi per una nuova e più elevata, formazione, di quanto non avvenga nelle forme precedenti della schiavitù, della servitù della gleba, ecc. Ciò porta ad uno stadio, in cui da un lato sono eliminate la costrizione e la monopolizzazione dello sviluppo sociale (compresi i suoi vantaggi materiali ed intellettuali) esercitate da una parte della società a spese dell’altra; d’altro lato questo stadio crea i mezzi materiali e l’embrione di nuovi rapporti che rendono possibile combinare questo pluslavoro di una più elevata forma di società con una riduzione maggiore del tempo dedicato al lavoro materiale. Infatti, in relazione allo sviluppo della forza produttiva del lavoro, il pluslavoro può essere grande con una giornata lavorativa complessiva piccola, e relativamente piccolo con una giornata lavorativa complessiva grande. Se il tempo di lavoro necessario è = 3 ed il pluslavoro anche = 3, allora la giornata complessiva di lavoro è = 6 ed il saggio del pluslavoro = 100%. Se il lavoro necessario è = 9 ed il pluslavoro = 3, allora la giornata lavorativa complessiva è = 12 ed il saggio del pluslavoro soltanto = 33,3%.
Inoltre, dipende dalla produttività del lavoro quanto valore d’uso venga prodotto in un tempo determinato, quindi anche in un determinato tempo di pluslavoro. L’effettiva ricchezza della società e la possibilità di un continuo allargamento del suo processo di riproduzione non dipende quindi dalla durata del pluslavoro, ma dalla sua produttività e dalle condizioni di produzione più o meno ampie nelle quali è eseguito. Di fatto, il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna; si trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria. Come il selvaggio deve lottare con la natura per soddisfare i suoi bisogni, per conservare e per riprodurre la sua vita, così deve fare anche l’uomo civile, e lo deve fare in tutte le forme della società e sotto tutti i possibili modi di produzione. A mano a mano che egli si sviluppa, il regno delle necessità naturali si espande, perché si espandono i suoi bisogni, ma al tempo stesso si espandono le forze produttive che soddisfano questi bisogni. La libertà in questo campo può consistere soltanto in ciò, che l’uomo socializzato, cioè i produttori associati, regolano razionalmente questo loro scambio organico con la natura, lo portano sotto il loro comune controllo, invece di essere da esso dominati come da una forza cieca: che essi eseguono il loro compito con il minor possibile impiego di energia e nelle condizioni più adeguate alla loro natura e più degne di essa. Ma questo rimane sempre un regno della necessità. Al di là di esso comincia lo sviluppo delle capacità umane, che è fine a se stesso, il vero regno della libertà, che tuttavia può fiorire soltanto sulle basi di quel regno della necessità. Condizione fondamentale di tutto ciò è la riduzione della giornata lavorativa». Queste concessioni diffuse nello scritto di Naria sono rilevanti e politicamente significative perché portano a scivolare nel regno delle fantasticherie soggettive, tanto varie quanto sono arbitrarie, sul futuro.
Portano a sostituire stati d’animo e indicazioni soggettive, prodotti di situazioni e influenze e classi antagoniste, alla comprensione dell’antagonismo delle tendenze oggettive. E ciò proprio mentre, al punto in cui è il movimento rivoluzionario italiano e nella situazione sociale che si prospetta da noi e a livello mondiale (rivoluzione e guerra), è attuale la elaborazione di un programma per la transizione dal capitalismo al comunismo, cioè per un periodo in cui il ‘non lavoro’ posto come obiettivo sorge dal lavoro; un programma che ci serva da guida nel lavoro di oggi volto a dare inizio a quel periodo distruggendo lo stato borghese e conquistando il potere politico; un programma che sia frutto non di fantasie e stati d’animo soggettivi, ma della critica al modo di produzione capitalistico e del bilancio dell’esperienza di più di cento anni di rivoluzione proletaria (ormai siamo a 112 anni dalla Comune di Parigi e a 66 anni dalla prima vittoriosa rivoluzione politica del proletariato: la Rivoluzione d’Ottobre). Oggi accettare la critica rivoluzionaria al capitalismo non basta, occorre accettare la tesi della continuazione della lotta di classe dopo la conquista del potere, nella fase della transizione dal capitalismo al comunismo e dei possibili rovesci del proletariato in quel periodo.
Tutto il primo capitolo (pagg. 141-143) dello scritto di Naria è, nel suo contenuto positivo, affermazione della preminenza dei rapporti di produzione sul processo lavorativo immediato. La argomentazione è svolta però confusamente in alcune parti.
Naria mette in luce giustamente che centrale, come soggetto che ha l’iniziativa in campo economico, nella società borghese è sicuramente il capitalista individuale o collettivo e che la centralità dell’‘operaio in quanto produttore’ è una deviazione riduzionistica (cioè di chi riduce i rapporti di produzione al processo lavorativo immediato). Ma sostiene questa tesi con argomentazioni stravaganti.
Nel primo capitolo dice che non c’è nessuna centralità conseguente all’essere lavoratori produttivi di plusvalore, c’è solo disgrazia e miseria. Perché le due cose non andrebbero di pari passo? È invece proprio l’essere produttiva di plusvalore che produce, oltre alla miseria e alla disgrazia della classe operaia, anche la sua centralità nel processo di superamento della società borghese.
La base oggettiva, non voluta né decisa né pensata da nessuno, della centralità della classe operaia sta appunto nell’essere produttrice di plusvalore (e quindi anche misera e disgraziata): è questo che la fa esistere come classe ‘in sé’,(*) da cui storicamente sorge come classe ‘per sé’.(**)
(*) Cioè come assieme di individui distinti dagli altri membri della società, aventi nel movimento generale della società un ruolo comune tra loro nonostante la diversità dei processi lavorativi immediati che svolgono.
(**) Cioè come assieme di individui uniti nel perseguimento di obiettivi politici e sociali (distruzione dello stato borghese, instaurazione della dittatura del proletariato, superamento del modo di produzione capitalista).
È questo che fa del ribaltamento della condizione della classe operaia, che non può essere che opera della classe operaia, la condizione centrale (senza la quale le altre non possono esistere e che non può esistere senza le altre) del superamento della società borghese, del modo di produzione capitalista.
miche ‘pure’ introdotta nel cap. terzo (quarto capoverso) del suo scritto. Ma dove mai esistono leggi economiche pure?
Il Capitale di Carlo Marx non è un trattato di economia politica, ma una ‘critica dell’economia politica’, in cui si dimostra che l’economia politica non è una scienza naturale (cioè un rapporto conoscitivo e di uso degli uomini su una realtà che essi non determinano ma accettano come un dato non modificabile da essi), ma una descrizione mistificata di rapporti alienati tra individui. Dire che la legge del plusvalore non è una legge economica ‘pura’, implica che esistano leggi economiche ‘pure’, cioè che non siano espressione mistificata di rapporti sociali alienati, rapporti tra individui connessi in società dal processo della produzione e della riproduzione delle condizioni materiali della loro propria esistenza Lasciamo questi proclami ai portavoce degli industriali e dei finanzieri che sbandierano le ‘leggi dell’economia’ ogni volta che vogliono fare digerire bocconi amari ai lavoratori!
Lo stesso Naria nel cap. secondo del suo scritto illustra la reificazione dei rapporti sociali e la personificazione dei ruoli sociali facendo piazza pulita di leggi pure o non pure dell’economia.
Da queste argomentazioni emerge che Naria rivendica sì il primato dei rapporti di produzione (come base per l’analisi della divisione della società in classi e dei reciproci rapporti tra le classi), ma ha dei rapporti di produzione la concezione propria dei soggettivisti, per i quali i rapporti di produzione sono direttamente rapporti politici tra le classi; le classi sono individuate, caratterizzate, definite, circoscritte dalla coscienza e dalla soggettività degli individui che le compongono (appartengono alla tal classe quelli che la pensano così e/o si comportano nel tal modo), secondo la nota tesi della ‘composizione politica di classe’ del prof. Negri.
A questa concezione dà fondamento la polemica svolta da Naria nel capitolo terzo del suo scritto contro i sostenitori della legge del valore-lavoro, con argomentazioni che sono una riformulazione delle tesi degli operaisti alla critica delle quali rimandiamo (Atti preparatori al Convegno sulla Repressione, 30-31 maggio 1981, pagg. 5-17).
Sulla base di questa tesi non si può andare lontano e infatti quando Naria cerca di spiegare in qualche modo donde provenga la coscienza, riprende egli stesso le argomentazioni dei riduzionisti. Il capitolo quinto del suo scritto è infatti tutto dedicato a spiegare i rapporti tra individui delle società metropolitane con il processo produttivo immediato (informatica, telematica, robotica, ecc.).
La tresca con le concezioni operaiste (*) emerge nettamente anche nel capitolo sesto dove Naria fa un tentativo inutile di esprimere concetti della critica comunista al capitalismo con categorie antimarxiste, È una concessione alla moda senza vantaggio alcuno e vari danni. Il tutto vuole esprimere la sussunzione reale della società e dei singoli individui nel capitale. Ma lo sforzo di esprimere questa sussunzione con categorie ‘nuove’ porta solo alla confusione.
(*) L’operaismo è una tendenza teorica e politica che in Italia nasce all’inizio degli anni ‘60 esprimendosi successivamente in riviste come Quaderni Rossi, Classe Operaia, Potere Operaio. I suoi esponenti più significativi furono Panzieri, Tronti, Cacciari, Negri. Questa tendenza ha ampiamente influenzato varie organizzazioni politiche (Potere Operaio, Lotta Continua, Autonomia Operaia e vari gruppi minori) ed ha avuto grande seguito nel mondo accademico e culturale. Deriva il suo nome dalla tesi che i partiti politici della classe operaia mistificavano gli interessi degli operai e quindi occorreva contrapporre gli operai in prima persona nei loro interessi e nel loro comportamento immediato, ai partiti che pretendevano di rappresentarli. Il movimento operaista si è fatto forte delle tendenze a combattere la trasformazione del PCI in ‘partito borghese per gli operai’ e la trasformazione delle società socialiste in società socialimperialiste; ma riducendo la classe operaia ‘per sé’ alla classe operaia ‘in sé’, contrapponendosi cioè alla necessità oggettiva della formazione dell’avanguardia organizzata del proletariato, ha deviato e sterilizzato quelle tendenze.
In realtà questa scuola ha revisionato il marxismo con l’occhio dei sociologi americani e ha dato voce teorica e politica all’aristocrazia proletaria dei paesi imperialisti, negando il ruolo rivoluzionario specifico della classe operaia in nome della tesi che nelle società imperialiste tutti siamo proletari.
Per un esame più dettagliato dell’operaismo vedasi lo scritto Toni Negri, ovvero del soggettivismo e del gradualismo in Atti preparatori al Convegno sulla Repressione (Milano 30-31 maggio 1981).
Analogamente, la parte conclusiva del capitolo settimo (quartultimo capoverso) è un’altra concessione al partito dell’aristocrazia del proletariato metropolitano, all’operaismo, che interpretando da miope la condizione dell’aristocrazia proletaria dei paesi imperialisti, si fa interprete del suo lato filoimperialista e servile e parla della società attuale come se in essa fosse già iniziato quello ‘sviluppo delle capacità umane che è fine a sé stesso’, il vero regno della libertà (di cui diceva Marx), e non fosse più quindi il regno della necessità, del bisogno, della miseria e dell’individuo che ha ancora raggiunto il dominio sui propri rapporti sociali.
Una tematica che oggi è fatta propria (proprio mentre scivoliamo verso la guerra e mentre licenziamenti di massa e immiserimento, gravando sulle masse proletarie come maledizioni divine e irresistibili, gridano alla alienazione perdurante e potenziata), da tutti i truffatori borghesi. Stiamo spostandoci dai bisogni sussistenziali a quelli spirituali, ai bisogni di stima, di partecipazione, di felicità, di libertà proclama il sazio ‘compagno’ Rodriguez, che dirige la Casa della Cultura di Milano (PCI). (Repubblica, 7-8 febbraio 1982).
Tematica che è il cemento culturale e ideologico del movimento che il prof. Negri, in accordo con il giudice Sica e il ministro Rognoni, cerca di promuovere in contrapposizione al movimento rivoluzionario del proletariato (v. T. Negri, Noi e l’Europa in Metropoli sett. 1981, T. Negri, Lettera al giudice Sica in Panorama 30 marzo 1981) e a cui aderiscono ‘spontaneamente’ riviste come Metropoli e Lotta Continua per il Comunismo e gran parte del movimento di dissociazione.
Questi signori, con le loro chiacchiere sui ‘nuovi bisogni’ e sui ‘nuovi rapporti umani’, cercano di velare le limitazioni alla soddisfazione dei vecchi bisogni e la costrizione perentoria alle dure necessità dei rapporti di valore e di capitale che i decretoni governativi e l’azione diffusa e quotidiana dei capitalisti impongono alle masse. E soprattutto cercano di spostare le lotte dal campo della eliminazione del rapporto di produzione capitalista per il comunismo, al campo limitato e in definitiva perdente della distribuzione del reddito e della ‘più umana’ o ‘più intelligente’ gestione del capitalismo.
Scrive il prof. Negri: «Nel ’77-’78 in tutta Europa noi abbiamo ormai la maturità delle Bürgeriniziativen, delle lotte antinucleari, e la ripresa della lotta sulla casa. E le stesse lotte operaie, quando riprendono, hanno speranza di riuscita solo se inserite dentro l’unità del proletariato sociale: come insegnano, a vario titolo, le lotte della Lorena del ’77 e le lotte dei minatori e dei dockers in Gran Bretagna.
L’attuale sviluppo delle lotte in Europa, soprattutto da parte delle masse del giovane proletariato, completa ed innova questo processo di indipendenza proletaria. Lo porta, come dicono ormai i compagni tedeschi e svizzeri, ‘oltre il rifiuto del lavoro’ - nel senso che pongono in discussione la totalità del tempo della vita, non solamente l’orario di lavoro, non solamente la giornata lavorativa, ma la maniera nella quale vogliamo vivere e non morire. Le caratteristiche di queste lotte sono quelle di una ricerca di comunità, di alternativa diretta, vissuta e direttamente gestita.» (Metropoli, 6 sett. 1981, pag. 5).
Stessa concessione di Naria all’operaismo si esprime nella tesi ingenua che il comunismo sia la generalizzazione, l’accesso di tutti ‘ai vizi... delle classi dominanti’ (capitolo ottavo).
Il presente ha due facce inscindibili (non puoi sederti a tavola e mangiare senza aver cucinato, se non c’è una cuoca o un cuoco che cucina senza sedersi a tavola: né il problema si risolve dicendo che faremo a turno a ‘sederci a tavola senza aver cucinato’ e ‘cucinare senza sederci a tavola’) ed è ingenuo (o furfantesco) negare una faccia per rivendicarne solo l’altra.
Superando il presente, ambedue le sue facce, nella loro base materiale come pure nelle connesse espressioni culturali e comportamentali, vengono superate. L’operaio che aspira a fare come il suo padrone, non è ancora rivoluzionario, ma operaio arrivista e aspira,te padrone, un illuso egualitarista o il punto di passaggio del cammino con cui l’operaio arriva ad avere coscienza che la società borghese è divisa in classi, che l’eguaglianza formale copre e nasconde una disuguaglianza reale e assoluta.
Proprio quell’individuo che Naria stesso additava alla critica nel primo capitolo del suo scritto, quell’individuo che vuole governare questa società, solo che vuole essere lui a governarla. Ma qui occorre passare all’altro tema fondamentale dello scritto di Naria e della Proposta.
Nel capitolo primo del suo scritto Naria critica appunto la concezione che sinteticamente si esprime come ‘dobbiamo essere noi a dirigere questa società perché siamo noi che produciamo in questa società’; afferma giustamente che invece il problema è distruggere questa società (nella quale, sia detto per inciso, chi è usato a produrre plusvalore ovviamente non può dirigere!); proclama il ‘superamento della politica’.
Qui Naria fa della confusione e dobbiamo esaminare la questione in dettaglio perché essa è uno dei cavalli di battaglia dell’ala non ‘istituzionale’ (cioè che non pone in primo piano la collaborazione diretta con le istituzioni statali) del ‘partito della dissociazione’.
Afferma V. Morucci: «Ma nel movimento italiano a metà degli anni ’70 subentra una frattura, una discontinuità forte. L’orizzonte non è più la ‘presa del potere’, ma l’affermazione diretta di sé come società alternativa. Il potere è visto come una realtà estranea e nemica, dalla quale ci si deve difendere, che non serve né conquistare né abbattere, ma solo ridurre, tenere lontano» (Il Manifesto, 10 nov. 1982).
Quando parliamo di ‘politica’, intendiamo: in primo luogo il complesso delle attività relative allo stato, alla sua esistenza, al suo funzionamento e alla sua riproduzione; in secondo luogo il complesso delle attività di individui, gruppi e classi nei confronti dello stato.
In Italia in questi ultimi anni alcuni pubblicisti hanno fatto un gran parlare di ‘autonomia della politica’ in due accezioni diverse.
La tesi ‘dell’autonomia della politica dall’economia’ è stata portata avanti da M. Tronti e da altri pubblicisti (interni ed esterni al PCI). Questi individui hanno sostenuto che lo stato (borghese), nella società (borghese) attuale, quindi nella società del capitale monopolistico e finanziario, puo dirigere il campo economico e sociale, (quindi la produzione, la circolazione, la distribuzione e il consumo) senza essere vincolato da leggi proprie dei rapporti di produzione dominanti e in concreto dai capitalisti. Quindi sarebbe solo per cattiva volontà, stupidità o malvagità dei politici che lo stato non decreta la piena occupazione, non fissa esso i prezzi delle merci, non stabilisce per decreti cosa produrre e quanto produrre, ecc. ecc.
È una riformulazione della tesi che lo stato è al di sopra delle classi, è ‘libero’ rispetto alle classi in cui è divisa la società. È, nello stesso tempo, un altro modo di affermare che nella società attuale gli individui (nel caso specifico gli individui organizzati in stato) hanno raggiunto la capacità di dirigere consapevolmente e liberamente le loro relazioni sociali e che quindi il rapporto che li lega, il loro legame sociale, non è più la produzione di valori, di merci.
Certamente né ora né mai lo stato si è identificato né genericamente con l’intera società (‘tutto il popolo’), né direttamente con una delle classi in cui si divide la società. Lo stato, in ogni paese e in ogni tempo, è un organismo separato dal resto della società, una istituzione a sé stante caratterizzata dal monopolio della coercizione, dotato di propria personalità, continuità, riproduzione.(*)
(*) Il monopolio della violenza e della coercizione può anche non essere assoluto. In Italia ad esempio lo stato non ha mai avuto il monopolio assoluto della coercizione, la classe dominante non ha mai delegato completamente allo stato questa funzione. Le ragioni di ciò stanno nella storia della formazione dello stato italiano, nelle contraddizioni tra borghesia e proletariato. Lo stato italiano è nato per estensione dello stato sabaudo al resto d’Italia, tra rassegnazione e diffidenza di centri di potere che restarono esclusi dal nuovo stato (la questione romana mantenne ad es. per anni attive in Italia formazioni armate non statali). Gli agrari siciliani non vennero né spazzati via dalla borghesia italiana né integrati completamente nei nuovi ordinamenti, quindi mantennero loro proprie organizzazioni di coercizione (la mafia). Talune prassi repressive che la classe dominante o frazioni di essa ritenevano necessarie per mantenere la sottomissione degli operai e dei contadini non erano per varie ragioni integrabili ufficialmente nelle istituzioni dello stato, stante la diversità della situazione sociale delle varie parti del paese, la debole egemonia della borghesia e le beghe interborghesi. Per cui vissero e vivono come prassi non ufficiali, tollerate, incoraggiate o represso dallo stato a seconda dei tempi (bande fasciste, mazzieri pugliesi, mafiosi, polizie private). Attualmente in Italia vi sono centinaia di migliaia di poliziotti privati, guardie giurate, gorilla, elementi di organizzazioni paramilitari e di spionaggio non inquadrati nei corpi armati dello stato, ma neanche in lotta con essi. La mancanza di monopolio assoluto della coercizione da parte dello stato non è un fatto specifico della società italiana, ma un fatto abbastanza diffuso legato ai concreti rapporti sociali nelle società.
Ma lo stato che domina un paese non può che esprimere e imporre i rapporti di produzione dominanti e quindi essere espressione della classe economicamente dominante. E assurdo pensare che uno stato possa fare un’azione continua e duratura in contrasto con gli interessi di tutta la classe economicamente dominante lasciandola tale e quindi contro i rapporti di produzione dominanti. Non esiste in questo senso, autonomia del politico dall’economico.
Questo non solo perché lo stato esistente è formato nei suoi quadri dirigenti da individui legati materialmente o addirittura appartenenti alla classe economicamente dominante e nella folla dei suoi agenti da individui reclutati, selezionati ed educati a servire i rapporti di produzione dominanti; ma anche perché lo stato, essendo una istituzione a se stante, dipende per la sua esistenza materiale dall’appoggio della classe economicamente dominante la cui ostilità generalizzata e il cui boicottaggio lo schiaccerebbe.
Uno stato deve mantenere la folla dei suoi agenti e consuma una gran quantità di prodotti che vengono anch’essi prodotti nell’ambito dei rapporti di produzione dominanti e acquisiti dallo stato conformemente a questi rapporti. Nella società borghese lo stato compera anch’esso la stragrande maggioranza dei beni che usa per le sue attività e compera in competizione con gli altri acquirenti gran parte delle capacità lavorative di cui si serve. Non può fare né l’una né l’altra cosa in contrasto con i rapporti di produzione dominanti.
Non solo, ma la classe economicamente dominante detiene l’iniziativa delle attività economiche e possiede i mezzi di produzione e i beni di consumo. Un antagonismo tra stato e classe economicamente dominante da una parte porta alla paralisi delle attività economiche e quindi al malessere e al risentimento di tutta la popolazione che si trova rapidamente priva di beni di consumo, dall’altra parte trova la classe economicamente dominante in condizione di assoldare quanti uomini voglia (dato che la capacità lavorativa umana è universalmente in vendita) contro lo stato che le è ostile, e di assoldare in proprio lo stesso personale mercenario assoldato dallo stato.
Quindi non solo è illusorio e avventurista cercare di usare contro le classi sfruttatrici uno stato da esse costruito (come dimostrano abbondanti esempi storici dalla Spagna del ‘36, al Cile del ‘73, al Portogallo del ‘75, ai vari colpi di stato di ‘militari di sinistra’ in ogni paese dove lo stato era in una qualche misura un organismo consolidato), ma è anche illusorio cercare di far convivere uno stato proletario con rapporti di produzione capitalisti.
Questa è la ragione per cui nessuna rivoluzione politica proletaria si è mai potuta fermare, fin dai suoi primi movimenti, pena la sua rapida sconfitta, al campo politico ma ha dovuto procedere immediatamente (e spesso contro i propositi iniziali e di malavoglia e come trascinata dalla forza delle cose e degli eventi) almeno all’esproprio della classe economicamente dominante: a toglierle il monopolio dell’iniziativa economica, dei mezzi di produzione e dei beni di consumo.
Così avvenne nell’ottobre del 1917, come in ogni rivoluzione successiva: anche i tentativi di economia lista durarono ben poco salvo in una certa misura in Cina, dove il nuovo stato ottenne la collaborazione della borghesia nazionale in misura consistente grazie al carattere antimperialista della rivoluzione e grazie a concessioni tali da portare Mao ad affermare nel 1970 che dopo 21 anni di potere socialista, la condizione degli operai cinesi non è cambiata un granché.
Nei contrasti che dividono la classe economicamente dominante in gruppi e in singoli individui, lo stato può sostenere un gruppo o un individuo contro l’altro oppure fare da mediatore più o meno neutrale del contrasto (ad es. in Italia, dopo l’unità, lo stato appoggiò i gruppi industriali del Nord a danno degli agrari meridionali nella politica doganale, commerciale e fiscale). Questo crea la parvenza di una autonomia dello stato dai rapporti di produzione dominanti. Quando lo stato con la sua azione modifica o elimina un dato aspetto della società borghese, del suo movimento economico, è facile per i salvatori del capitalismo gridare che lo stato può modificare con la sua azione ogni aspetto della società borghese. In realtà lo stato non fa che inserirsi nel contrasto tra aspetti della società borghese a vantaggio di alcuni contro altri.
Ciò era vero nel periodo del ‘dominio formale’ del capitalismo nella società, cioè quando il capitalista si limitava a usare la società come era, come la ereditava. E anche lo stato era dal capitalismo usato come una delle istituzioni trovate (quindi per mantenere ‘l’ordine pubblico’ e proteggere con dogane e trattati commerciali dati traffici borghesi in cambio di prestiti alle casse dell’erario, di contributi, di ‘aperture’ ai membri importanti dello stato).
Ciò resta vero nel periodo attuale del ‘dominio reale’ del capitale, cioè quando il capitale ha modificato e modifica ‘a sua immagine’ la società intera. In questa fase lo stato diventa non solo un partner commerciale e un esecutore (per l’ordine pubblico, le tariffe doganali e il fisco) del capitale, ma un membro attivo del movimento economico vero e proprio (politica monetaria, politica fiscale e doganale, moneta fiduciaria, politica economica, settore pubblico dell’economia, ecc.).
Ma sia essere un alleato della banda di briganti sia essere uno dei briganti, non dà allo stato alcuna posizione di dominatore arbitrario dei briganti.
Sostenere la possibilità dello stato di modificare pacificamente, con mezzi ‘normali’, i rapporti di produzione esistenti (cioè sostenere l’autonomia del politico dall’economico) equivale a ignorare o nascondere l’abc dell’economia. Chi percorre questa strada è favorito in ciò dal fatto che la natura dello stato, come la natura delle relazioni finanziarie, è per un certo aspetto di difficile comprensione per le masse perché non rientra nella loro esperienza diretta (a differenza delle relazioni relative al processo lavorativo diretto e ad altri aspetti dei rapporti di produzione e sovrastrutturali); di conseguenza la concezione dello stato diffusa tra le masse è più facilmente e ampiamente influenzata dalla immagine apologetica che ne dà la borghesia (lo stato siamo tutti noi, lo stato come volontà comune, lo stato come risultato di un patto tra i membri della società, il governo lo eleggiamo noi, lo stato sovrintende al soddisfacimento dei bisogni collettivi e le altre panzane di cui sono pieni manuali scolastici e testi universitari).
Sostenere la capacità dello stato, come di qualsiasi altra istituzione, di dirigere l’economia della società borghese è un’altra versione della tesi apologetica borghese assai diffusa negli anni ‘60 delle eliminazione delle crisi economiche capitalistiche grazie all’intervento statale e pubblico nell’economia.
Secondo questi miserabili apologeti del capitale, i capitalisti e i loro organi associativi potrebbero dirigere consapevolmente e unitariamente la vita economica (la produzione, la distribuzione, la circolazione, il consumo, la riproduzione) della società secondo un piano armonico. In realtà la società borghese, anche la società borghese ha raggiunto il grado più alto di concentrazione, è fondata sul rapporto di valore (produzione per vendere) e sul rapporto di capitale (compravendita delle capacità lavorative) e quindi si sviluppa secondo leggi proprie (oggettive) non governabili da nessuno, la cui azione può essere ritardata e ostacolata ma non impedita da alcuna azione soggettive, salvo rovesciare l’intera società borghese.
La cronaca di questi giorni ha fatto impietosamente giustizia di ogni tesi contraria. Il singolo capitalista o un’associazione di capitalisti o lo stato che pone a disposizione il suo potere coercitivo diretto, possono anche illudersi in certi momenti di determinare il corso degli eventi, ma continuamente la situazione ‘scappa loro di mano’ e gli eventi si svolgono per conto loro, senza più possibilità di direzione o controllo, come mossi da una forza misteriosa e onnipotente: perché i capitalisti non possono rapportarsi tra di loro e con le altre classi che come venditori e compratori, con l’imperativo assoluto della valorizzazione del capitale. E meno questa può procedere, più i rapporti diventano conflittuali e ogni ‘concertazione’ impossibile.
Una delle grandi mistificazioni culturali di questo secolo è la credenza diffusa che le politiche economiche ispirate o teorizzate da Keynes (l’intervento dello stato a creare domanda di merci elargendo redditi, a spendere prendendo a prestito o creando danaro) abbiano risolto la prima crisi del modo di produzione capitalista per sovrapproduzione assoluta di capitale, iniziata con questo secolo.
In realtà quella prima crisi universale fu ‘risolta’ dalle distruzioni di beni materiali e di uomini e dagli sconvolgimenti politici e sociali delle due prime guerre mondiali. I redditi aggiuntivi e le spese aggiuntive create dagli stati negli anni tra il 1920 e il 1930 si rivelarono ovunque impotenti a creare nuove condizioni confacenti alla produzione di una maggiore quantità di plusvalore e quindi al rilancio del modo di produzione capitalista.
L’aumento di domanda non risolveva la crisi dato che il calo della domanda era anch’esso un effetto e non la causa della crisi. Ciò servì al più a limitare gli effetti catastrofici della crisi e a prevenirne le conseguenze politiche. Aumentare la spesa pubblica, limitare la disoccupazione creando impieghi nella pubblica amministrazione, distribuire sussidi di disoccupazione e altre previdenze pubbliche limitavano la caduta del consumo ed erano utili ai fini dell’ordine pubblico, ma non eliminavano la causa che aveva tolto slancio agli investimenti di capitale, non rimettevano in moto la macchina del modo di produzione capitalista.
Nella società borghese sono state create un gran numero di istituzioni (Fondo Monetario Internazionale, Accordo di Bretton Woods, banche centrali, banche internazionali, sistemi di mutua garanzia finanziaria, accordi commerciali, borse merci e borse valuta, accordi di monopolio, politiche economiche statali, istituti previdenziali, ecc.) tese a frenare, ridurre, contenere le tendenze distruttive insite nel modo di produzione capitalista, le manifestazioni estreme del contrasto insanabile che sorge ad un certo punto tra produzione e riproduzione delle condizioni materiali dell’esistenza da un lato e rapporti di produzione capitalisti dall’altro. Ma frenare, contenere non significa eliminare. L’azione di queste istituzioni è fondamentale per capire le forme e i tempi del manifestarsi di queste tendenze distruttive; non ha alcuna incidenza sull’esistenza e sul manifestarsi delle stesse tendenze.
La teoria del ‘capitalismo organizzato’ presenta l’imperialismo come un capitalismo particolare, trasformato, in cui sarebbero stati eliminati la concorrenza, l’anarchia della produzione e le crisi economiche, e si realizzerebbe lo sviluppo pianificato dell’economia nazionale. Tale teoria è tutt’altro che moderna. Fu avanzata da ideologi del capitalismo monopolistico come Sombart, Liefman e altri e ripresa da Kautsky, Hilferding e altri teorici della II Internazionale.
Ancora nel 1914, alla vigilia della I Guerra Mondiale, il prof. Schulze-Gaevernitz sentenziava a proposito della società tedesca: ‘si riduce il campo delle leggi economiche, operanti automaticamente, e si amplia in modo straordinario quello della regolamentazione cosciente per opera delle banche’ (citato da Lenin, L’imperialismo, fase suprema del capitalismo). È la base teorica delle attuali economie ‘pianificate’ dell’URSS e di altri paesi, come si vedrà meglio più avanti.
L’impossibilità di una ‘pianificazione’ del capitalismo oltre che la dimostrazione, definitiva e conclusiva, della pratica ha avuto anche la dimostrazione teorica come impossibilità di conciliare nella pratica della società borghese (in condizioni di riproduzione allargata e di aumento della produttività del lavoro) contemporaneamente un ricambio equilibrato si in termini di valore d’uso, sia in termini di valore di scambio, ricambio equilibrato che è possibile solo in condizioni determinate e limitate. Per una trattazione sull’argomento v. R. Rosdolsky, Genesi e struttura del Capitale di Marx, ed. Laterza 1975, pagg. 513-579 sugli schemi della riproduzione allargata illustrati da Marx nel 2° libro del Capitale.
Sulla questione del movimento economico della società borghese resta tuttora valido e fondamentale quanto illustrato da Lenin in L’imperialismo, fase suprema del capitalismo.
La critica di ‘autonomia della politica dal sociale’ viene regolarmente rivolta da movimentisti e gradualisti ai fautori della organizzazione d’avanguardia, del partito del proletariato rivoluzionario. Come se attrezzandosi per la lotta politica e lottando in campo politico (cioè per la distruzione dello stato borghese e la costruzione dello stato del proletariato), quindi perseguendo una delle condizioni preliminari, indispensabili per la trasformazione dei rapporti di produzione, si separassero, ignorassero, trascurassero i compiti sociali della rivoluzione proletaria: il rivoluzionamento dei rapporti di produzione e della sovrastruttura.
Parlare di fine della politica, di superamento della politica vuol dire, a meno di usarla come ‘frase ad effetto’ o espressione di pii desideri, sostenere che la lotta per la distruzione dello stato borghese e la costruzione dello stato della dittatura del proletariato ha perso di importanza e/o che la attività politica non si pone più come attività particolare tra le varie attività umana, come funzione sociale distinta dalle altre, come ruolo svolto da un gruppo particolare di individui: in sintesi il superamento dello stato in generale, del partito e delle organizzazioni di massa.
Che questo sia un obiettivo della rivoluzione proletaria e contenuto caratterizzante della società comunista è una tesi dei marxisti-leninisti che deriva dalla comprensione dei rapporti sociali attuali nella loro connessione e nella loro dinamica. Ma il punto di contrasto tra marxisti-leninisti da una parte e operaisti e anarchici dall’altra è se oggi ciò è già possibile (nel senso che l’avanguardia non deve organizzarsi come corpo separato) e/o se basta una rivoluzione politica (l’abbattimento dell’attuale stato borghese) per eliminare lo stato in generale.
Noi oggi viviamo entro determinati rapporti sociali, il cui nucleo determinante sono ancora i rapporti di produzione (perché la disponibilità dei mezzi per la normale riproduzione della vita non è un fatto normalmente scontato).
Questi rapporti sociali, vissuti da tutti, sono difesi da da alcuni (la borghesia e il suo stato) e combattuti da altri. Operaisti e anarchici presuppongono che basta togliere di mezzo i difensori dei rapporti sociali borghesi perché gli uomini cessino di avere tra loro rapporti borghesi. Alcuni riformulatori dell’anarchismo in chiave riformista (Negri, Morucci, Piperno, ecc.) affermano addirittura che non occorre togliere di mezzo lo stato borghese, ma ‘basta starne alla larga’ o ‘tenerlo alla larga’ e che la questione si risolve con l’adozione di certi comportamenti individuali. In realtà togliere di mezzo i difensori dei rapporti di produzione borghesi è il primo passo necessario, compiuto il quale resta il compito di modificare i rapporti sociali vissuti da tutti gli uomini, rapporti che non cessano di essere borghesi spontaneamente, solo perché ci si è sbarazzati dei loro difensori. Infatti non sono rapporti imposti a ogni individuo solo e neanche principalmente con la coercizione militare. Il rapporto capitalistico è un meccanismo sociale secondo cui si muove la vita di ognuno di noi, che ha formato secondo le sue esigenze la nostra natura. Abbiamo bisogno di sfuggire a questo meccanismo che ci costringe in un ciclo ferreo di costruzione e distruzione, ma nello stesso tempo è secondo questo meccanismo che noi siamo abituati a vivere, che gestiamo la nostra vita: è un vestito che ci soffoca, ma anche l’unico di cui milioni di uomini sono abituati a vestirsi.
Il socialismo non è solo un nuovo stato, ma la trasformazione dei rapporti che gli individui hanno gli uni con gli altri (nella produzione delle condizioni della loro vita materiale e nel resto). Quindi il socialismo non lo si può instaurare né mantenere in vita per decreto o con colpi di mano. Non è neanche un nuovo ordinamento legislativo, statale, economico-sociale, ecc. che si possa instaurare da qualcuno sopra le masse; non è insomma un ordinamento istituzionale (anche se ogni rapporto sociale si traduce necessariamente in istituzioni).
Lo stato, i decreti, le istituzioni possono non ostacolare e anzi favorire l’inizio e lo sviluppo del socialismo, ma non possono farlo esistere. Il socialismo è un movimento di milioni di uomini, di tutta la società per modificare i rapporti esistenti (e quindi modificarsi).
D’altra parte lo stato borghese e le sue diramazioni impediscono questo movimento, lo soffocano e reprimono. Quindi occorre abbattere lo stato borghese. Chi nega questo, nega la premessa di tutto. Gli attuali rapporti non si reggono perché gli individui sono indifferenti alla loro modificazione, ma perché i tentativi, le iniziative per modificarli sono repressi sul nascere dallo stato e dagli altri cani da guardia del capitalismo e quindi non possono consolidarsi, generalizzarsi, svilupparsi. Ci occorrerà ancora uno stato perché la modificazione dei rapporti sociali non può essere condotta su piccola scala e quindi occorre imporla alla minoranza che o vi si oppone o vuole restarne estranea, indifferente. In un certo senso siamo in una situazione di unità sociale tale che un individuo non può cambiarsi oltre un certo limite se non cambiano tutti, perché non può cambiarsi oltre un certo limite se non cambiano le condizioni materiali della sua esistenza e queste sono indissolubilmente connesse alle condizioni materiali prevalenti socialmente. È per questo che tutti i propositi di rivoluzione culturale che non mettono alla base di tutto la trasformazione dei rapporti di produzione finiscono inevitabilmente in farneticazioni e sogni.
Sfidiamo chiunque a sostenere che l’attività politica si pone già attualmente, tra le classi oppresse, come attività comune, diffusa, ‘di tutti’ e che quindi si può parlare concretamente di fine della politica (e dello stato) come risultato immediato di un rivolgimento rivoluzionario.
Come si vede da quanto detto, operaisti e anarchici, quando non negano il bisogno di una rivoluzione politica, negano tuttavia la continuazione della divisione in classi e della lotta di classe anche dopo la rivoluzione politica.
La dimostrazione della necessità del partito, delle organizzazioni di massa, dello stato (intesi come organizzazioni di individui distinti dal resto della società per i vincoli che li legano tra loro, per la coscienza dei compiti da svolgere, per le funzioni sociali che svolgono e per i mezzi a ciò adeguati di cui dispongono e dotate di propri meccanismi di autoconservazione e di riproduzione) sta nello stesso movimento rivoluzionario e più in generale di massa.
Ogniqualvolta e dovunque una sua parte vuole essere qualcosa di più di un fremito transitorio e senza risultati, essa si dà una organizzazione, crea al suo interno organismi che riflettono (e in misura maggiore o minore cristallizzano - questo è l’aspetto negativo della cosa) i differenti livelli di sviluppo della coscienza, dell’impegno e dello slancio nella lotta. Questo avviene al di là e a volte contro la coscienza e la volontà diffusa del movimento stesso: in questo caso si hanno organismi informali, leader e leaderini; un sistema la cui differenza, rispetto a quello formato nella diffusa coscienza della necessità della cosa, sta nella irresponsabilità e maggiore delega (di fatto) che ne risulta, nella minor efficacia e nel minor movimento di crescita sociale generale che esso mette in moto, nella minor resistenza che presenta nel periodo del ‘riflusso’. Ma quello che qui ci interessa è 1) aver mostrato che una struttura differenziata di organismi e di funzioni si crea comunque, 2) prendere coscienza della necessità del fatto che nasce dallo stato presente della situazione sociale, dei suoi compiti positivi, dei suoi aspetti negativi e della sua transitorietà.
Solo questo ci permette di prendere misure concrete per limitare lo sviluppo e la prevalenza degli aspetti negativi della cosa e per arrivare al suo superamento (come ad es. eleggibilità e revocabilità dei funzionari, loro trattamento economico in relazione alle condizioni degli operai, sviluppo culturale di massa, partecipazione di massa a compiti originariamente svolti da funzionari, verifica di massa dei funzionari, partecipazione dei funzionari al lavoro produttivo e tutte le altre misure concrete tese a combattere la divisione funzionari-masse).
Si tratta della stessa necessità per cui si impone, al di là dei desideri e delle inclinazioni dei singoli, anche nelle nostre file la divisione del lavoro e l’asservimento degli individui alla divisione del lavoro. Anche la più semplice attività rivoluzionaria, come ad es. fare un giornale appena degno di questo nome, comporta attualmente che alcuni di noi smettano di lavorare in fabbrica per otto ore al giorno e possano organizzare il tempo della loro vita in funzione di questa attività. E ciò non per questioni legate alla volontà e alla coscienza degli individui che si dedicano alle attività rivoluzionarie, né alla ‘perversione’ e alla ‘sete di potere’ di alcuni di essi che semmai trova in questo soltanto il terreno per esistere e dispiegarsi, né alle ‘abitudini contratte nel lavoro cospirativo’, ma per la semplice ragione che nella società borghese gli operai in generale non possono e ‘non devono’ fare giornali. Per quanto lo sviluppo culturale di massa, una certa limitazione del tempo di lavoro e l’uso di alcune situazioni (cassaintegrazione, assenteismo, ecc.) permettano che alcuni operai dei paesi imperialisti sfuggano grazie al particolare slancio personale, almeno in parte a queste limitazioni, questa resta la condizione normale per il proletariato.
Nella pratica del nostro lavoro di ogni giorno, al di là delle chiacchiere ingenue o furfantesche sul ‘siamo tutti uguali’ (che è una cosa seria solo per chi lo pone come obiettivo da raggiungere e lotta per raggiungerlo), lo constatiamo continuamente.
Vogliamo fare un giornale, mettere in piedi un’attività, ecc.: occorrono funzionari. Perché? Perché data l’estensione dell’impegno produttivo dei compagni (per vivere, per guadagnare), essi non possono fare da soli il giornale. Fare giornali, studiare, fare attività politica non rientra nelle attività correnti del lavoratore normale, quindi occorrono funzionari.
In effetti alcuni operai hanno potuto svolgere un vasto lavoro rivoluzionario, acquisire una grande esperienza rivoluzionaria, dare un grande contributo di energie e di direzione al lavoro rivoluzionario, solo quando l’organizzazione rivoluzionaria ha creato un proprio corpo di funzionari.
Questo da una parte ha consentito anche a degli operai di dedicare le loro energie alla causa togliendo il monopolio dell’attività politica a quei ceti che già l’ordinamento della società borghese mette in condizione di disporre di cultura, di tempo e di mezzi (contro i vecchi partiti socialisti il cui corpo dirigente era composto di maestri, avvocati, ecc.); dall’altra ha consentito un più intenso legame pratico e ideologico tra l’organizzazione rivoluzionaria e gli operai in produzione e una maggiore attività politica anche di questi ultimi. La non partecipazione di alcuni (funzionari) al lavoro produttivo è la condizione necessaria perché anche i compagni che sono in produzione possano fare efficacemente attività di studio e attività politica.
Finché non sarà diventato ‘normale’ che ogni individuo che fa lavoro produttivo (nel senso di rivolto alla produzione delle condizioni materiali dell’esistenza) compia anche attività politiche, culturali, artistiche, creative (e di converso sarà diventato ‘normale’ che ogni individuo faccia attività produttiva), è inevitabile che l’espletamento di tali attività si ponga come una ‘professione’ accanto alle altre proprie del lavoro produttivo (nel senso detto), che siano esercitate da individui diversi specificamente asserviti a una di queste professioni.(*)
(*) È altamente utile in questa fase ristudiare i profondi insegnamenti di Lenin in L’estremismo malattia infantile del comunismo. In questi anni molti compagni hanno accettato l’idea che essere comunisti volesse dire comportarsi in un dato modo, anziché comportarsi in ogni circostanza nella maniera più consona, in quella circostanza, per contribuire più efficacemente alla lotta collettiva per il comunismo. Così c’era un modo di vestire ‘da compagno’, un modo di parlare ‘da compagno’, ecc. Una pseudoproletarizzazione esteriore che in molti casi contrastava con le esigenze del lavoro reale.
Ma la normalità della società del lavoro salariato, della condizione operaia nella società borghese, anche la più evoluta e civile che sia comparsa sulla faccia della terra, non è certo quella. I sognatori e i furfanti che dicono che nel lavoro rivoluzionario ‘non ci deve essere divisione del lavoro’ sottintendono che dipenda dalla nostra testa, dalle nostre idee più o meno evolute il fatto che ci sia o no la divisione del lavoro e asservimento degli individui alla divisione del lavoro; che ciò sia dovuto solo alla nostra ignoranza (come si vede siamo in pieno idealismo illuministico, come se l’esistenza o meno in massa di dati comportamenti dipendesse dal possesso di date conoscenze o idee, mentre in realtà anche proprio il possesso in massa di date conoscenze o idee è condizionato in primo luogo dalle condizioni materiali in cui le masse vivono).
Lo staccarsi di alcuni dalla condizione del lavoro salariato, riuscire a staccare almeno alcuni individui da quella condizione perché si dedichino interamente al lavoro rivoluzionario è la condizione necessaria perché un numero ben più grande di individui che ancora restano direttamente, nella loro vita quotidiana, sottomessi alle condizioni di schiavi salariati riescano a svolgere una qualche, più o meno ampia, attività politica. Se qualcuno organizza una manifestazione, molti più usufruiranno delle possibilità di esercizio di attività politiche che lo svolgimento della manifestazione comporta.
Se qualcuno pubblica un giornale, molti di più lo diffonderanno, un numero ancora maggiore lo leggerà e uno ancora maggiore si coinvolgerà nella discussione, comprensione e verifica delle tesi propugnate dal giornale.
I movimentisti obiettano: «ma se non ci sono i manifestanti, se non ci sono i diffusori, se non ci sono i lettori? Questo è quello che conta!»
E qui scoprono la loro coda di paglia! Perché noi siamo in un’epoca rivoluzionaria, della decadenza del capitalismo e delle rivoluzioni proletarie (il ché non vuol dire che ogni giorno è all’ordine del giorno la rivoluzione, ma non è neppure una ‘frase ideologica’ salvo che per quelli che non ne capiscono il significato concreto). Ciò non è dubbio a nessuno, salvo all’intellettuale isolato nel suo giro di intellettuali passivi ed egocentrici: né al borghese che sente di essere seduto su un barile di polvere, né al proletario rivoluzionario. Il compito di noi rivoluzionari non è ‘creare le potenzialità rivoluzionarie’, che sarebbe una velleità donchisciottesca e stupida. Ma lavorare per permettere a queste potenzialità (esistenti) di affermarsi e realizzarsi: non è creare i potenziali lettori che esistono, ma farli diventare effettivi lettori stampando il giornale, per così dire!
In realtà i movimentisti rivelano la natura borghese delle loro concezioni, salvo lanciarsi in frasi vuote tipo ‘tutti devono fare il giornale’! Come se i rapporti sociali attuali fossero tali da aver reso pratica e capacità comune, diffusa, di tutti, il ‘fare giornali’!!
Da quando il capitalismo ha creato le premesse (come grado di sviluppo delle forze produttive) del suo superamento (del comunismo), la trasformazione non attuata comporta la creazione di una quantità di tentativi di ridurre a unità armonica le tendenze contraddittorie della società borghese che contraddittorie restano e che solo perché restano contraddittorie (con tutti gli effetti distruttivi che ne conseguono) permettono la vita della società borghese. Così ad esempio i maggiori produttori di auto (dieci o quindici gruppi che producono tutte le auto del mondo) si accordano su una data divisione del mercato e sui prezzi; ciò per porre fine a una concorrenza che oggi distrugge uno e domani distruggerà un altro.
Chi è in difficoltà invoca l’accordo. Ma l’accordo non elimina la conflittualità degli interessi. L’accordo mantiene in vita chi era in difficoltà, ma non elimina le difficoltà stesse.
I fattori che rendevano alcuni produttori più forti di altri non vengono messi in comune. Anzi ognuno dei partners dell accordo cerca di costituire per sé condizioni di maggiore forza rispetto agli altri. Prima o poi chi è diventato molto più forte degli altri reputerà di avere più da guadagnare rompendo l’accordo di quanto rischi dalla rottura. E romperà. D’altra parte se non rompesse, verrebbero meno alcuni motivi di accrescere la sua forza e anche alcune possibilità (l'aumento della scala della produzione) di accrescere questa forza.
Riassumendo, quando il modo di produzione capitalista diventa maturo (per la transizione al comunismo) si formano al suo interno quelle che Marx chiamò ‘forme antitetiche dell’unità sociale’, (v. Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, ed. Einaudi pagg. 90-93), tentativi di superare l’antagonismo proprio del rapporto di valore, restando nell’ambito del rapporto di valore, tentativi di dirigere il movimento economico della società eliminando le conseguenze più distruttive del rapporto di valore e di capitale restando nell’ambito di questi rapporti.
Gli operaisti camuffano questa realtà della società borghese, la abbelliscono giocando alla confusione di due cose che all’osservatore, al fotografo che non ne capisce la natura, possono sembrare eguali, ma che per chi vi partecipa e per chi le studia nel loro movimento, nella loro origine e nelle potenzialità che via via rendono esistenti (cioè dialetticamente) sono antitetiche. L’esigenza di portare all’esistenza la reale unità sociale (*) si riflette sia nelle pratiche capitaliste della fase imperialista (nazismo, fascismo, New Deal, Stato del benessere e del controllo di massa, ‘socialismo reale’, ecc.), sia nelle pratiche della transizione dal capitalismo al comunismo (fase socialista).(**)
(*) Per ‘reale unità sociale’ si intende la condizione già raggiunta di individui che dipendono l’uno dall’altro per la produzione e la riproduzione delle condizioni materiali della esistenza. Questa condizione è stata creata dal capitalismo: essa non era mai esistita prima a livello mondiale. Essa esplica i suoi effetti nella società borghese, anche se i suoi membri non la assumono come punto di partenza della loro attività. Da qui la contraddizione tra questa condizione e le pratiche correnti nella società borghese e i riaggiustamenti catastrofici che ne derivano. Portare all’esistenza la reale unità sociale, significa assumerla come punto di partenza, come premessa per tutta l’attività degli individui; che ogni individuo regoli su questa base la sua attività. Per maggiori chiarimenti su questo argomento v. pag. 75.
(**) Qui e in tutto il testo quando parliamo di socialismo non intendiamo niente che abbia a che fare con Craxi o con Breznev, con Schmidt, Mitterrand o Andropov; intendiamo la fase storica di transizione dal capitalismo al comunismo, la fase in cui gli uomini si liberano gradualmente dai rapporti sociali borghesi e si costruiscono tra loro rap porti comunisti.
Nelle prime come sottomissione di tutto il movimento economico della società borghese (produzione, distribuzione, realizzazione, consumo) alla ‘comunità dei capitalisti’ che alcuni capitalisti cercano di fare esistere, scontrandosi con la ineliminabilità della divisione del capitale in parti contrapposte, divisione all’interno del paese e a livello mondiale; come sottomissione gerarchica e amministrativa oltre che economica del resto della popolazione (e anzitutto degli operai) al capitale. Con le implicazioni che ciò comporta e le conseguenze che ne derivano: ad es. una linea di massa e una politica operaia (dei borghesi sugli operai): mentre ogni singolo capitalista abbandona al suo destino l’operaio che non gli serve e carpisce con un salario più elevato all’altro capitalista l'opera di cui ha bisogno, la cosa cambia quando è la comunità dei capitalisti che cerca di sottomettere a sé il movimento economico della società regolandolo, razionalizzandolo,(*) smussandone gli spigoli più catastrofici: donde le politiche di collocamento della manodopera, le misure ‘sociali’ dei regimi, i ministeri del lavoro e i sindacati di regime.
(*) L’espressione ‘direzione razionalizzata’ è solo una frase il cui contenuto si esprime meglio con ‘attività produttiva intensificata’.
Nelle seconde come sottomissione di tutto il movimento economico della società alla comunità dei lavoratori che si viene formando (perché nella società borghese sono poste alcune premesse delle comunità dei lavoratori, rafforzate dalla lotta rivoluzionaria che apre il periodo della transizione, ma non si è formata ancora la comunità dei lavoratori), della quale entra progressivamente a far parte l’intera popolazione.
Nelle prime la reale unità sociale si esprime negativamente: come bisogno di reprimere e soffocare le manifestazioni più contraddittorie e distruttive dei rapporti borghesi, come sottomissione gerarchica e di dominio di alcuni produttori e venditori di merci su altri; quindi contraddittoriamente, come regressione a forme politiche e cultuali precapitalistiche (regolamentazioni amministrative) e perdita di dinamica del capitale che nel contrasto tra le sue parti è dinamico, mentre più si impedisce a questi contrasti di dispiegarsi (regolamentazioni, accordi, norme: ciò insomma che Reagan dice di voler abolire!) più perde slancio a crescere, mentre i contrasti anziché esprimersi giorno per giorno in tante e contrastanti lotte, esplodono di tanto in tanto in crisi catastrofiche e guerre.
Nelle seconde tale unità sociale si esprime positivamente come spinta alla trasformazione della società attuale, alla soppressione della divisione in classi, alla instaurazione di una unità nazionale e mondiale, in cui la spinta allo sviluppo della produttività del lavoro è la riduzione del tempo di lavoro. (Produttività che ha senso umano proprio se si delimita il lavoro, separandolo dal resto della attività degli uomini: ha senso trovare un modo per costruire una abitazione in 30 ore di lavoro anziché in 300. Non ha senso la ricerca di un modo per scrivere una poesia, pensare un concetto, fare una passeggiata, fare una carezza, conversare con un amico, creare un’opera d’arte, gustare una musica, ecc. in 30 minuti anziché in 300!).
Ora in questo premere della reale unità sociale per venire alla esistenza che si manifesta sia nella società imperialista che nella società in transizione dal capitalismo al comunismo, si danno forme e apparenze esteriormente eguali, se considerate nell’istante. Come due frutti, entrambi finiti sotto terra a marcire uno dando origine a un germoglio e uno semplicemente marcendo: per tutto un tratto possono sembrare eguali all’osservatore distratto (e possono anche trasformarsi l’uno nell’altro); ma chi ammirerà la nuova pianta che ormai germoglia, avrà chiara la differenza che c’era tra i due.
Una società imperialista e una società in transizione dal capitalismo al comunismo vivono due processi diversi (da un lato il capitalismo che marcisce, dall’altro il superamento del capitalismo), ma molte cose vi compaiono uguali per l’osservatore (qui è la base per i facili trucchi di propagandisti borghesi, del tipo comunismo = nazismo = totalitarismo).
Tutte le chiacchiere degli operaisti sulla maturità del comunismo, sul ‘socialismo ormai consumato nella società imperialista’ non sono altro che questo prendere una cosa per l’altra e trovano la ragione della loro fortuna accademica nella facilità del prendere una cosa per l’altra e nell’opportunismo pratico che giustificano.
L’estinzione dello stato è un obiettivo e una linea che si concretizza via via in fatti, pratiche ed istituzioni. Quando compiti, e relativi strumenti, che inizialmente sono esercitati da corpi ristretti di individui, diventano compiti di masse via via più ampie, essi cambiano di natura e diventano via via meno ‘di stato’: la amministrazione della giustizia, la repressione, ecc.
Con la estinzione dei suoi compiti repressivi si estingue lo stato. Molte delle chiacchiere sulla ‘fine della politica’ nascono semplicemente e banalmente dalla ignoranza del ruolo dello stato (conoscenza che non fa parte del bagaglio culturale diffuso nella società borghese, perché la classe dominante ha tutto l’interesse a mascherarlo, confonderlo e abbellirlo finché se ne parla e scrive, salvo esplicarlo in tuta la sua spietata efficacia nella pratica).
Lo stato è un organismo che ha come compito la repressione e la coercizione; è un gruppo di individui organizzati, distinto dal resto della società, che ha il compito di imporre e reprimere. È quel ragno (di cui parla Gorki in Le mie università) che stende la sua tela sulla intera società, ma ne rimane distinto.
Nessuna apparenza o forma democratica e assembleare di selezione o designazione di alcuni o di tanti dirigenti dello stato, nessun genere di ‘controllo’ esercitato sulle sue azioni, di divisione dei poteri e mansioni creata al suo interno, di limiti posti da consuetudini e da altre istituzioni sociali cambia questa natura dello stato. Tanto meno la cambiano le dottrine degli apologeti dello stato (tradottesi in linguaggio corrente) che identificano stato e nazione, stato e società, stato e popolo, stato e classe (per cui si dice che l’Italia è entrata in guerra con l’Austria , salvo poi magari aggiungere, passando sopra alla stridente contraddizione, che dichiarando guerra all’Austria fu violentata la volontà della maggioranza del paese). Ogni stato ha consistenza, continuità, strumenti di conservazione e di riproduzione che fanno ovviamente i conti con gli individui che esso domina e i rapporti che connettono questi individui, ma ne sono autonomi. Quando i borghesi parlano di ‘senso dello stato’, essi alludono proprio a questo, a una entità con personalità sua propria che non può essere trascinata qua e là e piegata a qualsiasi politica.
La posizione circa lo stato (necessità di distruggere lo stato che attualmente domina nel paese, necessità di costruire un altro stato – quello del proletariato, conservazione e negazione dello stato nell’epoca della transizione dal capitalismo al comunismo) non dipende da scelta o preferenze soggettive. Può capitare che ognuno di noi, individualmente e casualmente, abbia le preferenze e le inclinazioni più varie.
Ma qui si tratta del modo in cui nella situazione attuale si muovono ed evolvono milioni di uomini che non hanno né esperienza né possibilità di unità cosciente preventiva tra loro, della via e dei mezzi con cui milioni di uomini si appropriano, per la prima volta nella storia, delle loro relazioni sociali fino a padroneggiarle e a stabilirle secondo i loro bisogni: milioni di uomini che oramai sono indissolubilmente e vitalmente legati l’uno all’altro, da un capo all’altro della terra, per la produzione e la riproduzione delle condizioni materiali della loro esistenza (anche questo per la prima volta nella storia). Ciò non avviene né casualmente né arbitrariamente, ma è legato al determinato grado di sviluppo culturale e di socialità consapevole e di comprensione reciproca raggiunti da milioni di individui (cose in ultima analisi legate a loro volta in una certa misura al grado di produttività del lavoro umano raggiunto).
La società borghese, come ogni società basata sullo sfruttamento di alcuni uomini su altri, anche la società borghese più progredita, più sicura di sé, più tranquilla, più ‘democratica’, mantiene necessariamente e il più possibile fuori dalla politica, dalla cultura, dall’arte di dirigere e organizzare, dagli strumenti di comunicazione la maggior parte della popolazione.
Nell’epoca della sussunzione solo formale dei lavoratori nel capitale (cioè nel periodo in cui i capitalisti si limitavano per così dire a comperare e usare la capacità lavorativa umana come la trovavano, e questa - e gli individui che ne erano i portatori - era il risultato di uno sviluppo sociale precedente o a lato, avvenuto nell’ambito di rapporti non capitalistici) i lavoratori erano tenuti fuori da questi campi dalle condizioni stesse da cui provenivano; erano per così dire tenuti fuori ‘spontaneamente’ dalle condizioni miserabili di bisogno, di stagnazione, di isolamento sociale, di tradizione, di superstizione e di ignoranza in cui erano prodotti.
Nell’epoca della sussunzione reale dei lavoratori nel capitale (cioè nel periodo in cui i capitalisti non solo acquistano e usano la capacità lavorativa umana, ma la formano anche nelle condizioni di socialità coatta, di abbondanza di prodotti sgorgante dalla produttività del lavoro crescente illimitatamente, di impiego sistematico della cultura nel processo lavorativo, di rivoluzionamento continuo delle condizioni di lavoro, di abitazione, di collocazione, di comunicazione, di consumo, di sviluppo universale e onnilaterale di bisogni di conoscenza e di comunicazione, di interdipendenza mondiale fin negli aspetti più immediati della vita quotidiana) i lavoratori sono tenuti fuori da quei campi dalle misure diverse e a volte tra loro contraddittorie ma unitarie nel risultato (nessuna notizia vale quanto un numero illimitato di notizie contraddittorie date alla rinfusa) della controrivoluzione preventiva. Quell’insieme di misure che la borghesia sviluppa da quasi un secolo, da quando ha complessivamente come classe di essere seduta su un barile di polvere che essa stessa ha creato e solo sul quale può star seduta, misure tese a prevenire la rivoluzione proletaria impedendo che la forza rivoluzionaria potenziale del proletariato diventi effettiva, operante.
Sottrarsi a questa emarginazione pur essendo ancora socialmente dominanti le condizioni che la impongono e la esigono (rapporti di lavoro salariato), combattere la borghesia pur essendo la vendita alla borghesia della propria capacità lavorativa l’unico modo di procurarsi da vivere per la stragrande maggioranza degli uomini: questo è inevitabilmente un processo in cui gli individui si differenziano, alcuni arrivano prima altri dopo, alcuni individui vi arrivano e altri no, alcuni vi arrivano in un modo, altri in un altro.
Inoltre la società borghese è una società di individui, il nostro sentire e agire è più o meno individuale, impariamo e ci muoviamo individualmente, siamo momento per momento formati dalla scuola pratica e quotidiana ‘di ognuno per sé, dio per tutti’.
Unire, creare, consolidare e far agire quel patrimonio di cultura, di capacità di organizzazione e di direzione, di modi di sentire e di operare in cui si concreta il sottrarsi alla condizione di schiavi salariati è ‘remare controcorrente’, che richiede continuamente di distinguersi dai propri compagni di classe che restano ancora immersi nella condizione di schiavi salariati e contemporaneamente trovare nuovi strumenti di unità cori essi.
E non si tratta, come pensano alcuni sciocchi e predicano alcuni furfanti, del fatto che la maggioranza degli uomini ‘è stupida’. Perché è quanto fanno in pratica anche tutti questi che si reputano intelligenti O colti rispetto alla maggioranza ‘stupida’: quando si è in corsa, può anche darsi che tutti o molti corridori abbiano poca voglia di correre è molta di fermarsi, ma a fermarsi per conto proprio si rischia sempre di essere travolti dai propri stessi compagni di corsa.
Noi comunisti sappiamo di essere nella merda, noi come tutti gli altri proletari. Noi lottiamo per un ambiente di aria pura. Quindi siamo sempre tesi a tenere la testa più alta possibile, con la coscienza sempre presente di non scambiare le boccate d’aria che di tanto in tanto riusciamo a respirare con la vita in un ambiente di aria pura.
Noi comunisti sappiamo che per avere un ambiente di aria pura è necessario riuscire a mobilitare attivamente, per l’eliminazione della merda, la massa dei proletari. Il massimo di moralità, di umanità, di salute mentale, sentimentale e fisica oggi si esprime non nelle boccate di aria che ognuno di noi di quando in quando riesce a respirare, ma in quanto riusciamo a creare di mobilitazione di massa per eliminare la merda.
Gli anarchici, i soggettivisti, i ‘rivoluzionari comportamentisti’, ecc. invece pongono questo massimo in quanto di aria ognuno di essi riesce a respirare, nella ‘moralità’ che ognuno di essi riesce a esprimere. Di conseguenza 1) essi sono preda dell’utopia (ognuno di loro resta nella merda come noi: vedasi la sorte di questi individui, delle loro iniziative per una vita alternativa, per una comunità di eletti, ecc.); 2) il contenuto concreto delle loro iniziative è arbitrario, soggettivo (e quindi disgregatore del movimento rivoluzionario): questo contenuto nasce dalle sensazioni e dalle ribellioni istintive di ognuno di loro, dai loro pregiudizi, dalla ideologia dominante (borghese) o dalla sua semplice negazione (come ad es. all’autoritarismo e individualismo del rapporto padre-figlio viene sostituito l’indifferenza reciproca) e spesso è addirittura reazionario (v. i ritorni alla tribù e al paese).
Accusano noi comunisti di essere ‘schizofrenici’, dalla doppia personalità: da una parte l’antagonismo assoluto alla società borghese, dall’altra l’adeguamento delle nostre attività alle leggi oggettive secondo le quali essa si svolge; da una parte per una società senza stato, dall’altra per la creazione dello stato della dittatura del proletariato; ecc. Effettivamente siamo uomini della preistoria dell’umanità che ci facciamo portatori in questa preistoria delle potenzialità in essa racchiuse di passaggio alla storia. Come elementi della società borghese siamo anche noi alienati rispetto al dominio delle nostre relazioni sociali e lottiamo per distruggere l’alienazione; siamo emarginati rispetto alla direzione della nostra vita individuale e sociale e lottiamo per la fine della emarginazione. Non siamo di quelli che si adagiano nella società borghese né che sprecano le loro energie nel tentativo continuo di scavarsi nelle sue pieghe una cuccia confortevole.
Perché la classe operaia, produttrice di plusvalore nella società borghese, è ‘classe rivoluzionaria’ per eccellenza?
Non perché in ogni singolo periodo è la classe politicamente più attiva nella opposizione allo stato di cose esistenti e allo stato che impone questo stato di cose e lotta per conservarlo. Ma perché il superamento del capitalismo può venire solo dalla mobilitazione della classe operaia; dal suo superare in massa la condizione di assieme di individui venditori di capacità lavorativa; il cui rapporto con gli altri individui, con i prodotti del lavoro e in generale con tutti gli aspetti individuali e sociali consiste e deriva dalla vendita della propria capacità lavorativa; dal fatto che essa assume in massa un ruolo dirigente della sua stessa attività. Di conseguenza verrebbe reso impossibile il permanere dei ruoli distinti (e contrapposti) delle altre classi; verrebbe eliminato tutto il contesto sociale della produzione per vendere (del rapporto di scambio, di valore, di denaro) e della vendita (e acquisto) della capacità lavorativa in generale. Questo processo non può essere compiuto che dalla classe operaia (che ‘emancipando se stessa emancipa tutta l’umanità’) perché è la trasformazione della classe operaia stessa, il passare in massa degli individui che la compongono dal ruolo di oggetti, di strumenti della vita sociale, in mano altrui, al ruolo di soggetti, di protagonisti.
In particolare della ‘classe operaia produttrice di plusvalore’ perché è quella parte del proletariato (cioè della massa di venditori della propria capacità lavorativa) il cui ruolo è definito e fisso nella società borghese (e anche essenziale, ineliminabile); mentre il ruolo delle altre parti del proletariato è inessenziale e anche mutevole nel divenire della società borghese stessa, pur restando nel suo ambito. Anche il soldato di mestiere, l’insegnante, il poliziotto, l’impiegato statale, ecc. vendono la loro capacità lavorativa; ma il loro esistere o meno (e la loro quantità) dipendono da circostanze diverse dalla valorizzazione del capitale e possono sparire o comparire senza che vari il carattere borghese della società. E solo la scomparsa del ruolo della ‘classe operaia produttrice di plusvalore’ che segna la fine della società borghese, che testimonia che è avvenuto il superamento storico di questa società. La scomparsa del ruolo di altre parti del proletariato non è incompatibile con il permanere della società borghese.
E inoltre la ‘classe operaia produttrice di plusvalore’ che, tra tutte le parti del proletariato, vive nella società borghese le condizioni più adatte a sviluppare quelle attitudini di coesione (che soggettivamente diventa organizzazione) che rendono possibile il superamento della società borghese, che costituiscono la ‘comunità reale’ che sostituirà la comunità formale dell’epoca borghese.
Questo ruolo rivoluzionario della classe operaia non implica che gli operai siano in ogni momento, in ogni paese, ecc. gli elementi politicamente più rivoluzionari. L’essere politicamente rivoluzionari è legato a tanti fattori soggettivi, culturali, storicamente accidentali che solo indirettamente sono connessi con i fattori oggettivi di cui sopra.
La storia che abbiamo alle spalle e gli avvenimenti che ci circondano confermano ambedue le cose. Sulla base delle contraddizioni storicamente determinate delle società borghesi si sviluppano a ripresa movimenti rivoluzionari nei quali le varie parti del proletariato adempiono a funzioni più o meno importanti. Ma il carattere antiborghese di ognuno di questi movimenti rivoluzionari è legato direttamente alla importanza del ruolo che in essi ha la classe operaia produttrice di plusvalore.
Da questo punto di vista, a questo fine, la condizione delle altre classi proletarie è secondaria. Già oggi, nella società borghese, man mano che il capitale approfondisce la sussunzione reale dell’intera società (cioè ne plasma e riplasma ogni aspetto onde renderlo conforme, coerente e favorevole alla maggiore valorizzazione del capitale), esso limita la crescita e anche riduce la grandezza numerica della classe operaia produttrice di plusvalore. Altre classi di uomini vengono create, che incarnano, in modo deformato dal marchio borghese, la possibilità di riduzione ad una frazione trascurabile del tempo di lavoro necessario alla produzione e riproduzione delle condizioni materiali dell’esistenza e il bisogno che anche questo tempo minimo si ponga diversamente da oggi, libero dal marchio della schiavitù salariale.
Ma proprio perché queste classi non sono impiegate direttamente per la produzione di plusvalore, il rovesciamento della loro posizione sociale (*) non implica la fine della società borghese. È solo quando cessa di esistere la classe operaia produttrice di plusvalore che cessa anche la società borghese.
(*) Ad es. la nazionalizzazione della sanità che trasforma i medici da liberi professionisti in salariati o la trasformazione inversa.
E non basta l’eliminazione del padrone, del capitalista a porre fine all’esistenza della classe operaia produttrice di plusvalore. Bisogna che cessi di esistere nella società una massa di individui che sono tenuti e restano estranei all’uso concreto della loro propria attività, che si rapportano agli altri come venditori delle loro capacità lavorative, il cui plus-lavoro è l’elemento motore della vita economica di tutta la società. La fine dell’esistenza di questa massa di individui non può essere che opera di questi stessi individui, ma comporta contemporaneamente la trasformazione di tutta la società.
Noi nella lotta contro la tesi della maturità del comunismo € le sue deleterie conseguenze politiche tendiamo a porre in luce, nella nostra propaganda, come obiettivo la dittatura del proletariato. Ma in realtà lottiamo per il comunismo.
La transizione dal capitalismo al comunismo comporta la estinzione della natura di merce sia per i prodotti del lavoro che per la capacità lavorativa degli uomini. La mobilitazione di massa per questo obiettivo è la condizione necessaria per la trasformazione di tutti gli altri rapporti sociali, senza della quale ogni movimento per la trasformazione di altri rapporti sociali, ogni tentativo di rivoluzione culturale e nei comportamenti o resta sterile di risultati o si trasforma in movimento per creare privilegi per una minoranza di uomini.
La capacità lavorativa è la merce venduta dalla stragrande maggioranza degli uomini. Togliere il carattere di merce alla capacità lavorativa è il compito più difficile e risolutivo della transizione dal capitalismo al comunismo, come si rileva anche dalle esperienze dei paesi dell’Est e in primo luogo dell’URSS.
Pensare di togliere la natura di merce ai prodotti del lavoro e non alla capacità lavorativa degli uomini è una assurdità. Il presupposto perché degli individui vendano la loro capacità lavorativa è che altri individui la comperino: offerta e domanda di capacità lavorativa devono essere entrambe presenti. Ma ciò implica anche che il venditore cerchi di vendere al miglior acquirente e cerchi di vendere quella capacità lavorativa il cui prezzo è più alto. Ciò implica che egli possa vendere all’uno o all’altro a sua scelta, quindi anche a nessuno; che possa vendere questa o quella capacità lavorativa di cui è portatore, quindi anche nessuna.
Ci deve essere allora qualcosa che lo obbliga a venderne almeno una a qualcuno: occorre quindi che egli non possa ottenere i beni necessari alla sua esistenza se non con la ‘mediazione’, tramite la vendita di una sua capacità lavorativa ad altri; oppure che uno stato applichi capillarmente leggi contro l’ozio, il vagabondaggio o il furto: cioè un sistema repressivo generalizzato che applichi arresto, fucilazione, fustigazione, lavoro coatto, impiccagione, reclusione in carceri, manicomi, riformatori, orfanotrofi o qualcosa del genere a chi non è in condizione di dimostrare di essere già vincolato a un contratto di vendita della sua capacità lavorativa. Un sistema che nella storia della nascita del capitalismo e del colonialismo (nella civile Inghilterra, nelle Indie Occidentali, in Africa, ecc.) è stato applicato ogniqualvolta la facilità di trovare in natura beni di consumo, o la disponibilità delle condizioni per produrli direttamente o un non ancora ben accettato e radicato sistema di possesso privato dei beni di consumo o delle condizioni per produrli, consentiva a masse di individui di vivere senza vendere capacità lavorativa. Un sistema che però presenta una lunga serie di inconvenienti. Esclusa questa soluzione straordinaria, d’emergenza e transitoria, occorre quindi che per una massa di individui l’entrata in possesso dei beni necessari al consumo sia mediata dallo scambio con la capacità lavorativa, cioè che i beni necessari al loro consumo siano anch’essi merci, ottenibili cioè in quantità e qualità corrispondenti alla quantità e qualità della capacità lavorativa venduta. Quindi questi beni devono essere prodotti per essere venduti, ossia come merci.(*)
Ciò comporta, attraverso una serie di passaggi storici e logici, che anche i mezzi di produzione e le condizioni della produzione siano prodotti come merci e scambiati.
(*) Anche recentemente, in barba a Keynes e a Galbraith, i nostri capitalisti si sono resti ben conto che era impossibile mantenere il sistema del lavoro salariato (e quindi la società borghese) e nello stesso tempo i benefici dello ‘stato sociale’ e ‘stato del benessere’. E naturalmente hanno optato come la loro natura esigeva.
Quindi togliere la natura di merci ai prodotti del lavoro senza togliere la natura di merce alla capacità lavorativa degli individui è imporre nella società un sistema di coercizione diretta, statale, che non può essere né stabile né efficace in termini di produttività del lavoro: il fucile puntato alle spalle o la minaccia della fucilazione possono anche indurre a lavorare; è ben difficile che inducano alla diligenza, all’affinamento dell’abilità, ecc. quanto un articolato e diffuso sistema di mercificazione della forza lavoro e dei prodotti del lavoro.(*)
(*) La storia delle riforme ‘economiche’ dei paesi dell’Est diventa chiara e comprensibile, in tutti i suoi svolgimenti, nei passi avanti e nei passi indietro, nelle svolte e nelle giravolte, se la si studia alla luce di queste considerazioni, e quindi la si studia come storia di lotta di classe anziché nella forma mistificata di storia economica o, peggio ancora, di storia della tecnologia.
Togliere la natura di merci ai prodotti del lavoro significa una società in cui né individui né gruppi di individui decideranno più di produrre un qualche cosa per possibilità di guadagno; che la natura delle cose prodotte non sarà più influenzata dalla necessità di accaparrarsi compratori; che la decisione di produrre una cosa sarà il risultato della riconosciuta volontà di godere di essa; che un oggetto sarà prodotto o non prodotto, prodotto in un modo o in un altro non solo in base al tempo di lavoro a ciò necessario, ma anche in base alla sua riconosciuta utilità e alle conseguenze che la sua produzione ha su chi vi è addetto; che per gli individui l’accesso ai prodotti necessari alla loro esistenza sarà un attributo inalienabile e incondizionato derivante loro dal solo fatto di essere membri della società, di esistere (come l’accesso all’aria da respirare), con limiti derivanti solo da disponibilità, accordi, regolamenti e abitudini.
Togliere la natura di merce alla capacità lavorativa significa non solo che nessuno, individuo o gruppo di individui, comprerà o rifiuterà di comperare capacità lavorativa di un altro individuo, ma anche che nessuno la venderà (contrariamente a tutte le politiche socialdemocratiche, non si tratta del prezzo a cui la capacità lavorativa viene venduta o comperata: che sia pagata molto o pagata poco, nulla cambia al fatto che la capacità lavorativa resta una merce); quindi che la distribuzione delle capacità lavorative dei singoli individui tra le varie mansioni lavorative (e anche la formazione di queste stesse capacità lavorative, alcune delle quali resteranno per un tempo imprecisabile distinte tra loro, non intercambiabili, essendo impossibile, sulla base del nostro stato attuale, immaginare che si possa già materializzare nel macchinario e negli strumenti di lavoro tutta quella abilità necessaria ai singoli lavori che eccede il pur arricchito e crescente patrimonio conoscitivo e operativo universalmente acquisito dagli individui) sarà determinata da fattori diversi dalla ricerca di guadagno e da meccanismi diversi dalla ricerca di un posto di lavoro e dalla ricerca di dipendenti; che la erogazione, l’esercizio delle proprie capacità lavorative sarà attuata da ogni individuo non come mezzo per entrare in possesso di beni di consumo o di altra parte del prodotto del lavoro, né come misura della quantità di beni di consumo di cui potrà entrare in possesso, ma come suo normale modo di esistere, come espressione normale della sua esistenza nella società, come suo dovere sociale.
Oggi sono chiare a noi e a ampie masse di lavoratori la limitazione allo sviluppo dell’uomo, la miseria e la condanna che promanano dal carattere di merce assunta dai prodotti del lavoro. Oggi è chiarissimo a ampie masse di lavoratori il marchio schiavistico che promana dal fatto che la grande maggioranza di noi possa essere assunta e licenziata dai padroni. Non è invece altrettanto diffusa la coscienza che la liberazione da questi due gioghi è indissolubilmente connessa con la nostra liberazione dalla disponibilità a vendere la nostra capacità lavorativa al migliore offerente; con la liberazione dalla nostra privata proprietà sulla nostra forza lavorativa, dall’uso individualmente arbitrario della propria capacità lavorativa. Questa nostra libertà ha come altra faccia indissolubilmente connessa la libertà del capitalista di comperare o rifiutare la nostra capacità lavorativa; questa nostra libertà è l’ornamento che questa società schiavista pone addosso a noi schiavi, il diritto che questa società schiavista assegna agli schiavi, il diritto della nostra schiavitù.
Chi vuole mantenere i diritti connessi con il suo stato di schiavo salariato (essere disposto o no a lavorare a secondo del suo individuale stato di necessità e nella misura della sua individuale necessità; essere disposto a esercitare quella e solo quella capacità lavorativa che a lui sia al momento di tornaconto), inevitabilmente deve rassegnarsi anche agli inconvenienti del suo stato di schiavo salariato. Così come lo schiavo del tempo passato che voleva godere della sicurezza del cibo passato dal padrone, doveva ‘godere’ anche della sua frusta.
Nella società borghese, con il suo incessante, diffuso, universale contrattare, milioni di individui sono abituati a deprecare la ’libertà’ altrui di speculare, di comperare o non comperare di cui subiscono le conseguenze negative; ma sono altrettanto abituati e trovano del tutto ovvio, legittimo e naturale, ognuno per se stesso, di vendere o non vendere, di approfittare delle buone occasioni per speculare, per alzare il proprio prezzo. Quanti lamenti per l’alto prezzo delle merci che si comperano e invocazioni di fissazione d’imperio del prezzo delle merci altrui quando sale! Ma quanti strilli se viene minacciata la possibilità di vendere la propria merce e al prezzo più alto che si può spuntare! Quanti strilli quando i prezzi della propria merce calano e invocazioni di sostegno ai prezzi! Quanti strilli se viene minacciata la ‘libertà di iniziativa’ e la ‘libertà di mercato’ quando le cose vanno bene; quanti contro la ‘eccessiva’ concorrenza quando le cose van. no male! E nell’ambito della società borghese non può che essere così. Chi si mette a fare l’uomo civile in una compagnia di birbanti finisce senza mutande. Le esortazioni alla moderazione si sono tradotte unicamente in danno degli operai che le hanno accettate: è esperienza di questi anni in cui milioni di lavoratori hanno accettato le esortazioni alla ‘moderazione’ lanciate dai Lama e Benvenuto di turno e ne pagano le conseguenze. O aboliamo il ‘libero mercato’ e la ‘libera iniziativa’ per tutti, oppure è un minchione chi accetta di vendere la sua merce a un prezzo inferiore al massimo che può spuntare, per dover poi acquistare le condizioni necessarie a ripetere la produzione da uno che gliele venderà al prezzo più alto che gli sarà possibile spuntare.
Ovviamente la semplice soppressione di queste ‘libertà’ individuali (che per la maggioranza degli uomini significano oppressione e miseria) può anche tradursi nel passaggio da un sistema di oppressione impersonale, indiretta, esercitata tramite strumenti ‘oggettivi’ come le merci, i prezzi, il denaro, la ‘sacra legge’ della domanda e dell’offerta, ecc. a un sistema di oppressione amministrativa, personale, diretta, esercitata dal poliziotto, dal magistrato, dal secondino, dal controllore. Ciò è tanto più facile quanto meno è vivo nella coscienza comune degli uomini il legame che ci unisce l’uno all’altro, quanto più è limitata la ricchezza sociale e quanto più ancora schiavo della natura è l’uomo: cioè quanto più bassa è la produttività del lavoro umano.
Ma in definitiva, al livello di sviluppo della produttività del lavoro e delle forze produttive raggiunto mondialmente dagli uomini, oramai esiste la possibilità di evitare che un sistema di oppressione amministrativa sia il risultato immediato (e transitorio al ristabilimento della oppressione economica, tanto più efficace!) della soppressione della ‘libertà’ mercantile: il comunismo è possibile e ai proletari e alle masse oppresse di tutto il mondo conviene puntare su questa possibilità, che è anche l’unica possibilità di rompere il succedersi di distruzione e ricostruzione che è l’inevitabile modo di essere della società imperialista (ricostruzione, boom, crisi, guerra, ricostruzione e così via) e di evitare le conseguenze della putrefazione del capitalismo. Il realizzarsi di questa possibilità, della transizione al comunismo, è nelle mani del movimento cosciente dei lavoratori, è affidato alla sua unità, alla sua capacità di dotarsi di strumenti e pratiche che rendano possibile sia l’esistenza di una volontà comune (che rispecchia la interdipendenza materiale degli individui uno dall’altro), sia il godimento positivo della diversità, della ricchezza di cui la diversità, il cambiamento e il nuovo sono portatori, senza che quegli inevitabili rischi connessi alla sperimentazione e al procedere per tentativi con cui il nuovo viene al mondo, incidano negativamente sulle condizioni di esistenza degli individui.
Nella fase di transizione dal capitalismo al comunismo la natura merce dei prodotti del lavoro e della capacità lavorativa degli individui viene progressivamente limi fasi e per salti. Nell’ambito del togliere la natura di merce ai prodotti del lavoro si inquadrano:
- La assegnazione amministrativa dei mezzi di produzione e di materie prime alle unità produttive, che quindi né le comperano né le vendono.
- La assegnazione di compiti produttivi definiti amministrativamente per quantità e qualità dei prodotti, alle unità produttive, che quindi cessano di produrre per vendere, ma producono i beni ad essi commissionati con decisione sociale e nella quantità parimenti decisa.
- La assegnazione di determinati beni di consumo a determinate persone (a cui quindi non vengono venduti e che quindi non li comprano); assegnazione che ‘fa i conti’ con una serie di comportamenti concreti (l’assegnazione gratuita del latte o del pane deve per es. accompagnarsi con un impiego responsabile del latte e del pane o con forme di razionamento).
- La fissazione amministrativa dei prezzi dei prodotti di cui è mantenuta ancora la vendita e la compera. Ora questi prezzi quindi svolgono solo il ruolo di regolare discriminare e limitare impersonalmente l’accesso degli individui al loro uso, rispecchiando sia una condizione di penuria non ancora superata, sia la natura ancora parzialmente mercantile della capacità lavorativa e quindi la sopravvivenza di disuguaglianze economiche e sociali tra individui e gruppi (in definitiva la non ancora realizzata estinzione della divisione della società in classi; la non ancora realizzata comunità reale e un determinato livello di sviluppo della contraddizione individuo-collettivo) Questi prezzi, il cui livello quantitativo non è già più connesso né con il valore dei prodotti (il tempo di lavoro socialmente necessario a produrli) né con il loro costo di produzione (che presuppone addirittura il capitale finanziario), non hanno già più il ruolo di consentire la riproduzione dei prodotti stessi, che infatti non sono già più prodotti come merci, come valori (v. Nota 1 a pag. 75).
- La scelta amministrativa di che cosa e quanto produrre anche dei prodotti di cui è ancora mantenuta la vendita, onde evitare che il regime salariale e di diseguaglianza ancora esistente spinga all’impiego preferenziale di risorse produttive per i gruppi ancora privilegiati, insomma che sia il mercato a regolare l’impiego delle risorse produttive.
Nell’ambito del togliere la natura di merce alla capacità lavorativa degli individui si inquadrano:
- Le politiche di avviamento al lavoro, di impiego di tutte le capacità lavorative di tutti gli individui. Il contesto è lo svolgimento di tutte le attività lavorative direttamente o indirettamente necessarie alla produzione e alla riproduzione delle condizioni dell’esistenza, compito che se non viene assolto segna la decadenza dell’intera società e la sconfitta di ogni transizione dal capitalismo al comunismo: è un dato della esperienza del movimento rivoluzionario proletario che la borghesia trae forza dal mancato assolvimento (reale o presunto) di questo compito per rovesciare le forze rivoluzionarie. Con queste politiche si mira 1) a rompere l’asservimento degli individui alla divisione del lavoro, quella condizione per cui ora la stragrande maggioranza degli individui resta formata, deformata e oppressa (quando non soppressa) dalla condanna a dedicarsi tutta la vita a una particolare attività: alcuni lavori nocivi, pesanti, che si svolgono in particolari condizioni, ecc. non possono essere svolti da una persona per più di tot tempo (anni o mesi) consecutivo, creazione di un ‘servizio del lavoro’ per occupare questi posti di lavoro, ammesso che resti necessario svolgerli; 2) a realizzare la partecipazione al lavoro produttivo di tutti gli individui, nell’ambito delle loro forze e capacità: quindi qui si pone la questione che le donne, i bambini, gli anziani, gli invalidi partecipino al lavoro rompendo la condizione di emarginazione in cui li relega la società borghese, non solo e non tanto come loro ‘dovere sociale’, ma soprattutto come tramite della loro vita sociale e della formazione ed esplicazione di capacità creative; 3) a dividere nettamente il lavoro produttivo, le attività produttive (che in questo contesto, a differenza che nella società borghese, sono definite come quelle attività direttamente o indirettamente necessarie alla produzione e alla riproduzione delle condizioni dell’esistenza degli uomini e che quindi devono essere necessariamente svolte) dalle altre attività (culturali, creative, ricreative, sportive, politiche, ecc) che solo la condanna di una parte della popolazione al lavoro salariato fa sì che nella società borghese siano poste come professioni esercitate a tempo pieno e a vita da alcuni individui. Questa divisione è il punto di partenza per realizzare una condizione in cui le prime siano suddivise fra tutti come obbligo e le seconde diventino regno della libera e illimitata esplicazione e sviluppo delle capacità umane, accessibile e acceduta da tutti; 4) alla massima liberazione possibile di tutti gli individui dal lavoro produttivo: riduzione della giornata lavorativa o comunque del tempo che durante la vita ogni individuo dedica necessariamente al lavoro produttivo e quindi interesse comune e diffuso alla crescita della produttività del lavoro umano.
In questo contesto vengono ovviamente rotte anche tutte quelle condizioni che il proletariato con la sua lotta ha eretto nel corso dei secoli come barriere contro l’illimitato sfruttamento e oppressione a cui tende la borghesia, ma che contemporaneamente comportano limiti allo sviluppo dell’individuo (esclusione dal lavoro di donne, bambini, anziani, invalidi; ruolo meramente esecutivo e deresponsabilizzato della maggioranza dei lavoratori che nell’ambito del rapporto salariato, devono limitarsi a fare quello che gli viene detto di fare, ecc.) come ombrelli impugnati per avere un qualche riparo dalla pioggia, che diventano un impaccio al movimento e sono da gettare quando esce il sole.
- Le politiche di formazione delle capacità lavorative degli individui e di accesso del numero più ampio possibile di individui al godimento del patrimonio culturale, scientifico, artistico e spirituale in genere della società e alle condizioni necessarie per contribuire al suo arricchimento: quindi anzitutto le misure tese a rompere la condizione per cui l’istruzione è proprietà personale, merce, tramite, per l’individuo che la possiede, di privilegi materiali e sociali.
La trasformazione delle relazioni tra gli individui all’interno delle unità produttive, tesa a superare la attribuzione esclusiva ad alcuni individui delle attività direttive ed organizzative, ad altri delle attività esecutive; ad alcuni di attività intellettuali, ad altri di attività fisiche; ad alcuni di attività di progettazione e di ricerca, ad altri di attività esecutive; la negazione del licenziamento individuale e collettivo e dell’autolicenziamento.
La gestione da parte dei lavoratori del loro lavoro immediato, la loro gestione sull’organizzazione del lavoro, le ‘relazioni industriali’, la vita della singola unità produttiva, cioè in sostanza autogestione e cooperazione. Auto gestione del processo lavorativo e cooperazione tra i lavoratori sono impossibili nel capitalismo (salvo che come fenomeni transitori o casi marginali che sopravvivono nelle pieghe della società capitalistica). L’altro lato della medaglia è che un contesto generale borghese della società è incompatibile con una diffusa reale autogestione del processo lavorativo da parte dei lavoratori.
Se autogestione vuol dire che la singola unità produttiva produce merci (cioè compera le condizioni di produzione e vende i prodotti), ma la direzione anziché essere acquistata, ereditata, ecc. è eletta o designata in altro modo dai lavoratori, ciò non costituisce ancora superamento definitivo del rapporto di capitale.
I lavoratori restano ancora esclusi dal lavoro di direzione, progettazione, organizzazione, ecc. Essi restano venditori della loro capacità lavorativa, quali che siano i regolamenti e le leggi che regolano le condizioni della compra-vendita. Il successo di ogni unità produttiva resta legato alla massima realizzazione di pluslavoro dei lavoratori impiegati in essa, rispetto a quel che avviene nelle altre unità produttive.
Se autogestione vuol dire un sistema di relazioni nel lavoro che realizza e sviluppa la partecipazione di tutti i lavoratori a tutti gli aspetti della loro attività produttiva, allora è un aspetto della transizione dal capitalismo al comunismo, ed è ovviamente incompatibile con il permanere della emarginazione politica, culturale, ecc. dei lavoratori nella società.
Quindi le ‘relazioni industriali’ vigenti in un paese, il ruolo dei lavoratori nella organizzazione del loro lavoro e rispetto alla scienza e alla tecnologia del loro lavoro (non in casi eccezionali che sono isole nelle pieghe della società, ma come condizione prevalente e generale) forniscono una verifica dei rapporti di produzione vigenti nella società.
I lavoratori non possono essere liberi e padroni di se stessi nel processo lavorativo diretto e asserviti nei rapporti generali, come non possono essere liberi e padroni nei rapporti generali e asserviti nel processo lavorativo diretto. «Il dominio politico dei produttori non può coesistere con la perpetuazione del loro asservimento sociale» (Marx, La guerra civile in Francia, Ed. Riuniti 1977, pag. 85).
Quindi proporre l’autogestione e la cooperazione per le unità produttive in un contesto generale borghese è fare utopistiche chiacchiere diversive. Ma è anche impossibile un processo di transizione dal capitalismo al comunismo senza la trasformazione delle relazioni industriali, come aspetto del rovesciamento del rapporto tra lavoro vivo e lavoro morto creato dal capitalismo (v. Nota 2 a pag. 75).
- Le politiche via via più egualitarie di remunerazione delle prestazioni lavorative degli individui, nella misura in cui permangono ancora remunerazioni individuali o di gruppo delle relative prestazioni di lavoro, misura che è direttamente connessa con la misura in cui alcuni beni di consumo sono ancora venduti e comperati (cioè sono in una qualche misura ancora merci).
- Le misure e le pratiche attraverso le quali la iniziativa ‘economica (la decisione di iniziare o di sospendere un’attività e una impresa, di destinare a questo scopo o distogliere da questo scopo forze produttive) diventa realmente una decisione sociale, e quindi diventano veramente collettive anche le decisioni su cosa produrre, come produrlo, chi deve produrlo, come ripartire il prodotto, l’assegnazione ad ogni individuo di date mansioni, ecc.(*)
(*) Può sembrare che tutte queste cose 1) comportino una enorme perdita di tempo e 2) intralcino il sorgere di ogni novità e diversità. Come fare una cosa se, avendone sempre fatta un’altra, la maggioranza non ha chiara l’utilità o la possibilità di successo della nuova e non intende correre il rischio insito nel provarla? Questione che nella società borghese, nell’ambito dei limiti miserabili posti dalla società borghese stessa alla novità e alla diversità limitandone l’esercizio a quella minoranza che dispone di comando sul lavoro cioè di denaro, è risolta per il piccolo capitalista in base alla morale dei detti ‘chi non risica non rosica’ e ‘chi rompe paga’, e per i grandi capitalisti con l’affermata prassi del disporre del capitale altrui impossessandosi dei profitti e scaricando le perdite su altri. Ma, quanto alla prima preoccupazione, facendo si impara a fare meglio e la comunicazione tra individui, necessaria a realizzare l’accordo fra di loro, è già essa stessa la vita sociale di ognuno di questi individui. Quando il borghese malignamente ci addita le difficoltà del parto della nuova società, dobbiamo sempre ricordare gli enormi sprechi di tempo e di uomini che si hanno, non nella sua azienda dove certo solo lui può ‘perdere tempo’ a riflettere sul da farsi e dove se un individuo non gli serve viene messo alla porta e anche il tempo per pisciare è misurato, controllato e limitato, ma nella società borghese: con la disoccupazione dei lavoratori, l’enorme sviluppo di attività parassitarie e speculative interamente tese non alla produzione ma alla appropriazione del prodotto, l’ozio della classe dominante e dello stuolo dei suoi lacché, le attività intellettuali e pratiche volte alla repressione e all’inganno, il sottobosco politico e clientelare dello stato e dei suoi organi. Insomma passeremo del tempo a trovare tra noi la soluzione migliore dei nostri problemi, ma non ne passeremo più all’ufficio di collocamento e a difenderci dalle decisioni e dalle angherie della classe dominante! Quanto alla seconda preoccupazione, a parte il grande risultato per noi proletari dell’accesso di tutti all’esercizio della novità e della diversità, è proprio dall’abbondanza delle condizioni materiali dell’esistenza (cioè dalla elevata produttività del lavoro umano e dalla partecipazione di tutti alla loro produzione) che nascono le basi perché sia possibile non solo tollerare, ma aprire le porte al tentare nuove strade, allo sperimentare: proprio perché il rischio di insuccesso e di errore che è insito in ogni cosa nuova non diventa questione di vita o di morte per nessuno e la probabilità di successo diventa possibilità di maggiore libertà per tutti. Così come è proprio nella ‘natura umana’ resa possibile da questa abbondanza delle condizioni materiali dell’esistenza, che si sono create le condizioni perché la comunità umana che è nel nostro futuro:
1. da una parte investa tutti gli aspetti di ogni individuo sicché non ci sia nulla di privato. Già oggi vediamo quanto sia finzione giuridica (utile solo ai fini repressivi) che i sentimenti, i gusti, le abitudini, gli stati d’animo di un individuo sono ‘cazzi suoi’. Oggi gli individui di tutto il mondo vivono gomito a gomito, condizionandosi reciprocamente in tutti gli aspetti della loro vita; anche dove le distanze fisiche restano grandi, il sistema di comunicazioni e trasporti le ha annullate economicamente e culturalmente. Quando gli individui vivono gomito a gomito non ci sono santi: o essi regolano collettivamente le loro azioni o essi, se restano reciprocamente indifferenti, saranno regolati da un sistema di dominio di alcuni uomini su altri (dominio diretto, amministrativo; o indiretto, economico, tramite il danaro, lo scambio, il mercato). O tutti ‘stanno bene’ o il malessere di alcuni diventa malessere per tutti, che la società borghese tenta di limitare aumentando all’infinito e senza prospettive carceri, manicomi, orfanotrofi, ospizi, case di correzione, ghetti, zone residenziali protette, pattugliamenti, controlli, guardie, assistenti sociali, preti, misure di annientamento dei ‘devianti’, lobotomizzazioni, castrazioni, psicofarmaci, terapie psicologiche, misure di condizionamento di massa, sottoculture. Perché il ‘nostro’ bambino abbia una vita felice, siccome della sua felicità e della sua vita fa parte la convivenza con altri bambini, bisogna che tutti gli altri bambini abbiano una vita felice; perché possa giocare, bisogna che altri bambini possano giocare, non serve coprire lui di giocattoli. Perché io abbia una vita sessuale felice, bisogna che chi mi è attorno abbia una vita sessuale felice;
2. dall’altra parte non abbia in comune con le comunità primitive nient’altro che il nome. Quelli che sognano il futuro con l’occhio al passato, che sognano di ritornare al ‘bel tempo antico’, di ricreare le ‘comunità umane’ come esistevano un tempo, che ripropongono le ‘comunità naturali’ dimenticano di quanta oppressione fossero intrise e di quale dura necessità fossero il frutto. La comunità del nostro futuro è essenzialmente basata sulle capacità di comunicazione, di conoscenza, di libertà, di dominio sulla natura e su noi stessi, di comprensione, di tolleranza e di abitudine alla trasformazione e al nuovo che gli uomini sono venuti acquisendo e che i limiti della società borghese impediscono di consolidare, espandere ed esplicare.
Tutte queste limitazioni che vengono via via poste alla natura di merce dei prodotti del lavoro e della capacità lavorativa degli uomini (aspetto della negazione) e i corrispondenti sviluppi di rapporti di solidarietà, collaborazione e interdipendenza consapevolmente regolata tra gli individui nella produzione e riproduzione delle condizioni materiali della loro esistenza (aspetto della costruzione-germi di comunismo) si collocano nel contesto del programma di transizione dal capitalismo al comunismo.
Di per se stessa la rivoluzione, la mobilitazione di masse di operai per l’annientamento della macchina statale borghese e la costruzione di una nuova macchina statale, produce già alcuni inevitabili mutamenti anche nei rapporti di produzione e nel processo lavorativo immediato. Gli operai vittoriosi non accettano più il vecchio sistema di obbedienza cieca, di sottomissione, di indifferenza rispetto al che cosa produrre e come produrlo, di rapporto unicamente salariale (‘quello che mi importa è solo quanto mi pagano’), di esclusione dalle decisioni sull’impiego del prodotto, di predominio assoluto della valorizzazione del capitale, che costituisce la manifestazione della condizione operaia nel vecchio regime. Non accettare questo è modificare i rapporti di produzione. Sviluppare questa non accettazione (estenderla a più operai, approfondirla ad altri aspetti, farla passare da atteggiamento prevalentemente negativo del vecchio a atteggiamento costruttivo del nuovo), è combattere per la trasformazione dei rapporti di produzione. Ogni forma di relazione sociale si fissa in istituzioni storicamente determinate (e transitorie quindi): le nuove relazioni che si stabiliscono tra gli individui nella produzione devono trovare le istituzioni appropriate al loro esistere e consolidarsi e trasformarsi; ad ogni modificazione delle relazioni deve corrispondere la modificazione delle istituzioni.
La transizione dal capitalismo al comunismo riguarda e trasforma però tutti gli aspetti della vita individuale e sociale degli uomini.
Quindi le misure enunciate sopra come esempio e volte al superamento del carattere di merce dei prodotti del lavoro e della capacità lavorativa umana, non sono che un aspetto delle profonde mutazioni che porteranno alla luce la società comunista.
La transizione al comunismo infatti:
1. comporta l’aggregazione delle forze motrici della transizione, la concentrazione di tutte le spinte alla trasformazione e quindi l’organizzazione degli individui che ne sono portatori: il partito e le organizzazioni di massa che hanno, a livelli diversi, il ruolo di concentrare, rendere organiche e operanti quelle spinte contro le resistenze attive e passive alla trasformazione. Ogni organizzazione ha il ruolo positivo di consentire la realizzazione dei compiti per cui è costruita e di creare così le premesse per ulteriori trasformazioni. Ha l’aspetto negativo ineliminabile di cristallizzare in una certa misura il diverso grado di sviluppo delle coscienze e delle volontà e di tendere a perpetuarsi oltre l’adempimento dei suoi compiti e quindi di perpetuare ed accrescere la diseguaglianza su cui è sorta. Per questo il bisogno di distruggere le organizzazioni è irrinunciabilmente connesso per tutta una fase storica al bisogno di crearle.
2. comporta la creazione di uno stato nuovo le cui caratteristiche nella tradizione del movimento operaio rivoluzionario sono sintetizzate nell’espressione ‘stato della dittatura del proletariato’. Stato perché è un organo di repressione contro la vecchia borghesia, contro i nuovi campioni della conservazione di rapporti mercantili-capitalistici il cui superamento è all’ordine del giorno, contro i residui dei rapporti sociali borghesi, benché già qui si differenzi dallo stato borghese, perché tratta le ‘contraddizioni in seno al popolo’ in modo e con scopi profondamente diversi da quelli dello stato borghese. Della dittatura del proletariato perché finché e nella misura in cui esisterà divisione in classi, esso attuerà misure dirette alla transizione dal capitalismo al comunismo e sarà emanazione del proletariato, avrà nel consenso e nella partecipazione del proletariato la base della propria legittimazione (così come lo stato attuale attua misure dirette a conservare il modo di produzione capitalista ed ha nella borghesia la base della propria legittimazione). Ma il parallelo finisce qui, perché la borghesia è una classe sfruttatrice che si perpetua perpetuando la divisione in classi e il connesso sistema di oppressione e dominio. Il proletariato è una classe sfruttata che vuole smettere di essere sfruttata, che resta sfruttata pur essendo la base della legittimazione del nuovo stato e quindi vuole porre fine alla divisione della società in classi, quindi estinguersi. Quindi anche lo stato della dittatura del proletariato deve tendere a estinguersi, a cessare di essere stato. Estinguersi dello stato che non significa lo scomparire di istituzioni generali, ma la scomparsa della repressione di classe e dell’organo a ciò preposto e la scomparsa della attività politica come professione di un gruppo distinto di individui.
3. comporta che le condizioni della produzione e della riproduzione (fabbriche, terre, mezzi di trasporto, uffici, negozi, attrezzature, materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti) siano socializzati, resi di possesso collettivo, in forme inevitabilmente varie e mutevoli. Quindi che non possano essere venduti, ceduti, lasciati in eredità, prestati dietro compenso tra individui, gruppi di individui o tra unità produttive. Che non possano essere creati, distrutti e usati che nell’ambito di disposizioni pubbliche che hanno la loro fonte nelle organizzazioni di massa e nello stato, come passaggio alla loro socializzazione completa che procede quanto procede la effettiva venuta all’esistenza della comunità reale degli uomini.
4. comporta la graduale eliminazione di confini di nazione, di paese e di stato. Inizialmente è inevitabile rompere in una certa misura la unità mondiale creata dal modo di produzione capitalista: volendo distruggere la forma in cui si è realizzata questa unità (lo scambio, il mercato, l’azione mondiale del capitale, l’oppressione fra stati, la dominazione nazionale, la discriminazione, la sopraffazione e il retaggio coloniale) è inevitabile che anche il contenuto in una certa misura sia scombussolato finché non trova via via la sua nuova forma di esistenza. Formazione di nuovi stati onde sgomberare il terreno dai residui dell’attuale sistema di oppressione nazionale, statalizzazione del commercio estero in ogni paese, trattati commerciali a lungo termine, cooperazione internazionale al di fuori di rapporti di scambio, ecc. fino alla creazione di una unica comunità umana unita nella collaborazione e nella solidarietà della dipendenza reciproca.
5. comporta la trasformazione dell’atteggiamento di ogni individuo nei confronti degli altri, la eliminazione (inevitabilmente per tappe) dei rapporti di dipendenza di alcuni dati individui da altri singoli individui; non per passare a una indipendenza e indifferenza reciproca di ogni individuo rispetto agli altri (che è una illusione reazionaria) ma per passare alla dipendenza reciproca e consapevole di tutti da tutti. Quindi i rapporti uomo-donna, bambino-genitori, invalido-sano, allievo-insegnante, non lavoratore-lavoratore, arretrato-avanzato verranno trasformati.
Una società dove cessa la lotta per realizzare queste trasformazioni, cessa di essere una società in transizione dal capitalismo al comunismo; siccome tutto è collegato e la transizione è la lotta tra due mondi, regredisce verso il capitalismo (quali che siano le spoglie nuove in cui si presenta).
In questo contesto, per avere le dimensioni del problema della transizione dal capitalismo al comunismo, bisogna considerare altri due fatti.
1. Che scompariranno via via tutte quelle attività che hanno la loro ragion d’essere a) nel rapporto di capitale e di valore che caratterizzano la società borghese (come ispettori del lavoro, sindacalisti, rappresentanti di commercio, ecc.); b) nella esistenza della divisione della società in classi e nell’oppressione di classe; c) nell’esistenza dello stato come monopolio della violenza e della coercizione; d) nell’assoggettamento degli individui alla divisione sociale del lavoro; e) nella divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale.
2. Che l’espletamento di una serie di attività individuali e collettive non potrà avvenire nella forma in cui si svolgono oggi e mantenere i limiti che ora le determinano non solo negativamente (esclusione di alcuni dalla funzione, impedimento al loro affermarsi: nella società borghese ogni individuo ha il diritto di far pubblicare un giornale, proprio solo perché ben pochi hanno i mezzi per esercitare effettivamente questo diritto), ma anche positivamente (ne consentono l’esistenza e lo sviluppo). Perché il carattere attuale è ineliminabilmente connesso con il rapporto di valore e di capitale che sono la regola di tutta la società. Tutto ciò che 1) è ‘diritto’ della società del lavoro salariato che non pone limiti legali e amministrativi allo svolgimento di certe attività proprio solo perché di fatto il limite al loro effettivo espletamento è determinato impersonalmente dai rapporti economici (nella società borghese, salvo i casi di emergenza sopra ricordati, non esiste obbligo legale al lavoro proprio solo perché i rapporti di proprietà sono tali che la maggioranza degli individui è obbligata a lavorare per sopravvivere); 2) che è regolamentazione dei rapporti tra i vari capitalisti, ma che essendo impersonale (il diritto borghese non riconosce discriminazione di classe a differenza dei diritti delle società feudali e schiaviste: la legge è uguale per tutti, proprio solo perché i rapporti di produzione sono tali che la legge eguale per tutti tutela la più assoluta diseguaglianza reale) apre spazi anche all’azione di individui di altre classi che resta però limitata o impedita dai rapporti reali: tutto quanto rientra in questo novero non può ovviamente trasporsi nella società di transizione dal capitalismo al comunismo. Da ciò si vede il ‘buonsenso’ di quei pubblicisti borghesi che ‘giudicano’ le società in transizione sul metro della realizzazione più o meno piena dei ‘princìpi’ della società borghese, della minore o maggiore estensione a tutti delle pratiche della borghesia.
Vediamo, solo ad esempio di ciò, la questione della libertà di stampa. L’esercizio di questa libertà da parte di un individuo comporta che egli possa comandare lavoro, disporre del lavoro di una serie di altri individui (produttori di carta, di macchinari, di inchiostri, di energia elettrica, ecc., stampatori, distributori, scrittori, ecc.) per sé stesso, usarlo secondo i propri intendimenti.
Lasciamo da parte per un momento le limitazioni di tipo culturale e di tempo che nella società borghese escludono la maggioranza degli individui dalla fruizione di questa libertà, dall’esercizio di questa attività (giustamente, anche senza avere coscienza del marchio schiavista che la cosa comporta, i borghesi parlano a proposito della stampa di ‘quarto potere’, evidentemente potere di alcuni individui su altri). Nella società borghese quel potere di comando sul lavoro di altri uomini al fine di stampare, esiste materializzato in un oggetto (il denaro) e si mostra come un potere del tutto impersonale: nel senso che non appartiene per diritto, consuetudine, tradizione, credenza, merito o capacità a un dato individuo piuttosto che ad un altro. Il danaro non è indissolubilmente associato ad un dato individuo né per nascita né per designazione, come lo era il titolo nobiliare nella società feudale che cessava di essere appannaggio di un individuo solo con la sua morte. Il danaro è di chi ce l’ha e chi ce l’ha può comandare lavoro altrui (diretto o già materializzato nei prodotti) per gli scopi che vuole. Tanto vero che chi ha danaro fa stampare una serie di minchiate, addirittura falsità e calunnie contro gli stessi stampatori, i lavoratori delle cartiere, ecc.(*)
(*) Ovviamente la premessa per l’esistenza di questo ‘portatore materiale’ del comando sul lavoro non è alcun potere magico insito nella natura del ‘portatore materiale’: le monete metalliche, i biglietti di banca, gli assegni bancari, le cambiali e le lettere di credito non sono talismani. La premessa è semplicemente che la capacità lavorativa esista come merce, cioè che esista almeno una quota rilevante di individui che vendono (sono costretti a vendere) la propria capacità lavorativa e che i prodotti del lavoro siano anche essi merci, cioè prodotti per essere venduti.
Che uno abbia danaro perché è un capitalista, oppure perché trova credito, oppure perché lo rapina, o perché eredita, o perché fa un ‘buon matrimonio’, o perché lo mette assieme tramite l’associazione del poco che ne posseggono più individui, la cosa non cambia: egli potrà comandare lavoro per il fine che vuole e nella quantità corrispondente al danaro di cui dispone, salvo i limiti extraeconomici, politici posti che impediscono espressamente ad alcuni individui di esercitare tale attività e consentono ad altri di esercitarla a spese d’altri (sussidi e contributi delle banche e delle pubbliche autorità agli editori ‘amici’). Ma tali limiti non possono essere posti universalmente e permanentemente, pena il negare l’esistenza stessa del rapporto di danaro e quindi provocare riflessi contraddittori in tutta la società: la società borghese ha bisogno e tende a porre tutto (tutti i prodotti, tutte le capacità lavorative e più in generale tutte le prestazioni di un individuo) come merce quindi acquistabile da chicchessia abbia danaro, cioè a porre il danaro come equivalente universale.
Se vogliamo superare il rapporto di merce, di valore, di danaro, di capitale, evidentemente distruggiamo, scombussoliamo le condizioni presupposte per un tale esercizio della libertà di stampa: la libertà di stampa non per una persona determinata o per un gruppo determinato di persone, ma per chiunque ha o riesce ad avere denaro.
Questa nostra azione ha un aspetto di negazione (misure dirette a negare il carattere preesistente, imposizione contro quello che è ‘sempre’ stato, coercizione nei confronti del singolo individuo a cui è negata l’attività pur avendo egli denaro) e un aspetto di costruzione positivo (in una società in cui il denaro ha ancora il ruolo, sia pure limitato perché alcune cose non sono più in vendita, di equivalente universale, nonostante ciò stampano i loro scritti individui che non hanno denaro; creazione di nuovi atteggiamenti, nuove abitudini, nuove prassi e istituzioni; mobilitazione e creatività dei singoli individui). I due aspetti sono dialetticamente uniti. Quanto più tutti di fatto scrivono, quanto più sono tolti i limiti all’espletamento di queste attività posti dalla divisione in classi e dall’assoggettamento della maggioranza degli individui al lavoro, tanto più occorre vengano elaborate nuove pratiche e rapporti che regolano l’esercizio delle libertà di stampa da parte di tutti.
In URSS e in generale quando il corso rivoluzionario si rovescia, quando la via al comunismo si rovescia in restaurazione del capitalismo, l’unità dialettica dei due aspetti si rompe. Il secondo viene cancellato, il primo permane ancora e diventa via via intollerabile oppressione e camicia di forza anche per i capitalisti. Tanto più intollerabile perché proprio l’inversione del corso crea esso stesso le premesse per rompere gli ‘aspetti di negazione’: nuova generalizzazione del carattere di merce dei prodotti del lavoro e delle capacità lavorative; il denaro riassume in pieno il suo ruolo di cemento principale della società che tutto acquista e tutto equipara, ruolo che era stato più o meno ampiamente limitato (a che serve avere le tasche piene di rubli se non posso spenderli? si lamentava il superpagato specialista dell’‘era staliniana’ che si sentiva truffato dall’alto salario che gli veniva concesso mentre nello stesso tempo gli venivano negati la capacità lavorativa altrui e i prodotti del lavoro altrui su cui il suo collega dei paesi capitalisti poteva usare il suo reddito o farlo fruttare trasformandolo in capitale); quantità cospicue di denaro si accumulano nuovamente nelle tasche di alcuni individui creando un potere d’acquisto (cioè di comando sul lavoro altrui) che trova ancora limiti al suo esercizio in quelle misure; la contrapposizione degli interessi da una parte viene riproposta come motore positivo della vita sociale, dall’altra anziché uno strumento di mediazione ‘impersonale’ come il danaro trova uno strumento di mediazione personalissimo come le misure amministrative.
È evidente come istituzioni, abitudini e misure create per superare il carattere di merce, possano facilmente trasformarsi in strumenti di oppressione di classe, in forme di ristabilimento dell’oppressione di classe sui lavoratori. Per restare all’esempio illustrato: la cancellazione del fatto che chiunque ha danaro può assumere giornalisti, stampatori, ecc. e comperare tipografie, carta, ecc. diventa proibizione ai lavoratori di riunire il loro danaro per esercitare libertà di stampa, se la cosa non è gradita a chi comanda; proibizione in generale della libertà di stampa per chi non è al comando.
Quanto detto per la libertà di stampa vale per vari altri diritti, attività e libertà borghesi: di associazione, di riunione, di spostamento, di non-lavoro, di ‘libera’ scelta del lavoro, ecc.
Consideriamo come secondo esempio la libertà di lavoro. Nella società borghese non esiste l’obbligo legale di un individuo ad un determinato lavoro, fatto osservare dallo stato o da altre organizzazioni armate, salvo che in alcune situazioni ‘particolari’ (mobilitazione militare; prigionieri e detenuti in carceri, manicomi, orfanotrofi, ecc.; alcuni ordinamenti coloniali; alcuni ordinamenti per lavoratori emigranti; ecc.). La regola della società borghese è che un lavoratore vende la propria capacità lavorativa liberamente (se vuole, a chi vuole, per il periodo che vuole, ecc.). Il corrispettivo naturalmente è che qualcun altro è libero di comperarla se vuole, da chi vuole e per il periodo che vuole.
Se la libertà del lavoratore di vendere la sua capacità lavorativa oltre che legale fosse anche reale, resterebbe incomprensibile come mai nella società borghese si trovano lavoratori disponibili per ogni lavoro retribuito, anche il più pesante, il più nocivo e il più infame. In realtà ogni lavoratore, chiunque non è proprietario di capitale o di rendite, deve vendere la propria capacità lavorativa se vuole mangiare; dove non basta questo sopravvengono le leggi contro il vagabondaggio e il parassitismo (dei non proprietari). La disoccupazione e la differenza salariale completano l’opera facendo sì che, ‘miracolosamente’, i lavoratori si distribuiscano ‘per libera scelta’ tra i vari settori lavorativi secondo le esigenze della società borghese, occupando tutti i posti disponibili.
Togliamo questa costrizione economica, supponiamo che i beni necessari alla normale vita di un individuo siano riconosciuti a ogni individuo come dovutigli per il fatto stesso di esistere e di far parte della società. Cosa farà sì, in queste condizioni, che ogni individuo non solo presti una congrua quota del lavoro necessario alla produzione e alla riproduzione delle condizioni materiali dell’esistenza, ma anche che vengano dedicate ad ogni settore lavorativo le quantità di tempo di lavoro necessarie in quel settore?
Evidentemente non più la miseria, la fame dell’individuo o delle persone a suo carico, ma un ordinamento e una pratica concordati e imposti tra i membri della società stessa. A questo punto nessuno è più libero, neanche formalmente, di lavorare o non lavorare, di lavorare in un settore piuttosto che in un altro, più di quanto questa libertà possa essere riconosciuta a ogni individuo. Quindi una libertà che potrà essere tanto più ampia quanto maggiore è la ricchezza della società, cioè la produttività del lavoro; cioè in altre parole, quanto minore è il tempo di lavoro necessario che complessivamente deve essere compiuto dalla società settore per settore; tuttavia una libertà che formalmente non sarà mai assoluta. Ma che in realtà sarà, per la stragrande maggioranza degli uomini, chiaramente più ampia di quanto sia per essi la libertà reale nella società borghese.
Vogliamo essere formalmente liberi, individuo per individuo, di lavorare se, quando e dove vogliamo? Dovremo accettare il corrispettivo: la reale schiavitù salariale per la maggioranza degli uomini e per la maggior parte della vita.
Da ultimo, ad evitare compiacenze verso il particolarismo, le illusioni piccolo-borghesi di poter fare le cose ‘in casa propria” e il velleitarismo sognante, occorre dissipare ogni equivoco sul fatto che la transizione dal capitalismo al comunismo non può che essere un fenomeno mondiale.
Non nel senso che in tutti gli angoli della terra si debba o si possa marciare allo stesso passo, compiere contemporaneamente le stesse trasformazioni, raggiungere contemporaneamente gli stessi obiettivi: perché gli uomini sono oggi (e questo è il nostro punto obbligato di partenza) collocati in situazioni sovrastrutturali (statali, culturali, di sviluppo del movimento rivoluzionario) diverse e in condizioni strutturali in parte anch’esse diverse, sia per sviluppo delle forze produttive che per rapporti di produzione: in un arco che va da economie ancora quasi di sussistenza di piccoli gruppi umani semi-isolati e semi-autosufficienti in condizioni di grande dipendenza dalla natura, a società completamente sussunte nel capitale, dove il rapporto di capitale è già esso stesso un cadavere che appesta l’aria.
Non nel senso che le varie società nazionali debbano e possano procedere mantenendo l’ordine reciproco creatosi nello sviluppo del modo di produzione capitalistico, per cui in testa gli USA, l’Europa e il Giappone, poi via via gli altri fino alla Liberia: il ché è da sempre lo schemino coltivato dagli opportunisti, parassiti del marxismo.
Ma nel senso che nell’epoca capitalista è stata creata, per la prima volta nella storia, l’unità reale degli uomini di tutto il mondo. Per la prima volta l’umanità ha cessato di essere una astrazione (ciò che di comune i vari individui mostravano all’osservatore), per diventare un concetto concreto: individui connessi tra di loro da rapporti da cui nessuno di essi può prescindere per la produzione e la riproduzione delle condizioni della sua esistenza.
Nei secoli passati un osservatore poteva concludere che un abitante della Grecia e un abitante della Polinesia erano entrambi uomini o perché ambedue bipedi implumi o perché ambedue dotati di parola o per qualsiasi altro accidente egli rilevasse eguale in entrambi; oppure poteva concludere che tra i due non c’era niente in comune, uno era uomo, l’altro qualcosa d’altro. Ma per l’abitante della Grecia l’abitante della Polinesia non esisteva e poteva benissimo essere sommerso dal mare e scomparire dalla faccia della terra per sempre senza che ciò si riflettesse in alcuna misura sulla sua vita; e viceversa.
Il modo di produzione capitalista ha realizzato invece, per la prima volta, un sistema in cui l’abitante della Grecia e quello di qualsiasi altra parte del mondo dipendono l’uno dall’altro per la produzione e la riproduzione delle condizioni materiali della sua esistenza; li ha uniti in una unica società; ha creato un rapporto tra i due necessario a ognuno dei due. Una moria di bestiame in Argentina attualmente produrrebbe effetti in tutto il mondo; alcuni sarebbero privati di carne per via dei prezzi più alti, alcuni venderebbero a prezzi più alti i loro prodotti, altri non li venderebbero affatto e altri a prezzo più basso; alcuni non vendendo non potrebbero ripetere la produzione; alcuni accumulerebbero fortune e altri miseria; speculazioni nelle borse-merci, ecc.
Effetti più o meno devastanti e più o meno fortunati si avrebbero in tutto il mondo. Questo legame fa essere un uomo, uomo per l’altro e crea l’umanità concreta.
In queste condizioni acquisite nessun gruppo di individui, società, nazione o paese può ‘procedere per conto suo’ oltre un certo e determinato limite. Le condizioni della sua esistenza dipendono in modo essenziale da quel che succede al di fuori di esso e dai suoi rapporti con l’esterno.
Attualmente gli individui di un paese A hanno con gli individui degli altri paesi B un rapporto mercantile e di oggetti: i cicli di produzione compiuti dagli individui del paese A non possono essere compiuti senza oggetti prodotti da individui di altri paesi B (e questo è un contenuto del processo di ricambio materiale della società, che in ogni momento è un dato di partenza per ogni iniziativa e trasformazione, indipendentemente dai rapporti sociali) e questi oggetti non saranno disponibili se gli individui di A non li possono comperare scambiandoli o con un equivalente generale (danaro internazionale) o con un equivalente particolare (un’altra merce): questo dipende dai rapporti sociali, mercantili e capitalistici vigenti negli altri paesi B e tra gli individui dei diversi paesi A e B.
I cicli di produzione compiuti dagli individui di A non potranno essere ripetuti se certi prodotti di questi cicli non saranno venduti (in quantità e a prezzi adeguati) in altri paesi B (questo dipende dai rapporti mercantili e capitalistici tra gli individui nello stesso paese A).
I rapporti tra gli individui di un paese A sono condizionati dai rapporti tra individui negli altri paesi B: se questi sono mercantili e capitalistici, anche i rapporti tra gli individui di A e gli individui di B saranno mercantili e capitalistici: per avere un oggetto dagli individui di B bisognerà scambiarlo (con moneta internazionale o altro oggetto determinato in quantità e prezzo); le condizioni in cui si potrà averlo dipenderanno dalle condizioni di mercato (andamento della produzione avvenuta, stato della domanda, speculazione); quello contro cui verrà scambiato sarà sottoposto a condizioni analoghe, per cui nel paese A si dovranno produrre dati oggetti e non altri, in date condizioni e non altre. Cioè appunto i rapporti tra individui nel paese A sono condizionati dai rapporti tra individui nel paese B.
Ogni paese esporta e importa non solo oggetti, ma anche rapporti sociali; cerca di adeguare i rapporti sociali vigenti negli altri paesi a quelli vigenti al suo interno oppure deve adeguare quelli interni agli esterni. Alcuni paesi esportano rapporti sociali, altri li importano e li subiscono.
Il capitalismo USA impone la ‘libera iniziativa individuale’ in tutto il mondo. Il capitalismo di stato sovietico impone il capitalismo di stato in tutto il mondo: una maggiore concentrazione del capitale, una maggiore regolamentazione amministrativa dei volumi della produzione, delle correnti di scambio, dei termini di scambio. Il capitalismo USA è fatto in modo che alcuni capitalisti americani trarranno profitto da ogni repentino mutamento economico che avviene in un altro paese perché negli USA il capitale è meno concentrato (altri capitalisti americani potranno anche perderci). Il capitalismo sovietico è fatto in modo da reagire con difficoltà (perché ha un grado più elevato di unità tra le sue parti) ai repentini cambiamenti esterni. La forma tipica dei rapporti esteri dell’uno è la contrattazione di borsa, la speculazione e il colpo di mano. La forma tipica dei rapporti esteri del secondo è il trattato commerciale a lungo termine (v. Nota 3 a pag. 77).
Non è per volontà diabolica di Andropov o di Reagan che vi è oggi una ‘politica imperialistica’, cioè di dominio e servitù tra stati. Ma perché ogni volontà e azioni di individui, diabolica o benefica, non può che esercitarsi nel contesto di una ormai raggiunta unità economica mondiale.
La forma, i rapporti entro cui si attua, esiste questa unità economica mondiale possono essere o capitalisti (di sfruttamento economico tra individui e di assoggettamento politico tra stati) o comunisti (di collaborazione reciproca). Ogni stato oggi o lotta per mantenere i primi o lotta per instaurare i secondi. Ma fare una cosa o l’altra non è scelta libera, politica, transitoria, fatta caso per caso da uno stato, perché è inevitabilmente legata alla natura di classe dello stato stesso.
Se uno stato mantiene rapporti di sfruttamento economico nel paese che domina, quindi è espressione degli sfruttatori nel paese, è inevitabile espressione dei loro interessi di sfruttamento anche all’estero (gli appetiti non conoscono limiti di frontiera statale). Se uno stato lotta per rapporti comunisti nel paese non può che lottare per tali rapporti anche all’estero, perché il progresso verso l’obiettivo all’interno è in definitiva condizionato dal progresso verso l’obiettivo nel resto del mondo.(*)
(*) È ovvio, per chiunque non sia un sognatore ma si impegni in un’attività politica concreta, che ciò non riassume tutta l’azione internazionale di un concreto stato socialista. Mentre l’avanzamento verso il comunismo in un paese è legato al suo verificarsi anche in altri, il concreto processo di ricambio materiale in un paese è legato a rapporti con il resto del mondo quale concretamente è; la sorte di uno stato socialista è legata anche a rapporti con gli altri stati quali concretamente sono. I compromessi sono all’ordine del giorno per chi lotta veramente per il comunismo. Onde si spiegano molte ‘anomalie’ dei rapporti interstatali: una ditta capitalista che fa affari con uno stato socialista che accetta e ricerca questo rapporto perché gli è necessario; uno stato borghese che stabilisce accordi con uno stato socialista che lo accetta e ricerca come mezzo per guadagnare tempo e impedire la coalizione (temporanea) degli stati borghesi contro di esso. Anche se ovviamente tutti questi compromessi hanno risvolti negativi (temporaneamente rafforzano anche la ditta capitalistica e lo stato borghese contraenti non solo nei confronti delle altre ditte capitaliste e degli altri stati borghesi, ma anche nei confronti dei proletari che essi sfruttano e dominano). Combinare sostegno al movimento rivoluzionario in tutto il mondo con lo sfruttamento delle contraddizioni tra borghesi è un’arte dei partiti e degli stati rivoluzionari.
Non vi possono essere relazioni internazionali basate sulla eguaglianza e la collaborazione, sul porre a priori l’unità mondiale come punto di partenza delle relazioni internazionali, quando protagonisti ed autori di queste relazioni internazionali sono i funzionari del capitale all’interno dei singoli paesi. Il capitale esprime all’interno del paese il suo bisogno vitale di accumulazione, di profitto, di crescita: esprime lo stesso bisogno anche nelle relazioni internazionali. Ogni volta che un borghese parla di unità mondiale e ordine mondiale, inevitabilmente intende sottomissione ordinata di tutto il mondo ai suoi affari.
In conclusione una politica interna di conservazione dei rapporti capitalistici non può non tradursi, nelle condizioni ora raggiunte dall’umanità, in rapporti di dominio e servitù tra stati. Una politica interna di rivoluzionamento dei rapporti di produzione non può non tradursi in una politica estera rivoluzionaria.
I rapporti che una nazione, un paese, uno stato ha con l’esterno sono determinati dai rapporti che vigono tra gli individui al suo interno. Se questi sono rapporti di scambio, di capitale, anche i suoi rapporti con l’esterno lo saranno. Un capitalista americano che dà grano agli abitanti dell’Egitto senza esigere e ricevere una contropartita economica (un altro valore di scambio), non sarà più in grado di produrre nuovo grano perché egli deve a sua volta comperare le condizioni che gli consentono di rinnovare la produzione (oltre che rovinare il capitalista egiziano produttore di grano che troverà diminuiti i suoi acquirenti, cioè in pratica condannare alla indigenza e al pauperismo anche quei braccianti e contadini egiziani che fino allora erano vissuti grazie al fatto che il grano da essi prodotto aveva acquirenti).
Nell’unità mondiale creata dal modo di produzione capitalista vi è un contenuto (la dipendenza reciproca tra gli individui nella produzione e riproduzione delle condizioni materiali della loro esistenza) e una forma (i rapporti secondo i quali, nell’ambito dei quali questa dipendenza si attua). Anche in questo ambito contenuto e forma costituiscono una unità contraddittoria.
Consideriamo ad es. la questione delle materie prime minerali o vegetali. Stante la forma mercantile e capitalista delle relazioni economiche internazionali, ogni gruppo di capitalisti cerca di assicurarsi il monopolio delle materie prime per ricavarne il massimo profitto diretto o indiretto. Stante il contenuto del processo produttivo, senza alcune materie prime che provengono dalle parti più svariate del mondo, allo stato attuale della tecnologia in nessun paese il processo di ricambio materiale della società può procedere regolarmente.
Allora controllare gli stati dei paesi da dove provengono le materie prime diviene un obiettivo ‘vitale’ sia economico che politico. Ogni mutamento politico di un qualche rilievo in questi paesi, suscettibile di alterare il flusso esistente delle materie prime e il reciproco flusso di altre merci, ha ripercussioni politiche ed economiche che alterano i rapporti reciproci di forza sia tra le singole imprese capitalistiche che tra gli stati. E quindi ogni mutamento politico di uno di questi stati è combattuto da alcuni e favorito da altri, diviene oggetto di conflitto tra imprese capitalistiche e tra stati.
L’esigenza del ricambio materiale della società fa sì che si presentino come ‘oggettivamente’ necessari, indipendentemente dalla forma dei rapporti di produzione, misure di dominio e di sfruttamento atte a garantire la continuazione delle relazioni economiche mondiali rese precarie e rotte proprio dalla forma dei rapporti di produzione. E questo retroterra di relazioni economiche antagoniste alimenta e si nutre di tutti gli antagonismi sovrastrutturali vecchi e nuovi (culturali, razziali, nazionali, politici, religiosi, ecc.).
La guerra è il sostitutivo di uno stato mondiale: con la guerra il borghese impone nel mondo l’ordine che all’interno delle frontiere di un paese impone con lo stato.(*)
(*) Qui non ci interessa una teoria delle cause delle guerre in generale. Gli uomini facevano la guerra assai prima della comparsa del capitalismo, verissimo. È altrettanto vero che in ogni contesto sociale concreto, gli uomini facevano la guerra per specifici motivi legati a quel contesto sociale. Una teoria delle cause della guerra che pretenda di trovarle indipendentemente dalle condizioni concrete e specifiche della società in esame, non può essere che una sciocca e arbitraria immaginazione; infatti ve ne sono per tutti i gusti: dal peccato originale alle macchie solari. Pretendere di capire le cause di una cosa senza considerare le cause della cosa, porta al massimo alla descrizione superficiale della cosa. Quello che noi affermiamo è che le cause di guerra nel mondo capitalista sono diverse dalle cause di guerra nel mondo primitivo o nel mondo feudale; che queste cause di guerra proprie del mondo capitalista scompariranno con esso; che non sopravviveranno ad esse altre cause di guerra, come non sopravviveranno altre forme di sfruttamento e di oppressione.
Il modo di produzione capitalista (come già detto) ha creato una relazione ineliminabile e ineludibile tra miliardi di uomini, ma nello stesso tempo fa di questa reciproca dipendenza una fonte di miseria e di impotenza. Se un qualche accidente impedisce ad es. ai minatori cileni di produrre la normale quantità di rame, non si avrà solo una momentanea carenza di rame (a cui eventualmente si sopperisce attingendo a delle scorte opportunamente predisposte), ma i minatori resteranno anche privi di grano e di vestiti che pure sono stati prodotti in quantità normali; i produttori di grano e vestiti si troveranno anche loro incasinati perché i loro prodotti resteranno invenduti; a loro volta anch’essi non potranno fare gli acquisti che normalmente fanno e anche i loro fornitori resteranno incasinati e così via. L’accidentale e momentanea interruzione della produzione in un punto diventa così, a causa del rapporto di valore e di capitale, impossibilità della riproduzione, in una cerchia teoricamente estendentesi a tutto il mondo (in realtà nella società borghese sono state sviluppate istituzioni e pratiche - il credito, l’intervento statale, la politica delle scorte, le associazioni capitalistiche - che in una certa misura attenuano e contengono le ripercussioni del fatto).
Trasformare questa dipendenza da cieca sottomissione in consapevole cooperazione è una necessità; d altra parte richiede uno sconvolgimento tale di abitudini, modi di fare, idee, costumi, relazioni consolidate, interessi e privilegi costituiti, ecc. che non può essere effettuato se non attraverso un periodo storico di rinnovati sconvolgimenti rivoluzionari, un periodo di lotte e imposizioni con metodi rivoluzionari (dittatura del proletariato).
Da tutto ciò risulta chiaro che la trasformazione dei rapporti di produzione tra gli individui membri di una particolare società non può che procedere in rapporto con la trasformazione dei rapporti tra essi considerati come un tutto unico e il resto del mondo e quindi con la trasformazione dei rapporti di produzione tra gli individui che compongono il resto del mondo.
Negare il bisogno del partito del proletariato rivoluzionario e dello stato durante il periodo della transizione dal capitalismo al comunismo, significa non capire cosa è il rapporto sociale di valore, base ineliminabile del rapporto di capitale. Esso non è una imposizione legale, che può essere tolta con un semplice atto di forza, con un decreto sia pure sostenuto dalla ‘autorità’ di corpi armati decisi a farlo rispettare a un numero relativamente ridotto di oppositori. Ma è un modo di vita e di rapportarsi degli uomini tra di loro, su cui si sono modellati gli uomini stessi - senza beninteso fare parte di alcuna fantasiosa ‘natura umana’ come hanno sostenuto e sostengono tanti apologeti del capitalismo e del ‘libero mercato’ che amano sorvolare sul fatto che questo rapporto così ‘naturale’ si è imposto tra gli uomini in secoli di ferro e di fuoco, all’insegna della forca e della ghigliottina, con guerre e migrazioni nel corso dei quali interi popoli, evidentemente poco dotati di quella misteriosa ‘natura umana’, sono stati completamente sterminati.
Il rapporto di valore ha determinato una unità sociale raggiunta, una dipendenza universale degli individui l’uno dall’altro per la produzione delle condizioni materiali della loro esistenza, realizzata ma non assunta a base del loro agire e determinarsi. Il processo fino alla assunzione di questa interdipendenza come inizio dell’agire, fino quindi al raggiungimento di una direzione consapevole degli uomini sulle loro stesse relazioni sociali, non può che iniziare nelle condizioni acquisite della società borghese e quindi da condizioni di frantumazione e divisione tra gli individui e nei singoli individui (ogni individuo concreto è sintesi di molte determinazioni formali contraddittorie, svolge nella società borghese ruoli contraddittori: venditore di capacità lavorativa, compratore di altre merci; sfruttato dal capitalista come lavoratore, agente dello sfruttamento capitalista in quanto trasmettitore ad altri lavoratori degli ordini e della disciplina del capitale; ecc.). Questo processo richiede quindi necessariamente anche la rottura e la distruzione, in dialettica con la costruzione. Un processo quindi anche doloroso, lungo e lacerante, che richiede l’accumulazione delle forze motrici della trasformazione, cioè il partito, lo stato e le varie organizzazioni delle masse (e la loro demolizione e sostituzione man mano che esauriscono la loro funzione propulsiva). Non si tratta di questioni di ‘ingegneria politica’ o di ‘ingegneria costituzionale’ come la mettono tutti quelli che si sono sgolati e si sgolano su questioni come: separazione del partito dallo stato, divisione dei poteri, ecc. Si tratta di promuovere ed attuare un movimento sociale, di creare gli organismi e le istituzioni necessarie a realizzare una tappa della trasformazione e di demolirli e sostituirli quando questi, formatisi sui compiti di quella tappa e avendo riunito in sé il potere necessario al suo compimento, diventano, grazie a questo stesso potere, un ostacolo alla promozione del movimento sociale teso alle tappe successive di cui essi stessi hanno creato la possibilità.
In definitiva la cosa più ovvia, più ‘spontanea’ che può avvenire dopo una rivoluzione, è la costruzione di una nuova società borghese: non solo con altri uomini al comando ma anche con caratteristiche nuove (che in qualche modo negano alcuni caratteri della precedente società borghese, che rappresentavano una necessità ma anche un limite del capitale nella concreta formazione sociale precedente - così ad esempio la restaurazione capitalista in URSS non reintroduce la rendita fondiaria assoluta e tanto meno la proprietà fondiaria nobiliare).
La società borghese genera e rigenera per così dire spontaneamente la ribellione contro sé stessa, ma non crea la nuova società e i nuovi uomini.
La ‘spontaneità’ e facilità di questa riproduzione di società borghese sono tanto maggiori quanto meno sviluppato è nella società il rapporto capitalistico; quanto meno nettamente proletaria è la rivoluzione nei suoi compiti sociali; quanto meno si è sviluppato nella società l’antagonismo proletariato-borghesia. La rivoluzione politica del proletariato nell’epoca imperialista è più facile dove il capitalismo è meno sviluppato, la riproduzione della società borghese dovrebbe essere meno facile dove il capitalismo è più sviluppato.
Gli individui attivi, creativi non per soldi, per guadagno, gli individui che sono consapevoli di non poter affermare alcunché se non attraverso il collettivo, questi individui esistono, questi caratteri esistono nelle pieghe della società borghese; rappresentano in forma concentrata il germe dal cui sviluppo crescerà la società comunista. La società borghese con le sue contraddizioni, le devastazioni e le possibilità che contiene, genera inevitabilmente, in misura e tempi diversi da individuo a individuo, slanci e spinte di questo genere in milioni e milioni dei suoi schiavi salariati e persino in qualche individuo delle classi dominanti; gli individui in cui questi slanci e queste spinte diventano pratica attiva e in qualche misura duratura sono il prodotto concentrato della lotta delle masse proletarie contro il modo di produzione capitalista, frutto di questa lotta e contemporaneamente fattore propulsivo della stessa e fattore concentrato del salto di qualità della stessa, da lotta prevalentemente di resistenza a lotta per il superamento del modo di produzione capitalista e la creazione della società comunista. Ma essi sono lungi dal costituire tutte le forze che la società borghese suscita contro sé stessa, forze solo grazie alle quali e con lo sdoppiamento delle quali (cioè con lo sviluppo della contrapposizione di quanto in esse vi è di antagonista al capitalismo a quanto in esse rappresenta solo un normale contrasto in seno alla società borghese) la società borghese in generale, e non un particolare assetto di società borghese, sarà superata; ma che possono anche, non sdoppiandosi, riprodurre semplicemente un nuovo assetto di società borghese.
Molte forze rivoluzionarie nell’epoca imperialista contengono oggettivamente e inevitabilmente aspetti contraddittori. Ad es. nei movimenti antimperialisti di liberazione nazionale convivono inevitabilmente la negazione del modo di produzione capitalista che produce la condizione sociale in cui si trovano questi paesi e la negazione solo del particolare assetto attuale dei rapporti imperialisti nel quale il determinato paese, e quindi anche la sua attuale classe dominante, occupano una posizione arretrata. Lo stesso si verifica per molti strati sociali delle metropoli imperialiste, strati che subiscono sia le conseguenze del modo di produzione capitalista sia gli effetti della loro particolare collocazione all’interno della formazione economico-sociale concreta; collocazione il cui cambiamento non è incompatibile teoricamente con il permanere del modo di produzione capitalista nella formazione economico-sociale stessa: v. ad es. gli strati intellettuali dell’Europa Orientale, i movimenti poujadisti e in generale della piccola borghesia nella Europa Occidentale, i movimenti nazionali e razziali negli USA.
La società comunista può sì sorgere solo sulla base delle condizioni create dal capitalismo, non però al modo in cui si immaginano gli evoluzionisti - come traboccare più o meno tumultuoso o pacifico del capitalismo al pieno del suo sviluppo nel comunismo. Essa sorgerà come crescita ed estensione a tutta la società di qualcosa che le condizioni della società borghese hanno fatto nascere, del cui sviluppo hanno creato la possibilità, ma che nello stesso tempo reprimono e soffocano: come una donna che ha generato in sé un nuovo individuo, ma non vuole che nasca perché la sua nascita sarà la sua morte. Anche la società borghese in Europa non è sorta per sviluppo del feudalesimo maturo, ma per sviluppo (in date condizioni favorevoli) di quei rapporti mercantili e capitalistici che erano nati nelle pieghe della società feudale, che la società feudale alimentava ma di cui nello. stesso tempo impediva e reprimeva l’espansione.
Da tutto questo stato presente delle cose risulta evidente la necessità del partito, delle organizzazioni di massa e dello stato per un periodo di lunghezza imprecisabile (ma non indefinita né arbitraria, essendo definita dalla trasformazione dei rapporti sociali realizzata) dopo il rovesciamento della borghesia, cioè dopo che il processo di trasformazione sociale ha raggiunto quel salto di qualità che è la conquista del potere politico da parte del proletariato, conquista che è l’inizio della transizione dal capitalismo al comunismo.
Partito e organizzazioni di massa sono del resto necessari anche per la preparazione e realizzazione di questo salto, a causa dello sviluppo ineguale (delle coscienze, delle attitudini e delle capacità) che la società borghese determina spontaneamente e volutamente nelle file del proletariato, per cui questo esiste come classe-per-sé solo nel suo partito e nelle sue organizzazioni di massa e solo attraverso il suo partito e le sue organizzazioni di massa è in grado di costituire il suo stato. Partito e organizzazioni di massa che sono lo strumento indispensabile per concentrare le forze rivoluzionarie del proletariato e svilupparle; che sono le istituzioni in cui il proletariato non esiste più solo come unità oggettiva posta dalla borghesia ma come unione consapevole di individui; che sono strumento indispensabile per resistere alla controrivoluzione preventiva della borghesia.
La controrivoluzione preventiva è la caratteristica fondamentale della politica della borghesia in tutti i paesi,il fondamento della politica della borghesia in tutti i paesi,il fondamento unitario della attività politica, culturale, sociale, militare e scientifica della borghesia in tutti i paesi a partire dall’inizio dell’epoca dell’imperialismo e delle rivoluzioni proletarie vittoriose (inizio di questo secolo). Con l’aprirsi di quest’epoca la borghesia ha acquisito la coscienza non solo del pericolo che il proletariato rappresenta per essa, ma della difficoltà o impossibilità di soffocare un movimento rivoluzionario già diventato di massa (v. la controrivoluzione in Russia negli anni 1917-1921) e quindi della necessità di prevenire il suo sviluppo. Prima di questa data tutta la attività politica, culturale, sociale, militare e scientifica della borghesia era fondamentalmente diretta allo sviluppo del capitale (e quindi alla liquidazione dei residui dei modi di produzione che hanno preceduto quello capitalista). Dopo questa data tutta l’attività borghese è fondamentalmente diretta a conservarsi e a impedire il coagularsi delle forze motrici della rivoluzione proletaria (solo se si capisce questo, diventano chiari nella loro razionalità tutti i vari e contraddittori movimenti politici, sociali e culturali di questo secolo).
Anche se ciò urta contro il perdurante, perenne bisogno del capitale di crescere. Per cui la conservazione dell’esistente assetto capitalistico ostacola la crescita del capitale e diventa una contraddizione anche al suo interno. Un esempio: il sistema di dominazione coloniale ebbe un grande ruolo in una prima fase di sviluppo del capitalismo europeo. Ma, a causa dello sviluppo ineguale del capitale, ne divenne un ostacolo. I profittatori del dominio coloniale, il cui potere, benessere, sfruttamento e arricchimento avevano assunto forme definite, divennero un impedimento all’ulteriore sviluppo del capitale. La creazione di nuovi stati indipendenti in Africa e in Asia ha ad esempio posto le basi per uno sviluppo della domanda di merci, creato la cornice per nuovi investimenti contribuendo così a rendere possibile il venticinquennio di nuovo rigoglio del sistema di produzione capitalista che ha seguito la 2a Guerra Mondiale. Ma la distruzione del vecchio sistema coloniale, questo ‘taglio di rami secchi’ che ha favorito la nuova (effimera) fioritura, fu ostacolato in ogni modo dal sistema imperialista mondiale per la distruzione di interessi capitalisti costituiti e lo sconvolgimento generale che esso comportava e il potenziale pericolo di distruzione del sistema capitalista in generale che ciò conteneva. La borghesia è, nell’epoca imperialista, conservatrice, suo malgrado, anche dei limiti che la soffocano perché in ogni sconvolgimento politico e sociale sente, giustamente, la possibilità dell’inizio della sua fine incombente.
In concreto, stante una serie di accidentali situazioni soggettive, i grandi sconvolgimenti politici del periodo 1915-1945 e la successiva decolonizzazione liberarono il campo dai vecchi ostacoli e contribuirono, assieme alle enormi distruzioni realizzate in Europa, ad aprire lo spazio per i 20-30 anni di ricostruzione e crescita del capitale, il boom 1945-1975, che sono terminati in questi anni per dar luogo ad una nuova epoca di crisi generale e di sconvolgimenti politici e sociali, di guerra e di rivoluzione.
L’attività controrivoluzionaria della borghesia continuerà anche dopo il suo rovesciamento politico in qualche paese. Noi diciamo spesso ‘i lavoratori’, ‘il proletariato’, ‘il popolo’ per indicare i protagonisti della rivoluzione, della conquista del potere politico, della transizione dal modo di produzione capitalistico al comunismo. Ciò va inteso in modo dialettico, come cosa in divenire, altrimenti diventa un’assurdità: se con ciò intendessimo tutti i lavoratori, tutti i proletari, tutto il popolo non si capirebbe su quali forze conti la borghesia per conservare il suo potere e per restaurare il suo dominio, essendo vero che ‘il popolo unito non sarà mai vinto’. In realtà i lavoratori,il proletariato, il popolo sono concetti teoricamente ben definiti nella loro esistenza oggettiva. Soggettivamente mai tutti i lavoratori, tutti i proletari, tutto il popolo sono uniti nel perseguimento dei loro interessi sociali e politici. Questo è una inevitabile conseguenza delle condizioni di oppressione di classe in cui i lavoratori, i proletari, il popolo sono posti. È inevitabile che una parte dei lavoratori, dei proletari, del popolo persegua gli interessi di tutti i lavoratori, di tutti i proletari, di tutto il popolo; una parte si lasci manovrare dai propri oppressori; una parte si collochi tra le due. Non fare i conti con questa realtà, nella preparazione della rivoluzione, nella conquista del potere e dopo, nella fase di transizione dal capitalismo al comunismo, vuol dire rinunciare ai compiti rivoluzionari. In ogni situazione esiste una sinistra, un centro e una destra. La borghesia ha e avrà per un periodo indefinito una base per le sue manovre controrivoluzionarie al nostro interno, tra i lavoratori, tra i proletari, nel popolo. L’arte di dirigere, organizzare, comandare, sfruttare i difetti degli individui, le loro ambizioni e le loro bramosie,(*) la conoscenza degli strumenti del potere e delle modalità del loro impiego, tutto questo è gran parte della ‘politica’ come attività separata dalle altre attività umane ed è concentrato nella classe attualmente dominante, è attività di uomini alienata alla maggior parte di noi che la subiamo.
(*) ‘...È indispensabile che coltiviamo l’immaginazione di questi popoli asserviti, ed in generale quella dei politicanti ed affaristi locali con i quali abbiamo da fare, orientandola verso l’idea di grandezza. L’osservazione e lo studio accurato ci consentono di essere certi che costoro, indeboliti dall’alcool, sono assoggettabili ai nostri bisogni e alle nostre direttive. Generalmente questi (politicanti ed affaristi) come quelli (popoli asserviti) sono privi di convinzione e di carattere e sono privi di qualsiasi patriottismo ed ambiscono solo al prestigio e agli onori, che una volta ottenuti, noi gli sapremo far apprezzare…’
Anno 1912. Lettera di un rappresentante della United Fruit Co. in America Centrale all’avvocato della stessa compagnia.
Pensare che questo sia cancellato di colpo con una nostra vittoria, con la distruzione dello stato borghese e la costituzione del nostro stato, che questo patrimonio di difesa e offesa non sia impiegato dalla classe spodestata è miopia; non tenerne conto è avventurismo. Pensare che una classe (il proletariato) possa reprimere altre classi senza esercitare una certa misura di repressione anche al suo interno è una pia e pericolosa illusione: senza un certo grado di disciplina al suo interno, nessuna classe riesce a reprimere un’altra (chi rifiuta una cosa di fatto rifiuta anche l’altra); pensare che questa disciplina necessaria sia di colpo, in ogni individuo e in ogni circostanza, frutto solo della sua coscienza di classe è ipocrisia o vivere tra le nuvole.
«È ovvio che il grado di violenza che comporta la soluzione (del passaggio dal capitalismo al comunismo) dipende dalla resistenza che essa incontra e dal tempo durante il quale il problema (del passaggio) ammuffirà senza soluzione» (K. Marx). Marx a suo tempo accennò allo sviluppo delle cooperative di produzione e di consumo come alla via più pacifica e civile, se possibile, di passaggio dal capitalismo al comunismo. Ma la possibilità di un passaggio pacifico e ‘civile’ dal capitalismo al comunismo è stata storicamente bruciata e smentita dalla borghesia: nel massacro di decine di migliaia di Comunardi (1871); nella furibonda guerra civile e aggressione internazionale contro la repubblica dei Soviet (1917-1921) e nei ripetuti e articolati tentativi di soffocamento economico e militare dell’URSS; nelle sanguinarie repressioni delle rivoluzioni proletarie in Germania, in Ungheria, in tutti i paesi dell’Est dove dopo la 1a Guerra Mondiale si formarono governi rivoluzionari; nel terrorismo di massa dei governi fascisti e nazisti (compresa la guerra di Spagna); nelle repressioni coloniali spinte fino al genocidio (Libia, Etiopia, Africa Australe, Cina, ecc. tra le due guerre mondiali, Vietnam, Filippine, Kenya, Algeria, Guinea, Angola, Mozambico, Congo, ecc. dopo la 2a Guerra Mondiale); nelle eliminazioni di massa erette a sistema di mantenimento dell’ordine sociale (Indonesia 1966, Sudan 1968, Guatemala 1954, Cile 1973, Argentina 1976, Nicaragua, Salvador, ecc).
Storicamente è dimostrato che la borghesia nazionalmente e internazionalmente è disposta, pur di non ‘passare la mano’, ad ogni genere di violenza, di massacro, di distruzione, senza limiti di qualità e di quantità.
Dopo questa dimostrazione storica che si estende nell’arco di più di 100 anni, venire ancora a ventilare la possibilità di una transizione pacifica o quasi, tranquilla, ‘civile’, una transizione graduale, in cui la classe dominante si rassegna all’ineluttabile senza ricorrere ai mezzi più estremi (con un processo del tipo di quello per cui alcuni stati colonialisti si rassegnarono alla indipendenza politica delle colonie quando la lotta contro la dominazione coloniale raggiunse un certo livello, senza arrivare a mettere a ferro e a fuoco il paese e a stermini di massa), ventilare tale passaggio vuol dire scambiare sogni per realtà; vuol dire mancanza di determinazione nella lotta; vuol dire azione psicologica a favore del mantenimento dell’ordine sociale borghese; vuol dire avventurismo per cui si portano le masse lavoratrici al massacro e alla sconfitta; vuol dire indurre al disarmo gli oppressi proprio in una situazione in cui, grazie alla mercificazione della capacità lavorativa, allo sviluppo della produttività del lavoro, alle guerre e agli sconvolgimenti sociali in atto, le classi dominanti e i loro stati sono in grado di assoldare e assoldano quanti mercenari vogliono.(*)
(*) La propaganda pacifista, l’educazione alla non-violenza è cosa sacrosanta se rivolta contro la politica di preparazione alla guerra degli stati borghesi, se rivolta alle potenziali zone di reclutamento della borghesia. È cosa iniqua se volta a disarmare, a togliere spirito combattivo alle classi e ai popoli oppressi in una situazione in cui comunque la borghesia, grazie al denaro, alle stesse convulsioni politiche e militari delle società borghesi, all’aumento della produttività del lavoro e alla espulsione di milioni di individui del lavoro produttivo, può reclutare quanti sgherri e professionisti dello sterminio vuole. Non abbiamo bisogno di educarci alla non violenza, ma di imparare a combattere e combattere non perché mandati alla morte dalla pistola di ordinanza dell’ufficiale o dal plotone di esecuzione o dalla sottomissione gerarchica o ideologica alla classe dominante, ma solo per una causa giusta. Questo è il succo del nostro pacifismo: combattere e combattere solo per una causa giusta. Perché è solo da ciò che può sorgere non servile e piagnucolosa sottomissione di masse imbelli ai loro dominatori e la rassegnata partecipazione alle attività militari scatenate a questi, ma una comunità di uomini che, non dovendo più combattere per strappare ad altri ciò di cui vivere, non avrà più bisogno di guerre.
In questa fase storica non c’è via di mezzo: o una lotta furibonda contro la borghesia, la cui ferocia e il cui livello di distruzione sarà tanto minore quanto più noi avremo riunito condizioni favorevoli per schiacciare rapidamente e totalmente gli stati borghesi e in generale i corpi militari della borghesia; oppure subire tutte le conseguenze della sopravvivenza del dominio borghese alla sua ‘legittimità’ storica, tutte le conseguenze della decadenza della borghesia e del suo ordine sociale (monopolio, guerra interimperialista, crisi, ‘imbarbarimento’ dello stesso ordine sociale borghese).
Nella fase di transizione, finché il passaggio dal capitalismo al comunismo non sarà una fase storica conclusa, finché sarà un compito sociale in attuazione, i rapporti di capitale e di valore ancora in parte esistenti tra gli uomini avranno i loro sostenitori e i loro difensori: perché i rapporti sociali non sono individui o entità materiali a se stanti, ma relazioni concretamente intrattenute da uomini con altri uomini. Questi sostenitori e difensori sono la nuova borghesia. Ad ogni concreta tappa della transizione, la lotta tra il nuovo e il vecchio è lotta tra la borghesia e il proletariato. La borghesia non è costituita solo dai residui delle vecchie classi dominanti, i loro agenti, i sabotatori, le spie, i profittatori, i corrotti, ecc., ma (come diceva Mao) è nel partito e nello stato. A ogni nuova tappa della transizione la società si divide in due; ciò che è venuto maturando nel periodo precedente ad un certo punto diventa incompatibile con l’ordine fino allora vigente e lo deve rompere. Quegli individui che sì ergono a difesa di quell’ordine, che si sono immedesimati in esso fino diventarne personificazione (e una parte di essi è per forza di cose nel partito e nello stato), sono la reale borghesia nella situazione concreta.
Noi sosteniamo che nella società borghese attuale vi sono accumulati le premesse, gli strumenti e la possibilità per la liberazione degli uomini dall’asservimento alla divisione del lavoro e per la liberazione in grande misura dallo stesso lavoro necessario alla produzione e riproduzione delle condizioni materiali della vita della società (la ‘riduzione della giornata lavorativa’, ‘lavorare meno, lavorare tutti’). Vi sono accumulati pure gli strumenti, le premesse e le possibilità di una socialità più ricca e intensa, della comunicazione tra gli uomini, della comunità reale. Vi sono accumulati pure gli strumenti, le premesse e le possibilità di una individualità più ricca e multiforme, capace di maggiore creatività, godimento e attività. La trasformazione di questa possibilità in attualità è il comunismo. Questo traccia una discriminante tra noi e i sostenitori, i protagonisti e gli ammiratori del ‘socialismo reale’.
Contemporaneamente affermiamo che l’umanità si dibatte ancora e si batte ancora per l’affermazione dei bisogni più elementari (cibo, abitazione, vestito, salute, contro la disoccupazione, l’ignoranza e la superstizione, la fatica e l’inquinamento, ecc.) e che, se non assumiamo questa lotta come la nostra, guardiamo la realtà con gli occhi miopi e sazi della aristocrazia proletaria dei paesi imperialisti; ci condanniamo alla sterilità politica e a scontrarci in condizioni di debolezza con la crisi economica del capitalismo e la guerra; collaboriamo, al di là delle nostre intenzioni, alla creazione delle premesse per l’asservimento dell’aristocrazia proletaria alla borghesia in un blocco diretto contro la maggioranza dei lavoratori dei paesi imperialisti e contro i lavoratori e le masse oppresse del terzo mondo. Questo traccia una discriminante tra noi e le correnti culturali e le organizzazioni politiche influenzate dalle teorie operaiste e sostenitrici delle teorie dei ‘nuovi bisogni’ riassumibili in quanto Naria dice nel cap. 7 del suo scritto: «Nelle metropoli non sono i bisogni della miseria che muovono, ma è la ricchezza del bisogno di rapporti sociali, umani, a creare il movimento».
I paesi del ‘socialismo reale’ (*) sono la negazione della transizione al comunismo non tanto per il loro stato attuale, quanto per le tendenze di sviluppo in corso.
(*) Le considerazioni sui ‘paesi del socialismo reale’ svolte qui di seguito e in generale in questo scritto riguardano l’Unione Sovietica e le Democrazie Popolari dell’Europa Orientale, per quanto le relazioni sociali e gli ordinamenti di questi paesi siano tra di loro tanto diversi che solo l’ignoranza e l’asservimento dei nostri scribacchini di regime all’imperialismo americano li possono presentare come un tutto uniforme. Le considerazioni invece non valgono per la Repubblica Popolare Cinese dove una serie di grandi mobilitazioni di massa e in particolare la Rivoluzione Culturale Proletaria hanno affrontato con alterne vicende gran parte delle questioni qui accennate.
Le considerazioni non valgono sostanzialmente neppure per i vari ‘paesi socialisti’ formatisi in seguito alle lotte antimperialiste di liberazione nazionale dopo la 2a Guerra Mondiale.
Per quanto riguarda la massa dei lavoratori le condizioni sociali sono di gran lunga ancora migliori in questi paesi che nella maggior parte dei paesi dell’area dominata dall’imperialismo americano. Anche nelle zone più arretrate dei paesi del ‘socialismo reale’ i proletari sono ancora ben lungi dall’essere stati ricacciati nelle condizioni di sfruttamento, miseria e oppressione esistenti per la maggioranza dei proletari e per la popolazione povera dell’area dominata dallo imperialismo USA, risentendo ancora in varia misura delle conquiste delle rivoluzioni proletarie e godendo ancora i frutti delle lotte di liberazione nazionale. L’abolizione su larga scala della rendita, i limiti posti allo sviluppo del capitale finanziario, la abolizione legale della proprietà individuale sulle forze produttive, la sussunzione legale dell’economia nell’ambito della politica, la pratica diffusa di pieno impiego, la soppressione mantenuta del carattere mercantile di vari beni di consumo (abitazioni cittadine, ecc.) e altre misure del genere fanno sì che per alcuni versi la condizione del proletariato nella società sia incomparabilmente migliore che nelle società dell’area americana. Cosa per cui Breznev poteva con ragione obiettare a Berlinguer: ‘siete sicuri che ai disoccupati, agli sfrattati, ai bambini costretti al lavoro nero del vostro paese non interessino le conquiste realizzate nel nostro paese?’. L’arricchimento individuale, la speculazione, il lusso e lo spreco dei membri della classe dominante che nelle nostre società sono loro legittime, onorate e invidiate prerogative sono in questi paesi ancora pratiche diffuse ma illegali. La dominazione e lo sfruttamento dei membri della classe dominante sugli altri esiste come oppressione amministrativa e personale (quindi arbitraria e rimovibile) anziché come fatalità impersonale. La possibilità, la legittimità e la necessità di dirigere consapevolmente il movimento economico della società nell’interesse dei suoi membri sono diffusa acquisizione collettiva.
Nei paesi del ‘socialismo reale’ esiste a tutt’oggi una società di milioni di uomini che non si sono mai abituati a correre a chiedere un lavoro ad altri individui, a vivere l’incertezza di ottenerlo o meno, a subire il rifiuto, a vedere sorgere e sparire iniziative economiche (di cui subiscono le conseguenze) per motivi ad essi imperscrutabili; come non si sono mai abituati ad essere cacciati di casa dal padrone e in generale a subire come fatalità varie altre ‘delizie’ del capitalismo che per miliardi di altri individui nel mondo sono normali avvenimenti nella vita e da moltissimi considerate ancora come inevitabili e naturali fatalità. Per cui i termini della lotta di classe nei paesi del ‘socialismo reale’ si pongono ad un livello più avanzato che da noi.
Il fatto stesso che le condizioni di sfruttamento e diseguaglianza possano esser mantenute solo grazie a un diffuso impiego della violenza statale testimonia che queste società hanno riunito condizioni più favorevoli per la transizione al comunismo, che il capitalismo monopolistico di stato in questi paesi non si è formato come maturazione del capitalismo, ma come antidoto alla transizione al comunismo.
I negri dei ghetti USA, gli abitanti delle favelas di Rio, dei bassi di Napoli e delle bidonvilles del Cairo, di Lagos e di Hong Kong hanno in alcuni casi più beni di consumo di un lavoratore dell’Azerbaigian, di Shanghai e dell’Avana; ma proprio nel modo in cui a un individuo costretto a nutrirsi dei rifiuti di un ricco sprecone attingendo alla sua pattumiera poteva capitare di essere più nutrito di un libero contadino. La sorte delle popolazioni primitive della Siberia è ben diversa e migliore della storia degli Indiani del Nord America, degli Indios del Brasile, degli indigeni della Bolivia e del Guatemala e dei Pigmei dell’Africa Centrale.
Le società dei paesi del ‘socialismo reale’ sono la negazione della transizione dal capitalismo al comunismo perché tutte le misure che costituiscono l’evoluzione dei loro ordinamenti economici, politici e culturali negli ultimi anni vanno nel senso del ristabilimento o rafforzamento di rapporti commerciali e capitalistici e di distruzione dei germi di comunismo.
In URSS i dirigenti delle unità produttive non fanno ancora licenziamenti di massa, ma solo licenziamenti individuali disciplinari, come pure non chiudono ancora le fabbriche e spariscono. Ma tutte le misure prese a partire dalle ‘riforme’ krusceviane in poi creano le premesse per rendere la creazione di un esercito industriale di riserva una ‘soluzione necessaria dei problemi economici del sistema’. L’URSS dispone attualmente di tutte le tecnologie di cui dispongono gli USA: non si spiegherebbero altrimenti i successi sovietici nel campo militare e nel campo dell’esplorazione e della utilizzazione dello spazio. Se il processo lavorativo e la produttività del lavoro umano sono tanto arretrati in molte unità produttive sovietiche, la causa non sta nel boicottaggio commerciale dall’estero. Se dirigenti e lavoratori delle unità produttive non sono motivati alle innovazioni tecnologiche, ciò è dovuto al fatto che, mentre è ancora limitato il campo d’azione aperto a motivazioni dovute al profitto, al tornaconto individuale, alla disoccupazione (cioè mentre la concorrenza non impone ancora universalmente le leggi del plusvalore relativo proprie del capitale), non sussistono già più altre motivazioni (il benessere collettivo, la riduzione della giornata lavorativa, la produzione per soddisfare i bisogni, la comunità reale). È una questione di rapporto tra classi.
Tutti quanti in URSS e negli altri paesi del ‘socialismo reale’ intervengono da quasi 30 anni nel dibattito sulla: ‘riforma economica’, affrontano un unico problema generale. Essi, al modo di tutti i capitalisti, lo formulano in termini economici: come rendere più efficiente il sistema economico sovietico; le singole unità produttive che lo compongono; i reparti, le squadre di produzione e i singoli lavoratori di queste unità produttive. E danno risposte che, con differenze nei particolari, concordano nell’indirizzo generale: introdurre una maggiore concorrenza economica tra individui, gruppi e unità produttive; subordinare la continuazione del processo produttivo del singolo individuo, gruppo e unità produttiva (cioè la riproduzione) alla realizzazione del prodotto (conversione del prodotto in una quantità adeguata di denaro); ridurre la concentrazione del capitale a favore del suo decentramento; fare si che tra le varie unità produttive esistano sempre meno rapporti del tipo di quelli esistenti tra reparti di una stessa fabbrica e sempre più rapporti del tipo di quelli esistenti tra società distinte e concorrenti per la realizzazione del massimo profitto; aumentare la diseguaglianza nella partecipazione al patrimonio culturale e scientifico della società e al suo sviluppo; rendere sempre più questa partecipazione una professione a vita e parcellizzata e, di converso, una condanna a vita il particolare lavoro di quanti sono addetti al lavoro produttivo; erigere l’aumento della produzione a regola e misura della vita sociale e fondare questo aumento sulla intensificazione del lavoro; ridurre ogni trasformazione nei rapporti sociali a disposizione statale e a ordinamento legale imposto, con l’esclusione, l’orrore e la repressione di ogni movimento di massa. Risposte che significano tutte dare maggiore carattere mercantile ai prodotti del lavoro e alla capacità lavorativa degli uomini.
Le divisioni intervengono:
1) sulla estensione da dare al carattere mercantile a) dei prodotti (libertà di compra-vendita e di prezzo per tutto, o solo per i beni di consumo, o solo per i prodotti «nuovi», o solo per la quantità eccedente una quota ancora commissionata e ritirata tramite i ministeri statali; prezzi liberi completamente o solo entro certi margini fissati dallo stato o concordati dalle associazioni dei produttori, o prezzi stabiliti secondo parametri e criteri disposti amministrativamente, ecc.);
b) della capacità lavorativa (libertà completa di assumere e licenziare, di contrattare i livelli salariali e le condizioni normative oppure entro i margini stabiliti dalle autorità statali, dalle autorità sindacali; maggiore o minore ventaglio dei salari, salari più o meno legati alla produttività individuale o di gruppo; corrispondente maggiore o minore ventaglio della produzione di beni di consumo individuali senza di ché il ventaglio dei salari è un sotterfugio che trova sfogo parziale nella economia sommersa e nella borsa nera).
2) sulla accettazione delle conseguenze inevitabili del carattere mercantile della produzione: squilibri tra settori; produzione solo per la domanda solvente data; rapporti delle singole unità produttive con unità produttive straniere; abolizione o limitazione della statalizzazione dei rapporti commerciali e valutari con l’estero; lo sviluppo del capitale finanziario; chiusura e apertura di unità produttive; libera iniziativa individuale e di gruppo nell’intraprendere iniziati ve economiche e cessarle; disoccupazione.
Attualmente la società sovietica è un sistema mercantile e capitalistico impedito di esplicarsi completamente in importanti aspetti negativi (non si possono fare alcune cose) e positivi (non ne conseguono determinate altre) da misure amministrative imposte coercitivamente dallo stato.(*)
(*) Ed è ciò che avviene all’interno di ogni singola grande impresa capitalista: la concentrazione del capitale soffoca o attenua la sua dinamicità. Non è un caso che le imprese capitaliste, arrivate ad un certo grado di sviluppo, avvertono il bisogno di suddividersi in profit centers che hanno tra loro rapporti commerciali e di concorrenza, di far passare i rapporti tra le loro singole parti da rapporti di divisione tecnica del lavoro tra reparti diversi di una stessa ditta, a rapporti di compravendita.
Il dibattito si svolge attorno al tema ‘se e in che misura ridurre le misure amministrative per lasciare esplicare liberamente il carattere mercantile e capitalista del sistema produttivo’. Quindi è un dibattito interno alla classe dominante (quali che siano le iniziative per fare partecipare le masse al dibattito) perché è posto e mantenuto entro questi limiti. Quello che non emerge e viene represso è il movimento per un maggiore superamento del carattere mercantile e capitalista del sistema produttivo. Movimento che non potrebbe che consistere in una rinnovata mobilitazione della classe operaia e del proletariato contro i privilegi e la diseguaglianza economica e sociale; contro la divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, tra attività direttive e attività esecutive; contro l’asservimento degli individui alla divisione del lavoro; per la riduzione della giornata lavorativa; per la separazione tra lavoro necessario alla produzione e riproduzione delle condizioni materiali dell’esistenza e le altre attività (creative, ricreative, culturali, politiche, sportive, ecc.); per la partecipazione di tutti ad entrambe; per la produzione di quanto serve alle masse secondo scale di priorità; contro il perseguimento dell’aumento della produzione per la produzione. Tutti campi su cui le società del ‘socialismo reale’ non hanno fatto negli ultimi trent’anni nessun passo avanti e vari passi indietro.
Il sistema di capitalismo di stato affermatosi in questi paesi anziché via via superato viene consolidato e tutta la problematica della classe dominante è come articolare concentrazione e decentramento del capitale, capitalismo di stato e iniziativa e tornaconto individuale e di gruppo.
Per cui gli stati di questi paesi ancora oggi costituiscono un punto di appoggio per i movimenti progressisti dei paesi del Terzo Mondo dove è all’ordine del giorno la lotta per rompere l’asservimento alle forme specifiche di dominazione politica ed economica dell’imperialismo americano; costituiscono però anche un sistema di oppressione contro il movimento operaio rivoluzionario e sono un ostacolo per la mobilitazione delle masse necessaria a sviluppare i frutti della vittoria degli stessi movimenti di liberazione nazionale.
Vi sono paesi dove l’oppressione nazionale, la dominazione politica straniera, il colonialismo, il razzismo, il sostegno internazionale alla classe politica dominante, la particolare collocazione nel mercato mondiale appaiono gli ostacoli immediati di ogni progresso economico e civile; dove il limitato sviluppo delle forze produttive e della produzione appaiono la fonte della fame, della miseria e della dipendenza nazionale. In questi paesi il movimento rivoluzionario contro la società borghese si esprime inevitabilmente in prima istanza come movimento contro queste ‘delizie’ che si presentano come la causa di tutto. Quindi il programma rivoluzionario immediato consiste in conquista della indipendenza politica ed economica nazionale, sviluppo della produzione, rottura dei vincoli politici e finanziari che subordinano al mercato capitalista mondiale e soffocano ogni possibilità di sviluppo economico, culturale e politico (quindi un programma rivoluzionario democratico-borghese nella fase imperialista). Per il movimento rivoluzionario di questi paesi gli stati del ‘socialismo reale’ sono un alleato fino a quando non vi sono pericoli di ‘contagio’ o pericoli di sconvolgimenti che li tocchino direttamente. Infatti è anche nel loro interesse rompere il monopolio politico, commerciale e finanziario americano e la centralizzazione del mercato mondiale; la statalizzazione dei rapporti economici con l’estero oltre che una esigenza del movimento rivoluzionario di questi paesi è anche una forma adeguata all’imperialismo sovietico. Mentre gli stessi stati diventano un ostacolo per tutto quanto riguarda la mobilitazione di massa che è una componente essenziale nella maggior parte dei casi all’adempimento degli stessi compiti democratico-borghesi della rivoluzione.
Nei paesi dove è all’ordine del giorno la lotta per il comunismo, dove quindi il programma rivoluzionario è lavorare tutti lavorare meno, abolire la produzione di valori di scambio per la produzione di valori d’uso, abolire la schiavitù alla divisione del lavoro per l’unità di lavoro fisico e lavoro intellettuale, il rapporto delle forze rivoluzionarie con gli stati del ‘socialismo reale’ non può che essere un rapporto antagonistico (salvo lo sfruttamento delle contraddizioni in campo nemico che fa parte di ogni tattica rivoluzionaria).
Gli ‘operaisti’ e i predicatori dei ‘nuovi bisogni’ (ad occultamento della non soddisfazione dei ‘vecchi bisogni’ per la stragrande maggioranza degli uomini) guardano il mondo con gli occhi miopi e sazi dell’aristocrazia proletaria dei paesi imperialisti, della cui situazione privilegiata sono i portavoce culturali e politici.
L’aristocrazia dei paesi imperialisti esiste effettivamente ed è inevitabile che si esprima: è inevitabile anche che sorgano i profeti del suo lato filoborghese, del suo lato servile. Dobbiamo avere una politica nei confronti suoi e anche dei suoi profeti, che tenga conto della sua esistenza e della sua precarietà di fronte alla crisi economica e alla guerra, che valorizzi ciò che la lega alle masse proletarie e faccia i conti, con i mezzi concretamente necessari nelle singole situazioni, con ciò che la asserve alla borghesia.
Per avere una politica verso l’aristocrazia proletaria dobbiamo anzitutto conoscerla, cioè tracciare una giusta analisi delle classi della società metropolitana, della società dei paesi imperialisti.
A questo fine dobbiamo battere la tendenza, universalmente imperante nei circoli accademici imperialisti e nelle loro correnti di sinistra (operaiste e anarchiche), a partire dai comportamenti e dalle opinioni o, come è pratica degli intellettuali più ‘materialisti’, dai redditi degli individui per raggruppare poi questi in classi di individui affini per comportamenti, opinioni o reddito.
Noi marxisti-leninisti, convinti che le opinioni e i comportamenti degli individui sono non il fondamento della divisione in classi ma un prodotto dei rapporti tra le classi (rapporti di produzione, rapporti politici, ivi compreso l’armamentario della controrivoluzione preventiva, rapporti culturali, ecc.), sosteniamo che le classi vanno individuate partendo dall’analisi del funzionamento del sistema nel suo complesso. È la comprensione della macchina e del suo funzionamento che permette di comprendere il ruolo delle sue varie parti, perché può succedere e succede che due parti, eguali per chi le osserva, adempiano a ruoli diversi e che altre due, diversissime per chi le osserva, adempiano allo stesso ruolo.
Le opinioni e i comportamenti degli individui mutano assai più rapidamente e repentinamente della loro collocazione di classe proprio perché sono un prodotto non semplice né diretto della collocazione di classe, ma di svariati fattori su cui qui non ci dilunghiamo.
Anche i redditi degli individui nella società borghese mutano (e lo vediamo sotto i nostri occhi) con il variare della congiuntura economica generale. Variano non solo i redditi in assoluto, ma variano anche relativamente, per cui categorie che in una certa congiuntura si trovavano con redditi più elevati di altre categorie, al variare della congiuntura si trovano scaraventate più in basso e viceversa.
Dobbiamo quindi anzitutto porre le ‘determinazioni formali’ della società borghese, i ruoli fondamentali e contraddittori il cui svolgimento determina il movimento economico della società borghese. A ognuno di questi ruoli corrisponde una classe e la collocazione di classe di ogni singolo individuo è definita dal ruolo che esso svolge. Tenendo presente che ogni concreto è sintesi di svariate determinazioni formali, il ché nel nostro caso significa che un singolo individuo può svolgere ruoli diversi e contraddittori e quindi essere sintesi di collocazioni di classe contraddittorie: un caposquadra può ad esempio essere contemporaneamente un venditore di capacità lavorativa da una parte e dall’altra esercitare alcune mansioni del capitalista: comandare altri lavoratori, organizzare il loro lavoro, spremere da essi più lavoro possibile.
Quali sono le determinazioni formali rilevanti per la nostra analisi?
1) Il lavoro autonomo non produttore di merci.
Produzione per l’autoconsumo o comunque per il consumo senza preventivo scambio contro equivalente. Il prodotto del lavoro non è destinato allo scambio, non entra in concorrenza direttamente con il prodotto di altri lavoratori; il lavoratore non è direttamente costretto dal ‘mercato’ per quanto riguarda qualità dei prodotti, produttività del suo lavoro, tempi di lavoro, modo di impiego dei mezzi di produzione e tipo di mezzi di produzione. Non direttamente, perché indirettamente lo è in vari modi, se vive in un contesto dove il rapporto commerciale o capitalistico è diffuso. Se ad es. la produttività del lavoro che la famiglia dell’operaio brianzolo o bergamasco applica al proprio orto è particolarmente bassa, ad un certo punto essa troverà più conveniente trovare un lavoro dipendente, fare lo straordinario o il doppio lavoro e comperare quello che prima ricavava dal suo orto.
Nella società metropolitana è una forma secondaria, di poca importanza economica (anche se può averne molta per gli individui, cioè di scarsa incidenza sul movimento economico complessivo della società borghese). Comprende vari casi: secondo lavoro per la sussistenza, ‘libera’ attività dopolavoristica, lavori non ancora sussunti o difficilmente sussumibili (data la loro natura) nella produzione capitalistica o nella produzione mercantile (non ogni contenuto si adatta alla forma e viceversa).
2) Lavoro autonomo produttore di merci.
Il prodotto del lavoro è destinato allo scambio, è una merce e assume un valore e un prezzo. Il mercato regola quindi la attività di questo lavoratore sia in qualità che in quantità: non nei dettagli esecutivi (come avviene per il lavoratore dipendente), ma la regola. Se la produttività del suo lavoro è bassa, dovrà arrangiarsi allungando il tempo di lavoro suo e dei suoi familiari o cambiare mestiere. In caso di produzione da parte di chicchessia di una quantità delle sue merci superiore alla domanda solvente, egli sarà rovinato al punto da non poter più ripetere il suo processo lavorativo.
Scopo dell’attività di questo lavoratore è il suo consumo, non la moltiplicazione del suo denaro e questo determina le condizioni della riproduzione della sua attività. Non è direttamente costretto ad allargare la produzione, ad accumulare: entro certi limiti può continuare a riprodurre allo stesso livello.
Anche qui ci sono nella società metropolitana casi formalmente diversi e di importanza economica diversa. Ma si stratta di una forma secondaria, salvo che per alcuni settori di attività la cui natura mal si presta a essere sussunta dal capitale. Non è un caso che è ancora diffusa nel lavoro agricolo, dove le condizioni di regolarità, continuità, espropriazione della abilità personale del lavoratore richieste dal capitale sono più difficili da realizzare e dove la proprietà privata della terra e la sua dimensione limitata frappongono ostacoli al modo di produzione capitalista. Dove il modo di produzione capitalista è ben sviluppato, il capitale sfrutta per altre vie questo tipo di lavoro (credito, imposte, forniture, commercializzazione). Da una parte esso confina con il lavoro a domicilio su commissione del capitale quando la sua dipendenza dal capitale commerciale, industriale, bancario diventa cronica. Dall’altra confina con il lavoro artistico.
Queste due prime forme sono forme marginali che vivono per così dire nelle pieghe della società capitalistica e sono progressivamente eliminate dal capitalismo e rigenerate come forme complementari, ausiliarie della produzione capitalista stessa (basta pensare a grafici, analisti, dattilografe, ragionieri, disegnatori in proprio e alle produzioni decentrate, ecc.).
3) Lavoro salariato.
Parlando dei lavoratori che vendono la loro capacità lavorativa bisogna anzitutto distinguere la forza-lavoro che si scambia contro capitale dalla forza-lavoro che si scambia contro reddito (indipendentemente dall’uso concreto che l’acquirente farà della forza-lavoro acquistata, dal lavoro concreto per cui la assume).
La forza-lavoro che si scambia contro capitale è quella assunta direttamente dal capitale in quanto tale, assunta quindi per valorizzare il capitale, per farlo crescere.
La forza-lavoro che si scambia contro reddito è quella dei lavoratori assunti a qualsiasi altro fine che non sia la valorizzazione del capitale.
3a) Forza-lavoro che si scambia contro reddito.
Questa forma nella società metropolitana non esiste solo come residuato storico (il palafreniere della regina Elisabetta), né solo come concessione del capitalista alla ‘debolezza della (sua) natura umana’ a detrimento della accumulazione di capitale (la servitù di Agnelli e signora), né solo come esigenza commerciale e politica (le spese di rappresentanza e i gorilla di De Tomaso). Essa è anche in misura crescente un prodotto del movimento del capitale.
Man mano che cresce la sovrapproduzione di capitale e quindi quote crescenti di plusvalore non possono a loro volta essere trasformate in capitale, una quota crescente di plus-valore viene impiegata come reddito. Esso comanda lavoro morto (merci) sia come beni di consumo che come mezzi di lavoro e comanda lavoro vivo.
Rientrano in questo:
- il plusvalore usato come reddito personale dal capitalista e dai suoi scagnozzi, come lusso e sfarzo di cose e servitù, di gorilla, di leccaculo, ecc.;
- il plusvalore impiegato in fondazioni, istituti ‘culturali’, di vigilanza, di ricerca, di assistenza e beneficenza, associazioni politiche, culturali, sindacali, di categoria, ecc.;
- il plusvalore usato come spesa statale e spesa pubblica in generale (armamento, istruzione, pensioni, servizi sanitari, prebende e sinecure, burocrazie, servizi di assistenza, contributi pubblici alle clientele, servizi di repressione, guerra, ecc.).
Resta a mezza strada tra questa determinazione formale e quella del lavoro dipendente dal capitale, il lavoro impiegato da capitale operante in condizioni particolari (ricerca di valorizzazione ma non in concorrenza con il capitale vero e proprio: imprese pubbliche che vendono il loro prodotto).
L’aspetto caratterizzante questa determinazione formale è che il valore impiegato in questo modo non entra in concorrenza con il capitale vecchio e nuovo per la produzione e appropriazione di nuovo plusvalore e quindi non concorre alla formazione del saggio medio del profitto. Le condizioni del suo riprodursi sono determinate diversamente da quanto avviene per le attività capitalistiche: un’impresa capitalista si riproduce, continua la sua attività finché il capitalista realizza con essa profitti che non potrebbe realizzare maggiori in altro modo: finché questa condizione sussiste i lavoratori da essa dipendenti continueranno a lavorarvi; il dipendente di una istituzione qualsiasi, il lavoratore che scambia la sua forza lavoro contro reddito continua a lavorare finché il padrone da cui dipende non decide di ‘ridurre le spese relative al suo settore di lavoro’. Da qui il ruolo socialmente secondario di questi settori nella società borghese.
La forza-lavoro che si scambia contro reddito è enormemente cresciuta di numero ed è tuttora in crescita nelle società metropolitane dove si concentrano gran parte delle istituzioni culturali, scientifiche, di formazione e informazione, di ricerca, politiche e militari di tutto il mondo. Nella crisi per sovrapproduzione di capitale vi è uno scomposto e repentino dilatarsi e contrarsi dei singoli settori di impiego, reso possibile dal carattere arbitrario della loro esistenza e delle loro dimensioni. Da una parte la sovrapproduzione di capitale spinge ad un aumento delle dimensioni complessive, come vi spingono ragioni di sopravvivenza politica della classe dominante e la sua illusoria speranza di ‘uscire dalla crisi’ accrescendo la domanda di merci senza interferire con la ‘economia vera e propria’ (v. la grande trovata di Keynes, le sussiegose proposte del Galbraith dell’Affluent Society, la attuale politica economica di Mitterand in Francia). D’altra parte la constatazione dell’inutilità in termini di ‘uscita dalla crisi’, la ‘indolenza’ e la ‘insaziabilità’ che la cosa genera e propaga tra i lavoratori rovinando anche ‘il morale’ dei lavoratori impiegati dal capitale, la ricerca affannosa e illusoria di ogni capitalista di ‘uscire dalla crisi’ investendo lui masse più grandi di capitale che però gli vengono contese dall’impiego improduttivo: tutti questi fattori spingono alla riduzione della quantità di valore impiegata come reddito.
La forza-lavoro che si scambia contro reddito nelle società metropolitane, per quanto riguarda il suo venditore si trova nelle stesse condizioni della forza-lavoro assunta dal capitale: i lavoratori di questo settore si vendono e si pongono in concorrenza con tutti i lavoratori per vendersi al prezzo più alto. Anche molte forme del rapporto di lavoro in questi settori vengono mutuate dal rapporto di lavoro capitalista anche se qui esse non hanno alcuna ragione nella cosa in sé; così vediamo l’insegnante, il cattedratico, il medico, il giornalista e lo scrittore pagato a ore; attività considerate un tempo come ‘missioni’, prese e abbandonate come qualsiasi ‘volgare’ mestiere in base alle condizioni salariali connesse, con grande scandalo dei pelosi lodatori del buon tempo antico.
Per quanto riguarda le condizioni del suo impiego invece questa forza-lavoro si trova in condizioni diverse da quelle della forza-lavoro che si scambia contro capitale. Non si ha qui tutta la dinamica del plusvalore assoluto e relativo; produttività del lavoro diversissime possono tranquillamente e indefinitamente coesistere una a fianco dell’altra (l’ufficio postale automatizzato accanto a quello che va ancora avanti con la penna d’oca). La produttività del lavoro in questi settori è generalmente più bassa di quella in settori materialmente analoghi ma capitalistici; le tendenze ad accrescere la produttività di questi settori non hanno come scopo e risultato l’aumento di plusvalore estorto, ma il risparmio di plusvalore, cioè la limitazione del prelievo di plusvalore altrove estorto e destinato a questi settori. Il prodotto del lavoro di questi settori non è venduto; quando è venduto, lo è in condizioni di monopolio assoluto e il ricavato della vendita non condiziona la riproduzione (l’ufficio postale continua a funzionare anche se non incassa neanche tanto da coprire le spese); il valore impiegato in questi settori (mezzi di lavoro e salari) non concorre con altri valori per l’impiego al più alto profitto; soprattutto (come già accennato) l’esistenza, lo sviluppo, l’estinzione di ampi settori di impieghi di questo tipo dipendono da decisioni arbitrarie di individui, sono completamente soggettive (ad es. la decisione governativa di ridurre la spesa pubblica nella sanità se attuata ridurrà il numero di lavoratori del settore, lo stesso nel campo della pubblica istruzione; la decisione governativa di ‘sottrarre giovani disoccupati alle lusinghe del terrorismo’ occupandoli negli enti locali per lavori ‘di pubblica utilità’ (legge 285) ha aumentato, di poco, il numero dei lavoratori negli enti locali).
Non operano insomma in questi settori le leggi del capitale, né tali leggi del capitale in quanto tale si impongono qui tramite la concorrenza tra, le sue varie parti.
Questa è una delle grandi componenti della aristocrazia proletaria della società metropolitana.
3b) Forza lavoro che si scambia contro capitale.
Quanto alla forza-lavoro che si scambia contro capitale, occorre distinguere nel ciclo del capitale che si valorizza [(Denaro ---> Merce) … (Produzione) … (Nuova merce ---> Più Denaro); (D-M ... P ... M’-D’)] le determinazioni formali che il capitale assume: capitale-denaro, capitale produttivo, capitale-merce. L’unico ciclo di valorizzazione del capitale si scinde in tre fasi parziali (dapprima come fasi vissute dallo stesso capitale e poi come fasi vissute da capitali distinti).
1. Trasformazione del capitale-denaro (D) in capitale-merce (M) cioè in tutti i vari ingredienti di processi produttivi (materie prime, forza-lavoro, macchinario, materie ausiliarie, edifici, ecc.). Questa trasformazione comporta una gran quantità di operazioni:
- operazioni finanziarie e creditizie attraverso le quali il capitale-denaro passa dalle mani del capitalista monetario in quelle del capitalista imprenditore;
- operazioni di commercio di titoli finanziari e di speculazione sui titoli finanziari, cresciute sulle prime;
- operazioni commerciali e contrattuali da ufficio acquisti e da ufficio personale e le connesse operazioni assicurative;
- operazioni di prestito, affitto, ecc. dei vari ingredienti dei processi produttivi e le conseguenti operazioni, sui titoli di credito;
- operazioni di gestione magazzino materie prime.
2. Produzione di merci, cioè il processo lavorativo vero e proprio in cui alcuni lavoratori, inquadrati eventualmente in reparti e unità produttive distinte tra cui non si hanno operazioni di compra-vendita (scambio), trasformano gli ingredienti della produzione (M) in prodotti merce (M’) che il capitalista venderà.
3. Trasformazione del capitale-merce (M’) in capitale-danaro (D’), cioè la realizzazione, la vendita, la trasformazione delle merci particolari nel mezzo di scambio universale (che è anche mezzo di pagamento universale e mezzo di conservazione del valore): il denaro. Questa trasformazione comporta anch’essa una gran quantità di operazioni:
- pubblicità e reperimento clienti;
- contrattazioni e operazioni contrattuali;
- operazioni creditizie e assicurative;
- gestione rete commerciale;
- gestione magazzino prodotti finiti.
Le operazioni della 1a e 3a fase si distinguono da quelle della 2a fase perché sono per intero e fin dall’inizio una derivazione diretta dei rapporti mercantili e capitalistici, sono venute alla luce con essi ed esistono solo perché esistono rapporti di produzione mercantili e capitalistici; all’origine del modo di produzione capitalista erano svolte direttamente dal capitalista, al massimo con l’aiuto di uomini di sua fiducia il cui reddito anche quando assumeva le apparenze del salario era in realtà un compenso dell’affidamento, una compartecipazione al plusvalore e il cui rapporto col capitalista era sostanzialmente diverso da quello tra capitalista ed operaio. Solo in seguito al progredire dell’accumulazione del capitale, della sua concentrazione e centralizzazione e al parallelo svilupparsi della divisione sociale (le operazioni lavorative svolte sotto un unico capitalista si dividono in operazioni svolte sotto più capitalisti che hanno tra di loro rapporti di scambio) e tecnica (le operazioni lavorative svolte inizialmente da un unico individuo si dividono in operazioni compiute da individui diversi anche nell’ambito della stessa unità produttiva) del lavoro, anche le operazioni relative alle fasi 1a e 3a comportano l’impiego di veri e propri lavoratori salariati, mentre i risultati delle stesse operazioni e le operazioni stesse vengono esercitate da capitalisti particolari e vendute come merci tra le altre merci.
A seguito di questo sviluppo la forza-lavoro assunta dal capitalista può essere impiegata in mansioni attinenti a una o più fasi del ciclo del capitale. La riproduzione di valore è la produzione di plusvalore si hanno solo nella seconda fase; nelle altre due fasi si ha solo trasformazione della forma del valore (da danaro in merci, da merci in danaro).
Qui è importante, al fine di evitare errori correnti, sottolineare il fatto che le due fasi di scambio (D-M e M’-D’) non coincidono con i settori trasporti e commercio delle statistiche economiche correnti, ma si riferiscono a ciò che concerne unicamente le trasformazioni di forma di valore, alla soluzione dei problemi che queste trasformazioni comportano e alle operazioni che storicamente vi si sono sviluppate (credito, assicurazioni, mercato dei titoli finanziari e creditizi, cambio) e alle istituzioni sorte a questi scopi.
La divisione sociale del lavoro creatasi tra le imprese concrete spesso non rispecchia questa distinzione formale, per cui nelle stesse imprese e a volte nello stesso lavoratore vi sono mansioni che appartengono a più di una fase del ciclo sopra considerato. Ad esempio una concreta impresa del ramo ‘commercio’ può svolgere operazioni di trasporto, imballaggio, conservazione, manutenzione, ecc. che appartengono alla produzione e operazioni di reperimento clienti, pubblicità, contrattazione, rappresentanza, recupero crediti, ecc. che appartengono alla circolazione. Non solo, ma la natura concreta della produzione ha influssi sulla forma della circolazione, e anche i problemi della circolazione trasformano la natura concreta della produzione (es. per esigenze di circolazione un detersivo deve essere colorato).
Il passo successivo nella nostra analisi è distinguere all’interno della fase produzione le mansioni del capitalista da quelle dell’operaio.
Anche qui si hanno determinazioni formali ben distinte. La forza-lavoro è stata acquistata dal capitalista, gli appartiene e il capitalista ne fa l’uso che crede. La direzione, l’organizzazione, la progettazione, la distribuzione, la sorveglianza, il controllo del lavoro appartengono al capitalista, l’esecuzione del lavoro all’operaio.
Anche qui mansioni e ruoli propri di determinazioni formali distinte a volte convivono contraddittoriamente nello stesso individuo. Ciò che è il concetto di capitale deve mediarsi con il concreto processo lavorativo, in uno sviluppo che va dalla sussunzione formale alla sussunzione reale del processo lavorativo nel capitale e nella trasformazione di esso in modi più adeguati al capitale. Anche qui si ha interazione e opposizione di forma e contenuto.
In ogni paese capitalista vi sono, accanto alle figure che impersonano le determinazioni formali pure, individui che svolgono alcune mansioni proprie del capitalista e alcune mansioni proprie dell’operaio. E sono le figure socialmente e politicamente ambigue.
Poste queste determinazioni formali, risultano chiare le altre grandi componenti dell’aristocrazia proletaria: i lavoratori addetti alle mansioni relative alla trasformazione di capitale-denaro in capitale-merce e alla trasformazione di capitale-merce in capitale-denaro e quei lavoratori che pur svolgendo prevalentemente mansioni proprie dell’operaio svolgono anche mansioni proprie del capitalista.
Anche queste componenti sono enormemente cresciute e ancora crescono nelle società metropolitane: per le difficoltà crescenti di realizzazione connesse con la crisi (di fronte a difficoltà di vendita ogni impresa capitalista licenzia operai e assume venditori e addetti alla pubblicità); per il concentrarsi nelle società metropolitane proprio di tutte queste attività rispetto alla produzione effettuata in tutto il mondo: per l’enorme crescita delle attività creditizie, finanziarie. commerciali, amministrative, contabili e manageriali.
A questo punto sono individuati i settori in cui si trova collocata l’aristocrazia proletaria delle società metropolitane.
1. I lavoratori dipendenti che scambiano la loro capacità lavorativa contro reddito, settore numericamente enorme nei paesi imperialisti: dipendenti statali, parastatali, degli enti locali (solo in Italia sono più di 4 milioni), degli enti morali, delle fondazioni, delle organizzazioni politiche, delle associazioni ecc. Questo settore ha di caratteristico le condizioni soggettive che determinano dimensioni, riproduzione e condizioni di lavoro nel settore: l’espansione o la riduzione di ogni singolo settore di attività e le condizioni di svolgimento del lavoro sono frutto di decisioni, entro dati limiti, arbitrarie; non sono imposte direttamente dal processo di valorizzazione del capitale e dalle sue leggi.
2. I lavoratori dipendenti che scambiano la loro capacità lavorativa contro capitale e sono impiegati nelle fasi D-M (trasformazione di capitale-denaro in capitale-merce) e M-D (trasformazione di capitale-merce in capitale-denaro).
Questo settore ha un grande sviluppo nella fase imperialista (del capitale finanziario e del monopolio). Le funzioni svolte da questo settore rispetto alla produzione di tutto il mondo sono concentrate nelle società metropolitane. Gran parte dei lavoratori di questo settore godono delle briciole dei rapporti diseguali di scambio tra paesi imperialisti e il resto del mondo.
3. I lavoratori dipendenti che scambiano la loro capacità lavorativa contro capitale e sono impiegati nella produzione (P) e svolgono in essa anche alcune mansioni proprie del capitale (organizzazione, distribuzione, progettazione, controllo, regolazione, sorveglianza del lavoro). Tipica di ciò è la squadra di lavoro dei cantieri composta da uno o due operai dei paesi imperialisti e da dieci-venti manovali malesi, egiziani, pachistani, tunisini, ecc.
La distinzione tra il composito corpo della aristocrazia proletaria e la classe operaia non è frutto di una tradizione culturale, ma è resa obbligatoria dal fatto che si tratta di collocazioni diverse nel complesso movimento economico della società borghese, la cui esistenza e la cui attività obbediscono a leggi economiche diverse nello svolgersi della società borghese e che comportano anche potenzialità politiche, culturali e sociali diverse; diversi destini nella evoluzione della crisi del sistema capitalista; diversi ruoli sociali. Appiattire in un tutto unico le classi corrispondenti a determinazioni formali diverse (come fanno, da lati diversi, intellettuali borghesi, operaisti, anarchici, ecc.) vuol dire condannarsi a prendere delle gran cantonate.
Nelle società metropolitane la classe operaia è in diminuzione numerica ma è difficile, per innumerevoli buone ragioni, che l’imperialismo possa evolvere nel senso di confinare nel Terzo Mondo tutta la classe operaia, trasformando una divisione di classe in divisione anche territoriale. La riduzione della classe operaia anziché segnare il declino della centralità della classe operaia, come sostengono operaisti e teste d’uovo varie, è un sintomo della riduzione del tempo di lavoro necessario a produrre e riprodurre le condizioni materiali della vita degli uomini e quindi fa del rovesciamento della sua condizione sociale ancora più il fulcro, il banco di prova e la sintesi della trasformazione di cui la società borghese è gravida. E siccome il rovesciamento della condizione sociale della classe operaia non può essere frutto che di un movimento della classe operaia stessa, ciò ne sanziona anche la centralità politica e rivoluzionaria.
Quanto alla aristocrazia proletaria delle società metropolitane, essa inevitabilmente nutre al suo interno tutte le illusioni sulla soggettività del capitale, sulla sua correzione pacifica, sul progresso delle condizioni del proletariato all’interno della società borghese (l’illusione che basti una ‘classe politica’ più illuminata, lungimirante, razionale, moderna, intelligente - alla Lucio Magri per intenderci - per risolvere i problemi) e nello stesso tempo vive le condizioni di manipolazione e di soffocamento connesse con la decadenza della società borghese è con il sopravvivere del modo di produzione capitalista al suo ruolo storico. Da qui la miscela di furori rivoluzionari e di opportunismo che si scontrano al suo interno. Da qui gli slanci rivoluzionari e le fantasticherie sognanti di un mondo ‘migliore’ che non nasca dalle fiamme della società borghese ma da una sua ‘umanizzazione’.
Su questo terreno si scontrano l’egemonia operaia per la lotta per il comunismo e le manovre semi-intellettuali e semi-poliziesche dei prof. Negri a braccetto con i giudici Sica e i poliziotti Rognoni per un movimento ‘per i nuovi bisogni’ e ‘per nuovi rapporti umani’, tendenti nell'immediato a neutralizzare l’egemonia operaia rivoluzionaria e in prospettiva a schierare l’aristocrazia proletaria della società metropolitana a fianco della borghesia imperialista contro la classe operaia delle metropoli e contro le masse oppresse e sfruttate del Terzo Mondo. Le manovre dei Negri di turno, svariate negli spunti, hanno infatti in comune lo spingere l’aristocrazia a cercare di consolidare i suoi privilegi, a rinchiudersi nel proprio angusto orizzonte culturale e sentimentale, a coltivare i suoi hobbies e pretesi ritorni alla ‘natura’, a illudersi che i suoi privilegi possano perpetuarsi indipendentemente dall’andamento generale del modo di produzione capitalista, a cullarsi nell’illusione di una pretesa pace sociale infuriandosi semmai contro gli ‘schiavi’ che ribellandosi la turbano (vedansi i quartieri residenziali piccolo-borghesi protetti militarmente), a illudersi che le sue condizioni siano frutto della sua intelligenza e cultura ‘superiore’ anziché dello sfruttamento capitalistico e della sua collocazione all’interno di esso. Anche gli spunti anticapitalisti (contro la distruzione dell’ambiente, contro il nucleare, per la pace, contro la. mercificazione dei rapporti umani) sono stravolti: la connessione delle condizioni combattute con il resto dell’assetto sociale è occultata, l’essere le condizioni volute parimenti connesse in modo inscindibile con altri aspetti della società è occultato, tutto è presentato come frutto possibile di scelte e coscienze individuali.
Nella misura in cui movimenti di questo genere hanno un peso, essi preparano l’aristocrazia a essere terreno di manovra per la borghesia nella lotta contro il resto del proletariato delle società metropolitane e le masse sfruttate e oppresse del Terzo Mondo.
D’altra parte tutti i sostenitori (vecchi o riverniciati di fresco, rozzi o acculturati, unilaterali o eclettici) delle teorie secondo le quali la vita delle società metropolitane è mossa e determinata da nuovi bisogni di socialità, di comunicazione o altro del genere, sbatteranno la testa contro il fatto che finché l’accesso ai beni necessari alla vita corrente non sarà diventato per tutti un fatto scontato, la attività economica, per produrre e procacciarsi questi beni, resta la base condizionante, la struttura portante di ogni società umana. Al culmine del periodo trentennale di sviluppo capitalistico prodotto dalla 2a Guerra Mondiale, la aristocrazia proletaria dei paesi imperialisti ha vissuto come scontato (per se stessa) l’accesso ai beni necessari alla vita corrente e i suoi portavoce intellettuali e politici hanno teorizzato e generalizzato (nel pensiero) questo suo stato. Ma la nuova crisi generale per sovrapproduzione assoluta di capitale, di cui viviamo le prime manifestazioni, l’inizio, distrugge questo stato della aristocrazia proletaria e lascia i suoi portavoce intellettuali a produrre discorsi tanto più raffinati e fantasiosi quanto più ciò che riflettono smette di essere esperienza vissuta per diventare spettri di essere passati. E più i problemi diventano gravi, meno si lasciano dominare dalle parole.
Dopo trenta anni di sviluppo capitalistico, che tanti intellettuali si precipitarono a proclamare illimitato (alcuni esultandone, altri scuotendo amaramente la testa), siamo ora all’inizio di un nuovo periodo di grandi sconvolgimenti sociali e politici in cui il proletariato di tutto il mondo, forte dell’esperienza rivoluzionaria accumulata che nessun carcere speciale e nessun successo di teste di cuoio o di forze di pronto intervento ha annientato, potrà porre nuovamente in gioco la necessità del comunismo. Le idee, le opinioni, gli atteggiamenti e i comportamenti di milioni di uomini cambiano repentinamente quando l’uovo su cui sedevano si rompe e il guscio risulta vuoto. La complessità infinita viene compressa e costretta a misurarsi con alcuni pochi nodi fondamentali: i sentieri percorribili diventano per tutti pochi. Una fiumana variopinta e babelica che nessuna predicazione e nessuno sforzo eroico poteva, deviando un rivolo dopo l’altro, sbalzare dal percorso che le era tracciato, si trova il percorso sbarrato e deve aprirsi comunque una nuova strada. La strada verso il comunismo diventa possibile per milioni di uomini e il lavoro di chi si era affannato per anni a scavarla e non ha perso la fiducia, diventa determinante perché questa strada, e non altre, da possibile diventi reale.
Chi ha combattuto per il comunismo, non ha combattuto invano!
L’agitazione svolta nei paesi del ’socialismo reale’ per la introduzione della ‘verità dei prezzi’ è rivendicazione della eliminazione dei residui delle misure di transizione dal capitalismo al comunismo. Mira a conferire ai prezzi di vendita dei prodotti il ruolo di regolatori della riproduzione. Ogni unità produttiva potrà continuare nella produzione se e solo se il ricavato della vendita dei suoi prodotti le consente di farlo, acquistando quanto le è necessario (ovviamente a prezzi anch’essi ‘veri’). Altrimenti chiuderà (non è qualcosa che i lavoratori italiani ben conoscono?). Ogni unità produttiva potrà riprodurre su scala allargata, quindi ingrandirsi nella misura del profitto realizzato con la vendita dei suoi prodotti. Da qui la spinta a vendere a prezzo più alto, a produrre ciò che si vende meglio e quindi a impiegare le risorse produttive al servizio dei settori privilegiati interni (che chiedono beni e possono pagarli) e internazionali. D’altra parte da qui la spinta allo sviluppo di un mercato creditizio (per allargarsi si prende a prestito) e, di passo in passo, del capitale finanziario.
L’illusione di alcuni sostenitori della ‘verità dei prezzi’ e la truffa di: altri consistono nel presentare la cosa come una semplice modifica dei prezzi, nascondendo le conseguenze implicite e le cose che, a riforma avvenuta, si presenteranno come il gradino successivo ‘senza del quale il precedente non serve a niente, anzi provoca solo danno’. Se il ricavato della vendita di un prodotto diventa il regolatore della riproduzione, diventano necessari la ‘libera’ contrattazione del prezzo della forza-lavoro, la ‘libera’ determinazione di quante e quali capacità lavorative impiegarvi, la compravendita, l’affitto e il prestito dei mezzi di produzione, lo scioglimento del legame tra proprietà e impiego dei mezzi e delle condizioni della produzione (quindi il capitale finanziario), la introduzione della rendita fondiaria relativa come mezzo per equiparare condizioni naturali diversamente favorevoli in cui operano unità produttive diverse concorrenti tra loro (infatti l’accademico sovietico E. Liberman l’ha già proposta fin dal 1964 - Pravda, 20 settembre 1964) e tutto il resto del ‘paradiso’ capitalista in cui viviamo.
L’introduzione della ‘verità dei prezzi’ è quindi una misura essenziale per il compimento delle ‘riforme’ in atto in questi paesi, come sostengono i riformatori d’avanguardia; contemporaneamente contribuisce a chiarire il carattere borghese delle ‘riforme’ in corso.
Negli anni settanta alcuni pubblicisti hanno ampiamente sviluppato la tesi che i rapporti capitalistici di produzione sono incorporati nell’apparato produttivo (impianti, macchine, ruolo dei lavoratori addetti e organizzazione del processo lavorativo immediato conseguenti). Si veda la esposizione di questa tesi contenuta in La Grassa - Turchetto, Dal capitalismo alla società di transizione, Franco Angeli Editore.
Da questa tesi, elaborata nell’ambito della polemica contro la neutralità della scienza e della tecnologia, i suoi sostenitori deducono che la questione centrale della transizione dal capitalismo al comunismo è la trasformazione del processo lavorativo immediato. Anche noi, sostenendo che tra forma (il rapporto sociale di produzione) e contenuto (il processo lavorativo immediato) c’è un rapporto dialettico di unità e di lotta, abbiamo messo in chiaro il movimento di trasformazione del processo lavorativo immediato onde renderlo adeguato al rapporto sociale di produzione, il ché equivale a sostenere che il primo incorpora il secondo. Ne segue che un nuovo rapporto sociale di produzione deve per forza tradursi anche in trasformazioni del processo lavorativo immediato.
Ma i sostenitori di quella tesi affermano un elemento solo del rapporto dialettico forma-contenuto, l’unità (al che li porta ‘naturalmente e spontaneamente’ la loro giusta polemica contro i sostenitori del ‘socialismo realizzato’ dell’URSS e contro i sostenitori (PCI) del passaggio al socialismo come questione unicamente politica, limitata cioè unicamente al problema di chi esercita il potere statale e su quale linea politica).
Essi trascurano l’altro elemento, la lotta, cioè la contraddizione tra processo lavorativo immediato e rapporto sociale di produzione, e più in generale tra forze produttive e rapporti di produzione. Non solo, ma riducendo la transizione alla trasformazione del processo lavorativo immediato, la rendono nebulosa, identificandola con la creazione di un nuovo apparato produttivo che è tutto da inventare.
Noi sosteniamo che la transizione procede trasformando i rapporti tra gli uomini nella produzione (unità tra lavoro di direzione, organizzazione, progettazione e controllo e lavoro di esecuzione; unità tra lavoro intellettuale e lavoro manuale; ecc.); di conseguenza invertendo l’attuale rapporto uomo-macchina (dall’asservimento attuale del lavoratore alla macchina, all’uomo che adopera la macchina); di conseguenza dando un corso diverso allo stesso sviluppo della scienza e della tecnologia (l’apparato produttivo).
Esemplificando e semplificando: non è il fatto che un uomo debba sorvegliare il quadro di un terminale o alimentare una macchina confezionatrice che lo rende uno schiavo salariato; ma lo rendono tale un insieme di condizioni esterne e interne al processo lavorativo immediato: il fatto di essere assunto e licenziato, ad un dato prezzo, ecc. (rapporto salariale); il fatto di essere destinato tutta la vita a quel lavoro o ad altri analoghi lavori esecutivi; la sua esclusione di principio e di fatto dalla conoscenza, progettazione e gestione sia dell’apparato su cui esplica il suo lavoro, sia delle motivazioni, scopi e modalità del complesso delle attività lavorative e delle attività in generale che hanno luogo nella società, ecc.
Non è solo quello che un individuo fa, ma anche quello che non fa, da cui è escluso che caratterizza la sua condizione di schiavo salariato.
E evidente a tutti la diversità in cui si trovano un individuo che nasce minatore, va a cercare un lavoro in miniera lo trova se lo accettano e finché non lo licenziano, quando lavora deve obbedire e basta, e morirà minatore e un individuo che possiede il patrimonio culturale, sentimentale ed economico della società cui appartiene, partecipa alla decisione e gestione della vita di questa società, ha esercitato ed eserciterà in essa varie mansioni e ora si trova anch’esso a svolgere come sua mansione lavorativa del momento la stessa che svolgeva il primo individuo sopra nominato.
Il sistema di pianificazione sovietico è teso a limitare, predeterminare, stringere in una camicia di forza prestabilita le spinte anarchiche e contraddittorie di una economica sociale basata stabilmente sul rapporto di valore e sul rapporto di capitale. Stabilmente perché non viene più condotta, da anni, alcuna politica di superamento di questi rapporti ma anzi tutte le politiche sviluppate dallo stato e dal partito sovietico negli ultimi decenni sono volte a rafforzare questi rapporti e a distruggere i germi di comunismo prodotti dalla Rivoluzione Proletaria d’Ottobre e dai suoi sviluppi.
La ‘pianificazione economica’ come sistema di distribuzione a priori, consapevole delle risorse e capacità produttive di una società tra i vari compiti produttivi decisi, in URSS non esiste affatto e darla per esistente è stato uno dei grandi errori teorici e politici commessi dai comunisti sovietici (pari a quello di aver dato per scontato la scomparsa di classi antagoniste). In URSS esiste un sistema coercitivo statale contro le dinamiche proprie delle varie frazioni di capitale e quindi una continua rincorsa tra pianificatori e dirigenti delle unità economiche a ‘chi fotte chi’.
Il sistema di pianificazione sovietico è la più sviluppata delle ‘forme antitetiche dell’unità sociale’ (di cui si parla nel cap. 3° parte 3a) generate nella società del capitale nello sforzo di attenuare gli effetti più catastrofici connessi col rapporto di valore e di capitale, pur restando nell’ambito di questi rapporti.
Il sistema di pianificazione sovietico è l’espressione del capitale più monopolizzato che esista sulla faccia della terra e quindi non è arbitrario: ogni tentativo di riformarlo si è infatti scontrato e si scontra con la necessità di attenuare il carattere monopolistico del capitale stesso, di aprire maggiore spazio istituzionale (legale) e pratico all’iniziativa economica indipendente, privata, delle singole unità produttive e dei singoli individui.
Questo bisogno di coartare spinte contraddittorie senza superarle (perché il processo del loro superamento è il processo di avanzata verso il comunismo, verso una comunità libera di lavoratori e quindi verso una comunità libera di uomini), ha le sue necessarie manifestazioni.
1. All’interno del paese produce repressione e regolamentazione dei rapporti economici e, di necessaria conseguenza, dei rapporti politici, culturali, civili anche all’interno della stessa classe dominante.
Le limitazioni poste alla libera produzione di merci e alla libera compravendita di merci (in primo luogo della forza-lavoro) tra unità produttive e tra individui, impongono limitazioni politiche delle altre libertà borghesi (libertà di associazione, di manifestazione, di parola, di stampa, ecc.).
La politica salariale è usata come rimedio alle contraddizioni sociali. Le autorità concedono aumenti salariali a individui e a gruppi per tenerli buoni o per farli lavorare di più. I beni di consumo continuano a circolare come merci, anzi cresce il loro carattere di merci; diminuisce l’assegnazione di beni di consumo senza contropartita o con contropartita simbolica (v. ad es. la casa); dove viene ancora mantenuta, essa entra in contraddizione ogni giorno di più con i rapporti sociali predominanti (nei mercati colcosiani si vende a 6-8 rubli/kg la carne che nei negozi statali è venduta a 2 rubli/kg): chi produce questi prodotti trova ovviamente iniquo dover consegnare ai centri d’acquisto statali a prezzo fissato, poniamo di 4, quello che sa di poter vendere direttamente al prezzo di 8; la classe dominante trova sempre più gravoso il fatto di dover versare fondi statali per compensare la differenza tra il prezzo pagato al produttore e il prezzo di vendita, alleggerendo così di una parte dei loro costi salariali tutte le aziende indistintamente, quelle a bassa produttività come quelle ad alta produttività e quindi di fatto favorendo le prime.
In un movimento economico sempre più affidato alla motivazione dell’arricchimento privato (dell’individuo e dell’unità produttiva) e che lega sempre più la riproduzione e la riproduzione allargata alla realizzazione di profitti privati (della singola unità produttiva o del singolo consorzio) risultano sempre più ingombranti, incompatibili ed ‘iniqui’ questi residui del movimento passato teso al superamento del carattere di merce dei prodotti e della capacità lavorativa.
La concessione di aumenti salariali a dati gruppi e individui per contenere contraddizioni sociali, provoca un costante eccesso di domanda di prodotti (diversi a secondo dei gruppi sociali da cui proviene) rispetto alla produzione, che è mantenuta limitata dalle limitazioni poste al libero dispiegarsi del carattere mercantile e capitalistico dei rapporti di produzione. Ciò si vede ad es. chiaramente nel campo della produzione agricola e dell’impiego delle forze produttive in agricoltura (il terreno agricolo degli appezzamenti individuali è in URSS il 4% del totale del terreno agricolo, ma vi si produce circa il 60% delle patate e il 35% della carne). Connesso a ciò è lo sviluppo crescente dell’economia sommersa, del mercato nero e dei ‘reati economici’, produzione e scambio di beni di consumo e di investimento al di fuori del piano.
2. Nei rapporti con l’estero produce necessariamente mille tentativi volti a costringere altre unità economiche in rapporti predeterminati e definiti, contraddittori agli antagonismi reali (per modo di dire: il governo cubano deve vendere zucchero all’URSS anche l’anno in cui le condizioni del mercato mondiale gli renderebbero più vantaggioso venderlo altrove, mentre i mezzi valutari - il denaro - ricavati dalla vendita dello zucchero restano la misura dei beni di consumo e dei mezzi di produzione che i cubani possono avere dall’estero e che comperano al prezzo corrente del momento). Esso quindi produce, come mezzo indispensabile per fare rispettare questi accordi predeterminati e definiti, i mille tentativi di vincolare gli stati allo stato dell’URSS. Donde gli ‘accordi’ e i ‘patti militari e politici’ senza ritorno, la ‘sovranità limitata’, l’interventismo politico e militare dell’URSS, la politica di potenza dell’URSS sviluppatasi apparentemente come risposta alla politica di potenza degli USA e che ancora appare come tale. In realtà è un risultato della ‘competizione pacifica’ teorizzata da Kruscev, in cui lo stato sovietico cerca di assicurarsi vendite e rifornimenti pianificati, di assicurarsi dall’estero il rifornimento dei beni prodotti in quantità carente all’interno e lo smercio di quelli prodotti in eccedenza (il capitalismo sovietico è anch’esso continuamente alle prese con il rompicapo di assicurare un ricambio ordinato sia in termini di valore d’uso che in termini di valore di scambio), di creare dovunque strutture economiche omogenee con cui scambiare.
Il capitalismo sovietico, come ogni singola frazione di capitale, ha bisogno di espandersi e per espandersi a quel livello di monopolio, ha bisogno di dominare. Il capitale sovietico ha bisogno di esportare merci e capitale, come ogni altra frazione di capitale. Solo che per il suo essere arrivato ultimo, il suo bisogno di espandersi si scontra con un ordine economico e politico preesistente dominato dai monopoli e degli stati americani e europei.
Ciò spiega la politica commerciale dell’URSS e la politica valutaria dell’URSS: le limitazioni e il contingentamento delle esportazioni sovietiche in Europa, negli USA e nel Terzo Mondo (vedi il caso auto); le iniziative congiunte (joint ventures); gli investimenti in URSS pagati con il ritiro dei prodotti come via per superare il blocco commerciale; le società miste; le banche e le società finanziarie sovietiche in Occidente; il ruolo dell’URSS nei trasporti marittimi tra paesi terzi; gli accordi commerciali; gli aiuti dell’URSS a paesi del Terzo Mondo (assolutamente bilaterali); il debito estero dell’URSS; i prestiti accordati all’URSS come alternativa agli scambi commerciali (per acquisti dell’URSS nei paesi creditori); la caccia dell’URSS ai mezzi di scambio e di pagamento internazionali (dollaro, sterlina, ecc.).
La grande maggioranza dei paesi del Terzo Mondo è legata a filo doppio all’imperialismo americano e/o europeo. Quindi ogni rivolgimento che si produce o si può produrre in questi paesi va obiettivamente a danno almeno di alcuni settori dell’imperialismo americano e/o europeo e quindi l’URSS lo appoggia. Donde il carattere ‘progressista’ dell’intervento politico, militare ed economico sovietico nella maggior parte del mondo.
In ogni paese asservito all’imperialismo americano e/o europeo, le forze politiche che si propongono compiti di rivoluzionamento economico e sociale trovano appoggio nell’URSS, che ha obiettivo interesse al loro successo (salvo poi operare per impedire che la rivoluzione sociale prosegua oltre: vedi la storia della RPC, di Cuba e di altri movimenti, o usare il suo appoggio come moneta di scambio nello scontro con gli USA).
L’imperialismo americano è invece sulla difensiva: il suo interesse è affermato oggi e sua necessità è difendere la situazione attuale: in Sudafrica, come in America Latina, come altrove, salvo che nei paesi dominati dall’URSS e nei paesi con governi rivoluzionari (dove il suo interesse è fomentare instabilità e rivolgimenti politici - v. Europa Orientale, Mozambico, Angola, ecc.).
Il caso della Polonia è esemplare di una situazione in cui il contrasto tra imperialismo russo e imperialismo americano si scontra con gli interessi di entrambi: il primo ha interesse a ristabilire la situazione precedente; il secondo desidererebbe ardentemente rovesciarla, ma questo rovesciamento metterebbe ‘in sofferenza’ le qualche decina di miliardi di dollari di credito che le banche occidentali vantano nei confronti dello stato polacco e i pingui interessi che ogni anno ne ricavano, oltre ai pericoli di contagio presentati da un movimento che non si presta ad un semplice salto di campo, dalla soggezione all’URSS alla soggezione agli USA. Per cui la Santa Alleanza USA-URSS benedetta dal Vaticano per riportare tra i lavoratori polacchi ‘ordine sociale, autorità, lavoro’. Per valutare giustamente la ‘difesa del socialismo’, l’ ‘appoggio ai movimenti di liberazione nazionale’ e la ‘difesa delta pace’ tanto sbandierati dallo stato sovietico a spiegazione della sua politica estera, bisogna che andiamo anzitutto a guardare quale ‘difesa del socialismo’ esso conduce nell’ambito delle sue frontiere.
Proposta di ricerca collettiva.
È da più parti sentita l’esigenza di rivisitare criticamente la storia del movimento dell’ultimo decennio. La proposta che qui formuliamo intende essere ancora più ambiziosa. Desideriamo spingere la rilettura fin nel passato remoto della classe operaia troppo spesso cristallizzato in formule dogmatiche, utilizzando chiavi interpretative il più possibile «spregiudicate», per entrare in questioni «tabù», fra cui: la conoscenza operaia, la sua morale, la genesi dell’etica del lavoro, la fede nel progresso, la fiducia nella tecnica, l’ostilità rivolta agli strati meno produttivi, agli indolenti, ai vagabondi, ai disonesti... i privilegi materiali che modellano cultura elitaria, l’efficienza produttiva che si traduce in arroccamento corporativo... le figure soggettivamente differenziate, anche se inserite nel medesimo processo lavorativo, che stentano a costruire ipotesi comuni e programmi unitari...
Troppo spesso si è rimandata la soluzione di questi interrogativi fondamentali o alla prassi politica o alle formule classiche del marxismo. In un caso come nell’altro la risposta non può essere scientifico-creativa, bensì empirica-dottrinaria. Presupporre che il futuro sia stato scritto e in-scritto in tavole immutabili significa dimostrare una ben scarsa fiducia (rovescio paradossale del fideismo dogmatico) nel metodo creativo che il marxismo ci ha consegnato.
Le pagine che presentiamo posseggono la sinteticità dello schema; i paragrafi che si susseguono somigliano ai «punti» di una scaletta di studio. Ci ripromettiamo di approfondire i diversi problemi qui soltanto sfiorati, e su questi intendiamo confrontarci collettivamente, accogliendo stimoli che puntualizzino o rettifichino la nostra «traccia» e interventi che ne approfondiscono le tematiche.
Compito imprescindibile di una tale proposta e di un tale sforzo non è, naturalmente, il raggiungimento di un nuovo diagramma teorico, di una nuova verità ideologica, di un altro sistema settario e dottrinario, bensì l’individuazione di strumenti collettivi - di critica e autocritica - per la ripresa della circolazione di idee e di lotte...
Rapporto tra classe operaia organizzata e «proletario pericoloso».
All’interno del movimento operaio italiano, nonostante alcune petizioni di principio, il rapporto tra classe operaia e proletariato extralegale, disoccupati, «figure marginali», appartenenti all’esercito industriale di riserva, è stato sempre risolto in favore del ruolo ideale svolto, nel processo di costruzione ed emancipazione della società futura, dal lavoratore industriale.
Il Turati de «Il delitto è la questione sociale», una volta sciacquatosi la bocca con la denuncia delle cause sociali della criminalità e della devianza, si ferma all’assunto «conflittuale» della origine del delitto.
Pochi anni dopo nonostante la «buona predica», il partito socialista assumerà tutta intera la teoria lombrosiana, frenologica e biopatologica.
I modelli dominanti della società borghese vengono, malgrado le polemiche di scuola e le distinzioni ideologiche, inglobati nella «cultura socialista»: Turati diverrà propugnatore di una legge liberticida contro l’alcolismo. Altri socialisti, come Ferri, porteranno avanti la concezione antropologica positivista all’interno dei manicomi e delle teorie alienistiche... Insomma: il diverso, il criminale, l’improduttivo, rappresentano per la «cultura socialista» un oggetto di studio; non certo un soggetto politico-sociale di lotta e di emancipazione.
Positivismo e evoluzionismo sociale sono alla base delle certezze e della stigmatizzazione, mediante le quali, la cultura socialista riconosce alle «Classi non produttive» o marginali una diversità intrinseca, che oscilla tra la responsabilità individuale e le tare ereditarie (si veda al proposito il verismo del Verga e la scuola naturalistica di Zola).
All’opposto il pensiero pre-marxiano «anarchico» (socialismo utopistico) fatta eccezione per Proudhon, ha sempre annesso enorme importanza soggettiva strategica al proletariato inoccupato e al sottoproletariato. Non è superfluo ricordare che Weitling prima, Bakunin e i suoi seguaci dopo, teorizzarono - spesso contro «l’autoritarismo» della componente marxista - la priorità sociale e militare del lumpenproletariat.
Una via di mezzo tra socialismo scientifico e socialismo utopistico proto-anarchico, fu rappresentata da quegli «utopisti» borghesi come Saint-Simon, Owen che, pur peccando di idealismo, assegnarono, senza incertezze, la palma dello sviluppo sociale e dell’emancipazione universale alle «classi lavoratrici industriali».
Il popolo lavoratore viene modellato come soggetto morale, rispettoso della proprietà altrui. Gli strumenti di lavoro che quotidianamente lo circondano appartengono al datore di lavoro; la reverenza nei confronti delle macchine simboleggia l’ossequio verso chi le possiede. Onestà, disciplina, dedizione al risparmio sono elementi connaturati alla fabbrica trionfante e fanno da solido spartiacque tra lavoro e indolenza. In passato, la figura del salariato e quella dell’extra-legale si sovrapponevano fino quasi a combaciare. L’ordine produttivo, ora, impone una definitiva recisione di quei legami di solidarietà, una classificazione più rigorosa dei soggetti che fin lì erano convissuti nello stesso marasma sociale e avevano condiviso la medesima cultura.
Il ’48 fornisce un primo esempio di questa rottura: lavoratori e fuorilegge fanno parte di due mondi ormai incomponibili. In Francia, la sommossa popolare non sembra oltrepassare le frontiere della «rispettabilità»; gli obiettivi operai sono specifici di una classe subalterna che ha coscienza di sé in quanto strato sociale produttivo, lontanissima dal mondo degli sfaccendati, dei mendicanti, dei ladri, dei delinquenti dei detenuti. Lotta operaia e lotta carceraria non si incontrano neppure nei momenti di maggiore spinta libertaria; ai reclusi non viene riconosciuto neppure il diritto simbolico di cantare la marsigliese. L'atteggiamento popolare nei confronti del carcere e del crimine è rigidamente selettivo. Le porte della prigione di Saint-Lazaro vengono spalancate dalle masse in rivolta, ma solo le prostitute vengono rimesse in libertà.
La giustizia popolare non perdona i vagabondi e i criminali. Alle venditrici di sesso viene dunque riconosciuta l’utilità sociale che le differenzia dalle rimanenti turbe di disonesti, questi ultimi condannati da una morale imperniata su criteri rigidamente produttivi. A questa prima discriminazione se ne aggiunge una seconda, destinata a radicarsi e a informare di sé decenni di politica carceraria della sinistra storica. Si tratta della tolleranza preferenziale verso i reati politici; il movimento del ’48 reclama a gran voce la liberazione degli operai incarcerati per sovversione e dei militari reclusi per insubordinazione. I primi provengono dalle loro file, sono avanguardie che garantiscono la riproduzione politica di un’intera classe; i secondi costituiscono dei potenziali alleati, braccio armato su cui contare per l’instaurazione di un nuovo ordine. Nei confronti dei delitti comuni permane e si approfondisce una netta intransigenza.
L’ordinamento carcerario e gli apparati repressivi vengono contestati solo in alcuni aspetti parziali; l’istituzione carcere in quanto tale vive intatta nei modelli di società rivoluzionaria. E il lavoro carcerario ad essere combattuto, piuttosto, in quanto sleale concorrente del lavoro «libero», attività sottopagata che sfavorisce i produttori esterni, unici per onestà e disciplina a meritare il godimento di un tale diritto. Ed ecco i decreti del Governo Provvisorio; amnistia totale ai militari detenuti; libertà per gli operai condannati in seguito agli scioperi del ’45; soppressione del lavoro carcerario. «...Nel liberare i detenuti politici, nostri fratelli, il Governo Provvisorio intende però mantenere in stretta sorveglianza i responsabili di crimini e delitti contro le persone e la proprietà...».
L’etica del lavoro
L'etica del lavoro è un elemento portante della discriminazione morale fatta, fin dalla rivoluzione francese, tra lavoratori e nullafacenti e scioperati. Non è un caso che l’ideologia illuminista e giacobina si scagli contro gli oziosi! Attraverso le parole di Robespierre è la borghesia nascente che esprime il proprio disegno.
È noto come l’origine del tradeunionismo inglese sia da rintracciare negli ultimi decenni del Settecento. È qui che sorgono le associazioni di tipo mutualistico che riunivano gli artigiani specializzati (Friendly Societies). Le prime organizzazioni di mestiere si strutturano come sette, sono dotate di minuziose regole interne, di statuti bizzarri sull’iter dell’apprendistato e di norme rigorose sulla selezione degli adepti e l’imposizione delle quote associative. Lo spirito che anima le associazioni è quello anglicano, debitore al calvinismo dell’austerità morale, della laboriosità infaticabile, della morigeratezza dei costumi, della oculata e ossessiva previdenza. Gli artigiani associati sono saggi nella cura dell’anima e nella preservazione del corpo: sono frugali, silenziosi, casti: non bevono, non bestemmiano, non scorreggiano. La società per cui si battono è congeniale alla perpetuazione della loro casta; i modelli culturali cui si ispirano, nella enfatizzazione dei meriti individuali della frenesia produttiva e dell’ordinato attivismo collettivo, fanno da sostegno trascendente ai loro privilegi.
L’unionismo cosiddetto di «nuovo modello» perde forse la scorza confessionale ma non l’intima valenza messianica. Lo spirito di sacrificio presente e la proiezione mistica nel futuro lo connotano di una nuova «teleologia laica». Alla gerarchia ecclesiale viene sostituita la classificazione professionale: sono la produttività e l’esperienza lavorativa gli indici che valorizzano alcuni settori sociali, conferendo loro dignità storica, e invalidano inesorabilmente gli altri. Lo stesso Robert Owen accomunava nelle classi produttive i gruppi imprenditoriali e gli artigiani, animati da analoghi sentimenti: fiducia nella scienza, spirito di previdenza, fede nel progresso rigeneratore e nel «self-improvement».
I nuovi artigiani dell’industria del metallo, la cui condizione materiale non viene affatto intaccata dallo sviluppo dell’industria, si arroccano in una potente aristocrazia del lavoro. Altra casta si riunisce nel sindacato di mestiere dei modellisti meccanici (United Patternmakers’ Association), e la severità delle norme interne ne fanno una società di buona condotta, un consesso di lavoratori esperti e rispettabili. E ancora, i privilegiati filatori di cotone si sentono meritevoli di un destino di spicco, prescelti in questo per particolari capacità e inclinazione al sacrificio.
Si delinea qui la fisionomia dei primi funzionari sindacali, casta interna alla casta, nuovi officianti che celebrano i confronti rituali con gli imprenditori. E l’idea dei «closed shops» verrà tramandata fino ai giorni nostri: l’assunzione di forza-lavoro qualificata deve passare attraverso la consulenza preventiva degli associati di questo o quel mestiere.
In comune le prime associazioni industriali di mestiere posseggono la consapevolezza della propria insostituibilità nel processo produttivo; all’abilità lavorativa abbinano la conoscenza di una parte del ciclo, tradizionalmente trasmessa da padre in figlio. (E il sacrale rispetto dell’istituzione famiglia non è connesso alla possibilità di trasferire i privilegi materiali di generazione in generazione?). Le aristocrazie del lavoro specializzato condividono il disprezzo per i «labouring poors», i lavoratori meno favoriti destinati al «sweated work», portatori di una cultura antitetica alla prima, beffarda verso il puritanesimo artigiano, incline all’egualitarismo e all’autodeterminazione collettiva.
Etica del lavoro e attività artigiana
Prima dell’operaio esiste l’artigiano. L’attività che questi esplica è limitata al mestiere e ai suoi segreti. Non è dunque un’attività che può trasformare e migliorare il mondo. Si tratta, piuttosto, di un’arte: un’arte che tramandata di padre in figlio, di maestro in discepolo, è immutabile, sempre uguale a sé stessa. Il lavoro, in questo contesto, assume il significato più alto della creatività professionale. È il segreto della trasformazione-creazione, mediante procedimenti esclusivi, della materia in prodotto. Il dominio assoluto dell’artigiano sugli strumenti di lavoro e la sua realizzazione nel prodotto finito (che appare sempre come «capolavoro», prodotto non-riproducibile), fanno sì che tale attività venga assunta come simbolo dell’armonia, tra mente e braccio, tra individuo e società. L’ideologia dell’artigiano che esalta il lavoro di mestiere è contro «l’inumana filosofia della macchina».
Essa oppugna, dunque, alla grande fabbrica e al processo industriale che non solo rivoluzionano i misteriosi gesti della creazione «unica», ma espropriano i lavoratori di ogni possesso dell’utensile, di ogni reale intimità con il prodotto finito.
Come è possibile che, nonostante il rovesciamento dei valori armonici operato dalla grande industria e dal processo produttivo meccanizzato, venisse recuperata l’etica del lavoro produttivo? Perché l’operaio, nonostante la spietata critica al lavoro industriale, che sarà organicamente sviluppata da Marx (ma che già era contenuta nello stesso Fourier, in Owen e, perché no in Smith, ecc.) finisce per recuperare il lavoro come valore, come unità di misura (universale) della società presente e del suo rovesciamento in divenire?
Tutta l’ideologia borghese (giacobina) trasuda di acclamazioni e entusiasmi per il lavoro produttivo. Saint-Simon si spella le mani nell’applaudire i «lavoratori industriali» nei quali comprende, senza distinzione, capitalisti e operai.
Robespierre e il suo Stato Austero perseguitano senza posa gli oziosi e i nobili, ma non possono fare a meno di favorire e stimolare gli interessi, altrettanto egoistici, della nuova classe in ascesa: la borghesia.
Danton, capo degli indulgenti, reo, tra l’altro, di essersi arricchito velocemente speculando sui beni degli aristocratici, muore gridando la sua buona fede. Al parassitismo della rendita egli ha sostituito, da buon precursore borghese, il parassitismo finanziario!
Il lavoro, secondo l’accezione borghese (un tantino equivoca a guardarla dal lato proletario) è dunque la vera bandiera che sventola sulla Bastiglia. Ma oltre questa indiscussa subalternità ideologica, secondo la quale per essere liberi, in base ai diritti democratico-borghesi, occorre innanzitutto guadagnarsi il pane, c’è nell’etica proletaria del lavoro sia la garanzia che la prefigurazione di una «futura società felice».
Si sogna il giorno in cui la rivoluzione degli sfruttati distruggerà la fabbrica che fagocita la vita di milioni di sfruttati; ma intanto si esalta la morale sana e costruttiva di chi produce...
Curioso davvero che un movimento organizzato, un’ideologia politico-sociale antiborghese e anticapitalistica abbiano, e continuino ad avere, un rispetto reverenziale per il lavoro. E non il lavoro astratto, ma il lavoro storicamente determinato! Quello di fabbrica, di officina, di miniera!
Utopismo e lavoro
Il socialismo utopistico e l’ideologia pre-marxiana, pur disprezzando manifestamente la grande industria e auspicando il ritorno all’armonia del mondo artigiano, rurale, retto da leggi di cooperazione e associazione (si veda Proudhon, Fourier o, più tardi, lo stesso Marcuse) esaltavano ugualmente il lavoro.
La liberazione totale dell’uomo si sarebbe realizzata, secondo costoro, mediante due condizioni strettamente intrecciate. Prima: l’instaurazione di una libera, diretta e egualitaria associazione di scambio (e baratto) fra i produttori. La mutua relazione economica avrebbe instaurato un equilibrio di mercato spontaneo basato sul reciproco utilitarismo egualitario.
Secondo: per mutare le abitudini e «recuperare» gli uomini «traviati» dal capitale occorreva instaurare un sistema pedagogico pervasivo. L’educazione, in tutte le sue forme (primariamente quella naturale della famiglia e della società) avrebbe istruito alla giustizia, all’uguaglianza, all’amore le nuove generazioni, realizzando così il «paradiso in terra».
Concezione pedagogica e libero scambio egualitario risultano quindi indissolubili nella ideologia «pre-marxiana» e «utopistica». I teorici delle varie forme associazionistiche, dalle comuni di Fourier alle cooperative di Proudhon, credevano quindi necessario affermare innanzitutto il modello mediante l’esempio, la testimonianza: dunque, il lavoro esemplare. Erano cioè convinti che bastasse realizzare un prototipo da mostrare al mondo, per cambiare ogni altra falsa e nociva organizzazione sociale. Le false idee, non le spietate leggi oggettive erano, secondo loro, la causa dei malesseri e della miseria sociale!
Centralità del lavoro produttivo e controllo operaio
La questione della professionalità è centrale per capire e spiegare l’etica del lavoro, sia dentro che fuori l’ideologia «utopistica». Fare bene, con competenza, è considerato dall’ideologia rivoluzionaria, sinonimo di «pensare bene», essere intelligenti, coscienti, ecc. Di qui nasce, sviluppandosi con incredibile facilità, la concezione del lavoratore più bravo, più «padrone del mestiere» che diviene anche avanguardia, leader riconosciuto, guida morale e politica!
L’autorità del capo operaio nasce dalla autorità del suo mestiere, della sua abilità, pazienza, anzianità nello svolgere il lavoro alienante e distruttivo cui lo costringe il padrone.
La concezione rivoluzionaria e sovvertitrice che si dà dentro questa apparente acquiescenza e sottomissione alla schiavitù del lavoro è la seguente. L’operaio che sa il suo lavoro entra nei segreti della fabbrica, penetra i recessi del mostro capitalista. Impara, poco alla volta, a conoscere gli strumenti e i mezzi del dominio. Lo schiavo esce, così, dalla caverna platonica. Distingue le ombre dagli oggetti reali e, in ultimo, le cause prime di questi o di quelle dalle loro manifestazioni. È un principio di lenta modesta appropriazione della conoscenza, del sapere e del dominio, quella che si compie attraverso l’esplicazione del mestiere. O almeno: questa è la giustificazione razionale che si può dare - l’unica - di una tale etica «del lavoro contro il lavoro».
Solo chi avrà dimostrato di possedere sufficiente familiarità e dimestichezza coni sottili strumenti di alienazione e sfruttamento del capitale potrà, infatti, permettersi di sfidarli, mettersi alla testa degli altri operai e convincerli a lottare contro il Moloch.
Principio morale e prassi politica vengono a fondersi. L’operaio professionale del XIX secolo contiene in sé sia il principio della creatività negata, sia il principio della realizzazione futura. Entrambi si esercitano e si tramandano in virtù del lavoro produttivo.
Ma cos’è che può trasformare e rovesciare dalle fondamenta la società presente, secondo il marxismo rivoluzionario? Non certo l’educazione non certo la morale esterna. La società nuova nascerà non dall’educazione, non dalla testimonianza illuminante; ma dallo sviluppo combinato e dialettico tra condizioni oggettive e crescita soggettiva del proletariato.
In questo teorema l’etica del lavoro si nega in quanto etica e si esalta in quanto prassi trasformativa.
Il lavoro operaio, inteso come leva di trasformazione e abbattimento del sistema capitalistico complessivo, risulta subalterno all’apparato di dominio borghese e alle leggi generali del capitale. Ma, dal punto di forza della centralità produttiva e tecnica del ciclo, agisce per rovesciare tale subalternità in egemonia tendenziale. Come, con quali mezzi?
Gramsci e il controllo operaio diretto
Il lavoro operaio e, per estensione, la classe si presentavano al contempo centrali, subalterni e tendenzialmente egemoni nel ciclo e nella società capitalistica. Queste apparenti antinomie venivano, nella ideologia rivoluzionaria, superate dal seguente ragionamento. La centralità produttiva operaia nel ciclo industriale è anche immediatamente subalternità economica, in quanto essa vive il suo rapporto col capitale in forma di forza lavoro espropriata dei mezzi produttivi, ecc.
Mediante la conoscenza sempre più approfondita e vasta del ciclo, la classe può, tuttavia, raggiungere un controllo effettivo sul processo produttivo, il suo funzionamento e la sua riproduzione. Quella espropriazione originaria da cui deriva la subalternità può essere superata gradualmente dal controllo diretto dei produttori sull’intero ciclo. La classe operaia conosce, si forma una scienza del controllo tecnico che è anche sapere rivoluzionario.
Di qui la teoria (che Gramsci renderà organica ad una fase specifica dello sviluppo industriale in Italia) del controllo operaio e, per certi versi della autorganizzazione di classe. I produttori socializzati dall’organizzazione di classe storica (il partito storico) che nasce, a sua volta, dalle loro esigenze mature di egemonia politica e sociale, ricompongono le conoscenze del ciclo, ottenute direttamente, mediante il lavoro e la conoscenza professionale. Nasce così una lettura complessiva diretta del terreno industriale, a partire dalla quale le forze operaie possono unirsi e marciare per la conquista della centralità politico-sociale. Ma tale centralità, una volta realizzata, altro non è che egemonia rivoluzionaria. In questa concezione due sono i momenti fondamentali del rovesciamento della subalternità in centralità e della identificazione della centralità con l’egemonia.
Primo: lo sviluppo delle forze produttive, la fabbrica altamente massificata e socializzata, fanno si che tutta la società industriale sia improntata sul modello e sulle regole dell’industria. Il ciclo industriale diviene perciò centrale all’interno del sistema complessivo. Conoscere il ciclo significa conoscere il cuore del sistema.
Secondo: la classe operaia non solo produce tutta la ricchezza ed è fondamentale per la riproduzione delle classi non direttamente produttive, ma ha la possibilità di impadronirsi, grazie alla conoscenza diretta del ciclo, anche di quel sapere tecnico che la espropria.
Ne discende che: se, a differenza della classe borghese che fece la rivoluzione a partire da una egemonia economica dispiegata (proprietà dei mezzi di produzione, ecc.), la classe operaia non si trova in questa situazione oggettiva, nondimeno essa ha la possibilità di gestire meglio e più razionalmente la ricchezza che è sua, e che le viene costantemente sottratta dal capitale e dalla classe borghese. Al posto del possesso e della proprietà giuridica la classe operaia pone come strumento sostanziale della economia «il piano». Il piano sta alla classe operaia egemone, come la proprietà dei mezzi di produzione sta alla borghesia.
In Gramsci, allora l’egemonia operaia si dilata fino a coprire diversi piani che si intersecano. La centralità dell’operaio professionale è economica, in quanto indispensabile alla produzione di ricchezza; tecnica, in quanto dotata di conoscenza del ciclo produttivo; sociale, perché egemonizza tutti gli altri strati proletari nella creazione di una nuova società; è infine politica in quanto si auto-organizza e dirige l’intero processo rivoluzionario. L’operaio professionale incarna il futuro dirigente complessivo: possiede un patrimonio tecnico-conoscitivo autosufficiente e controlla il completo dispiegarsi della produzione. La sua figura, modellandosi sui principi dell’auto-governo, può creare nuove istituzioni dominanti, nuova cultura; può sostituire il governo borghese in tutte le due funzioni (economiche, ideologiche, culturali, giuridiche, ecc.).
Certo, gli operai professionali non sono socialmente maggioritari, ma gli altri settori proletari, figure monche al confronto, saranno trascinati dai primi nel flusso dell’emancipazione... È la fascia di classe più globalmente preparata e cosciente a dirigere... Non per questo si può parlare di partito formale, in quanto non vige qui il principio della delega, lo strato dirigente della classe operaia si auto-organizza: il partito è storico, nell’accezione marxiana, e si costituisce naturalmente e parallelamente allo sviluppo delle forze produttive. La conoscenza, in questo caso, è interna, è di tipo empirico-induttivo; nell’idea di Gramsci, la padronanza nell’uso degli strumenti di lavoro qualifica l’operaio professionale alla funzione di agente storico della trasformazione sociale.
L’unica mistica che, in fondo è dato ritrovare in una tale accezione di controllo rivoluzionario diretto è quella della razionalità, che nasce dalla definizione di operaio-intellettuale. Forza e ragione, conoscenza e sapere controllo e potere, piano e stato sono perfettamente armonizzati e nascono da un solo soggetto: il produttore.
E va da sé che una tale accezione di processo rivoluzionario era assai diversa dalla religione e sentimental-utopistica del partito socialista e dalle ideologie pre-marxiste. L’instaurazione del nuovo mondo era certezza scientifica basata su dati concreti e verificabili. Al massimo si poteva esaltare e feticizzare l’organizzazione e l'autocoscienza dei lavoratori: ma la loro collocazione nel presente, per un rovesciamento politico dei rapporti esistenti, era indubbia.
Si pensi al biennio rosso e agli operai asserragliati nella Fiat che davano lezioni di autoorganizzazione e di «morale concreta» a tutta la società, facendo funzionare la fabbrica, progettando trattori, costruendo armi... senza bisogno di tecnici, capi e controllori. Ecco il punto che armava di incrollabile fede questi lavoratori: l’autogestione sapiente e complessiva del ciclo dimostrava la possibilità di egemonia su tutti gli altri processi sociali. Gli operai sapevano mandare avanti le fabbriche, senza l’intervento di chicchessia. La borghesia era inutile! Diventava parassitaria, come lo era stata, a suo tempo, la nobiltà. Così autogestione e piano conferivano un’investitura economica rivoluzionaria ad una classe che, pur centrale dal punto di vista produttivo, non possedeva, di fronte al dominio, che le sue braccia, la sua forza lavoro.
E chiaro, dunque, il perché della valorizzazione del lavoro di fabbrica e del mestiere. Solo stando nella fabbrica il proletario poteva non essere più sfruttato, poteva cioè conoscere, controllare, organizzarsi per la sua emancipazione dalle catene del capitale.
Fine del controllo diretto e affermazione della conoscenza esterna
L’esito fallimentare del «biennio rosso» impone una revisione dell’intero apparato teorico gramsciano. L’operaio professionale, pur nella completezza pratico-teorica che lo contraddistingue, non è in grado di autorganizzarsi in quanto è privo di anima politica. Forte sul piano tecnico ed economico, è debole nella strumentazione più puramente politica. Lukács, nel commentare l’insuccesso dei «consigli operai», indica negli episodi torinesi, una lezione impartita all’intero proletariato mondiale sui pericolosi limiti di un’azione unilateralmente sindacalista. «... L’Internazionale Comunista rifiuta nel modo più categorico l’opinione secondo la quale il proletariato può compiere la sua rivoluzione senza avere un partito politico...»
La lotta di classe esige centralizzazione e direzione unica delle diverse forme del movimento proletario. È la concezione leninista classica che viene affermandosi: formazione esterna di quadri, agitatori propagandisti che si dedicano, in quanto rivoluzionari di professione a capire la realtà materiale ed elaborarla secondo i principi del partito; tra smettere questi dati concettualizzati alle masse sotto forma di indottrinamento politico e di organizzazione rivoluzionaria. Essi non sono quindi solo maestri, ma artefici e trasformatori sociali della realtà esistente. La classe operaia professionale è parte integrante di questo processo, le cui formanti ideologiche, politiche e organizzative, sono però esterne. Nonostante la conoscenza del ciclo sia diretta, questa:conoscenza non porta a principi di autorganizzazione e di autoformazione del proletariato. La centralità produttiva rimane inalterata, ma non certo quella politica, delegata a un cervello esterno, sede di elaborazione privilegiata di pensiero rivoluzionario: è il trionfo del partito formale. Ancora Lukács: «... Il proletariato applica la dittatura anche a se stesso. Questa misura si rende necessaria per mantenere in vita il proletariato, qualora manchi la corretta conoscenza e l’orientamento volontario degli interessi di classe...».
Controllo operaio indiretto e delega politica
Mediante la ristrutturazione forzata del ciclo, l’introduzione di tecniche labour saving, l’attacco politico all’autonomia operaia, la centralità produttiva viene come sommersa dalla subalternità economica e dalla mancanza di controllo tecnico e di conoscenza diretta. Insomma, la fabbrica si avvia a diventare «cattedrale nel deserto».
Questa fase durerà in Italia almeno dal dopoguerra al ’68, per riprendere (dopo una frattura di oltre cinque anni) nel 74-75 e giungere fino ai nostri giorni.
Col taylorismo, la conoscenza diretta viene completamente dissolta. Non più agente cosciente del processo produttivo, l’operaio-massa non può che investire i suoi rappresentanti esterni dei compiti tecnico-conoscitivi e politico-elaborativi. La forma-partito revisionista segue, nel suo modellarsi, lo sviluppo del modo di produzione e si adegua alle trasformazioni da esso indotte.
Ma taylorismo vuol dire anche educazione morale, oltre che produttiva, disciplina spirituale oltre che lavorativa. L'elementarità del gesto sembra rimandare a un’analoga elementarità e povertà culturali. L’organizzazione scientifica del lavoro impone anche norme extra-lavorative, modella il comportamento anche fuori del luogo di produzione. Il revisionismo apprezza i risvolti antropologici del taylorismo e li esalta; l’organizzazione scientifica del lavoro è idonea al progressivo auto-disciplinamento della comunità lavorativa e dell’intera umanità.
Nel progetto revisionista occorreva, dunque, fatto salvo il principio della centralità produttiva, continuare ad esaltare il lavoro operaio come valore - ma solo nelle categorie più qualificate e professionalizzate.
Nasce così la prima scomposizione scientifica di classe, la prima stratificazione cosciente della classe operaia centrale e, di conseguenza, le successive disgreganti distinzioni tra operai del ciclo principale e «marginali», garantiti e no, ecc.
Se prima erano tutti gli operai di mestiere, quelli interni al ciclo, a rappresentare i potenziali becchini del sistema, in quanto produttori globali, ora, poco per volta, le varie forme di centralità si dislocano lungo la linea, come attributi diversi corrispondenti alle mansioni del ciclo. Si avrà così una centralità tecnica e sociale massima per le mansioni più qualificate: una centralità produttiva più intensa per i lavoratori di linea (cui corrisponde una scarsa egemonia) ecc. La ricomposizione della conoscenza, e quindi del controllo di tutto il processo produttivo, subisce una notevole battuta d’arresto. In alcuni segmenti è il sindacato a conoscere e a «controllare» istituzionalmente il processo lavorativo mediante le sue articolazioni; in altri reparti è la base operaia a imporre direttamente le sue esigenze... In ogni caso non esiste più una figura centrale unificante di produttore e, di conseguenza, non esiste più una teoria collettiva del controllo che si presenti come egemonia storica autorganizzata.
Egualitarismo ed egemonia dell’operaio di massa
È nota tuttavia la risposta di lotta dell’operaio di massa. L’operaio di linea formatosi negli anni ’60 risponde all’espropriazione tecnica e politico-sociale del ciclo lanciando la parola d’ordine dell’inchiesta (conoscenza diretta) che dovrebbe portare, attraverso l’autorganizzazione e l’autoformazione rivoluzionaria, al controllo operaio su tutto il ciclo produttivo.
Avviene un ribaltamento radicale. La conoscenza diretta, in questo caso, serve a trasformare in modo rivoluzionario tutta la realtà esistente: la conoscenza è trasformativa. I suoi soggetti immediati sono i produttori espropriati di tutto (operai comuni).
Mediante la proposizione di un obiettivo di lotta unificante - l’egualitarismo salariale e normativo - e mediante la pratica massiccia di lotta, gli operai delle grandi fabbriche riuscirono a ristabilire condizioni analoghe a quelle del passato. Ovvero: la centralità produttiva dell’operaio di linea poté esplicarsi in controllo tecnico sul ciclo, facilitato anche dall’inchiesta operativa (cortei, ramazze, fusione dei reparti in lotta, inchieste rivendicative, ecc.). A sua volta questo patrimonio di conoscenza-controllo costituì il supporto alle rivendicazioni sociali e ai comportamenti egemonici della fabbrica. È significativo, e va sottolineato, come, di fatto, l’operaismo della fine anni ’60 - che investì e contagiò anche altre componenti sociali: dagli studenti agli impiegati, dagli intellettuali ai detenuti - sia stato una manifestazione analoga al tipo di egemonismo diretto descritto da Gramsci.
Il controllo operaio contro gli operai
Ma era ben questo il processo tanto temuto, sia dal padronato che dai riformisti. La possibilità di trasformare la centralità produttiva in controllo tecnico - e questi in egemonia politica tendenziale - spaventa tutti i settori antioperai e controrivoluzionari.
D’altra parte l’operaio-massa, sotto i colpi della ristrutturazione politica e tecnologica, era destinato a scomporsi in nuove figure produttive, decentrate e disperse, e a smarrire la propria centralità politica e sociale.
Una volta istituzionalizzata la domanda di potere nata dalle lotte, attraverso la creazione di organismi di delega e di controllo indiretto, la sua funzione quantitativa nel ciclo venne indebolita da nuove figure professionali che ne ostacolavano e ne espropriavano la conoscenza diretta.
Il lavoro operaio torna ad essere un feticcio, come sempre lo è stato nelle teorie antirivoluzionarie. Lavorare non è un valore se il lavoro produttivo non è sinonimo di altro: controllo sui meccanismi dei sfruttamento, egemonia tendenziale sul Comando, distruzione futura dello stesso lavoro alienato.
Ora, di nuovo, solo la professionalità «operaia» che sfuma nel controllo antioperaio partecipa realmente ai livelli di controllo tecnico e di centralità politica. Le categorie non stabili, non professionali, non inseribili in un disegno gradualistico di miglioramento sociale, o sono represse, o sono abbandonate a se stesse o, come nei casi più recenti, vengono licenziate, ricacciate nel ciclo sotterraneo del lavoro sommerso...
Così il famoso controllo diretto, divenuto indiretto si avvia a trasformarsi in controllo «operaio» contro gli operai!
Le ultime espressioni di inchiesta diretta vengono da gruppi armati sostenitori della centralità operaia. Questa conoscenza diretta, però, non trasforma né la realtà della fabbrica secondo il discorso classico del controllo operaio, né i rapporti sociali in base all’auto-organizzazione di classe che questa teoria-prassi dovrebbe indurre. La conoscenza interna del ciclo, dunque, viene sottomessa e finalizzata a formanti esterne di tipo dottrinario e organizzativo. Il rilancio di un operaismo chiuso su se stesso trova sempre di meno le basi oggettive su cui puntare un progetto di riproduzione allargata del controllo operaio, e di proiezione sociale dello stesso. Si verifica perciò che all’accerchiamento della fabbrica centrale da parte del ciclo diffuso e alla ristrutturazione, sia tecnica che politica, dell’intero ciclo sociale (di produzione e riproduzione), corrisponde l’arroccamento sempre più dogmatico e soggettivo dell’operaismo dei gruppi. La conoscenza diretta è il «controllo operaio», invece di portare a ipotesi di autoformazione e di autoorganizzazione, con proiezione sociale, delle componenti proletarie, diventano pretesto per rilanciare formanti esterne e dottrine dirigistiche, funzionali alla riproduzione e alla soggettività della forma-partito. Quale la centralità operaia sostenuta dai gruppi?
L’operaio-produttore, nella accezione originaria, rappresentava il soggetto totale della trasformazione. La base concreta della sua supremazia era data dal fatto che essa meritava la direzione della società e poteva, da subito, farsi parte dirigente, nella lotta come nel governo, grazie alla sua collocazione creativa e trasformativa. La sua egemonia risultava dunque intrinsecamente meritocratica, sia contro la classe borghese, sia verso i ceti piccolo-borghesi, ma anche nei confronti delle componenti proletarie «non produttive», marginali e extralegali.
Con la progressiva scomposizione produttiva e sociale, intervenuta nel corpo stesso della classe operaia centrale, tale ruolo intrinsecamente meritocratico è stato assegnato a ristrette componenti (élite o aristocrazie tecniche) operaie, la cui centralità produttiva (per il padronato e i riformisti) è stata abbinata alla centralità politico-sociale delegata. L’operaio-massa si è trovato così espropriato di ogni «investitura meritocratica». Anzi: per ottenere un qualche riconoscimento ha dovuto accettare, a testa bassa, i gradini discriminatori imposti dal comando capitalistico e sottoscritti dai riformisti. Non più la classe nel suo insieme, ma solo ristretti gruppi o individui di questa classe sono stati battezzati dalla controparte e dai suoi alleati «meritevoli» di Progresso, aumenti, considerazione, ecc.
La professionalità, prima identificata col mestiere, è divenuta sinonimo di sottomissione e subalternità felice alle scelte capitalistiche. Conoscere il ciclo, «controllarlo» è divenuto sinonimo di coadiuvazione del comando o, in eufemismo, di «cogestione delle scelte imprenditoriali».
Ora, per un certo periodo (stando almeno ai testi ufficiali), i gruppi armati hanno considerato loro referente la classe operaia senza distinzione di sorta, trovandosi così ben presto da un lato a «competere» ideologicamente e politicamente con la base materiale del revisionismo; dall’altro a giustapporre il controllo diretto all’egemonia (delegata) del «partito armato».
L’unico controllo diretto possibile nella fabbrica, dopo gli anni caldi, una volta tramontata la parola d’ordine egualitaria, era quello che alcuni operai, appartenenti al ceto «comune» più sfruttato, delegavano, sotto forma di militanza organica, alla formazione combattente. La delega, invece di essere istituzionale, era armata, ma la forma non mutava la sostanza.
Anche tra le file dei gruppi combattenti veniva calato il principio del controllo indiretto, della delega all’apparato complessivo esterno.
La conoscenza proveniente da alcune componenti operaie era raccolta, elaborata e usata a fini militari e operativi, oltreché propagandistici, dall’apparato esterno. Gli operai non si riappropriavano direttamente del ciclo e delle gerarchie per rovesciare sul Comando tale conoscenza, bensì per rifondere questo sapere nella linea strategica complessiva dell’apparato esterno.
Concezioni più recenti che riconoscono la scomposizione operaia in atto e propongono definizioni più soggettive, come quella di operaio metropolitano, non danno ugualmente ragione della complessità dei processi in atto e del loro superamento.
La realtà è tale da non poter essere risolta con le formule.
Il potenziamento del concetto di professionalità e di centralità esterna, delegata alle istituzioni e ai partiti, è reso sempre più razionale e funzionale dalla «rivoluzione informatica».
Se da un lato essa flessibilizza e spezza, tendenzialmente, ogni rigidità tecnica e umana del ciclo, dall’altro punta alla individualizzazione delle mansioni e dei ruoli.
Se il taylorismo era il teorema della parcellizzazione produttiva applicato alla organizzazione del lavoro, la informatizzazione (o fase post-taylorismo) rappresenta qualcosa di più complesso.
L’atomizzazione e la segmentazione dei gesti e delle mansioni sono ulteriormente esasperate. Il colloquio a tre: Comando-macchina-operaio che il nuovo ciclo intende instaurare mediante il controllo cibernetico, fa si che anche la gerarchia intermedia sempre più assuma il ruolo di veicolo comunicazionale, perdendo via via prerogative decisionali.
Ciò è possibile con l’introduzione di sistemi individuali o collettivi (a responsabilità individualizzata) di feedback, ovvero di retroazione, capace di trasferire nel gesto, nell’operazione del singolo produttore, il «messaggio del Comando» che viene così dislocato lungo l’intero ciclo e reso esecutivo dal terminale uomo o macchina-uomo.
Si ha pertanto una sorta di materializzazione del Comando nel singolo pezzo (lavorato, semi-lavorato, ecc.) e nella singola operazione, i quali controllando la loro perfetta esecuzione realizzano al tempo stesso: l’autocontrollo del terminale (il classico feedback così utile contro sabotaggi, scarti, falle, ecc.!) e la massima circolazione/penetrazione del Comando.
Se per Taylor il produttore ideale era la scimmia, per il sistema robotizzato è la scimmia sintetica (elettronica). O, in mancanza di questa, un tipo di esecutore in grado di offrire la massima affidabilità.
Va da sé che solo un produttore-terminale sottomesso al «messaggio del Comando», disposto a materializzarlo nella esecuzione ottimale, può permettere l’instaurazione di cicli così altamente sofisticati.
La rivoluzione informatica, come il Fordismo e più del Fordismo, necessita di un controllo totale sui produttori-terminali. Le trasformazioni dell’organizzazione del lavoro industriale devono essere dunque anche trasformazioni dell’organizzazione sociale del lavoro.
Il produttore-terminale, per essere tale, deve venire inserito in un contesto che ribadisca e «chiuda» la sua collocazione nel ciclo di fabbrica. L’individualizzazione produttiva è dunque anche individualizzazione economica, sociale, ideologica, morale, ecc...
Il taylorismo, suo malgrado, aveva permesso una morale collettiva, una conoscenza operaia, un potenziale controllo sul lavoro alienato da parte della Classe: tutti fattori che congiuravano a favore della emancipazione proletaria. La ristrutturazione tecnologico-politica del presente punta ad annientare i residui di un tale passato e ogni loro virtuale rinascenza...
L’epoca del produttore-terminale, dell’operaio altamente individualizzato dalla mansione professionale sì è già aperta.
La spaccatura tra classe operaia ufficiale e rappresentata e «proletariato pericoloso» passa ormai indifferentemente nelle officine come nei quartieri, nelle grandi fabbriche come nell’economia sommersa...
L’ideologia che sostiene non è più vagamente evoluzionistica e ipocritamente positivista, come nel passato! È smaccatamente borghese: efficienza, onestà, disciplina significano carriera, sottomissione, complicità col Capitale, il Comando e il loro «sviluppo oggettivo».
Sembra che, almeno in casa riformistica, abbia vinto la tesi tecnocratica dello sviluppo delle forze produttive che emanciperà i lavoratori (e già premia i più virtuosi tra essi).
Ma non è solo ideologia, traviamento revisionista o avvelenamento del pensiero operaio.
Sull’altro lato, sul versante del movimento, i compagni tentano nuove strade di comprensione e pratica rivoluzionaria.
La conoscenza e il controllo diretto, interni ed esterni al ciclo di fabbrica, possono emergere solo dalla lotta di classe. Nessuna ricetta, nessun prontuario del «buon militante» possono surrogare la prassi.
Queste note schematiche e a tratti provocatorie; queste chiavi di lettura che sottoponiamo ai compagni e al dibattito militante vogliono dunque riaffermare il primato della prassi. Ma intendiamo anche richiamare l’attenzione e le energie del movimento su riflessioni critiche e autocritiche non più rinviabili.
Riprendere la lotta, dunque, ma sua loro espressione più alta: l’Unità di pensiero e di azione.
Ho raccolto la vostra interessantissima «proposta di ricerca collettiva» contenuta nell’articolo «classe operaia, etica del lavoro, proletariato pericoloso» del numero di Maggio di «Controinformazione», cercando di essere al tempo stesso il più sintetico e il più connesso possibile. Ne è uscito fuori un guazzabuglio prolisso e sconnesso, data l’urgenza che sentivo di toccare molti discorsi, a mio parere, importanti. Ma forse sintesi e connessione possono uscire fuori solo da un dibattito e da un lavoro collettivo... Dobbiamo addentrarci in nuove regioni, metterci in viaggio, se vogliamo scoprire nuovi mondi. E occorre almeno avere un’idea chiara di che cosa è il vecchio per riconoscere il nuovo. Che non ci accada come a Cristoforo Colombo che arrivato in America disse: «Toh! ecco le Indie Occidentali!», invece erano le Antille. Ma Colombo non era mai stato neppure in India.
Siamo abituati a negare il nuovo designandolo con vecchi nomi. Ma per nuove cose ci vogliono nuovi nomi. Per designare i nuovi continenti bisogna inventare nuovi linguaggi e per vedere nuova terra bisogna dotarsi di nuovi occhi.
1. Dalla centralità produttiva alla centralità rivoluzionaria
L’analisi ed il concetto di classe operaia non possono essere riferiti solo alla produzione, in quanto produzione immediata, poiché questo significherebbe limitarsi ad una lettura riduzionistica del materialismo storico. L’analisi ed il concetto di classe operaia devono, piuttosto, essere riferite alla riproduzione dei rapporti sociali di produzione, a ciò che caratterizza un modo di produzione dal punto di vista sociale.
Il materialismo storico non è una «dottrina economica»; ma è una critica dei rapporti sociali vigenti dal punto di vista della loro trasformazione rivoluzionaria. Alla luce del materialismo storico occorre rileggere il «Capitale». Vedere una centralità produttiva della classe operaia è restare dentro il capitale; allora più correttamente ha ragione Carli quando parla di centralità dell’impresa. La centralità nel processo di valorizzazione, ma anche nel processo lavorativo, che è quello sussunto nel modo di produzione capitalistico, è centralità dei mezzi di produzione, del lavoro morto, del capitale, della forza lavoro in quanto capitale. La centralità del lavoro produttivo è centralità del plusvalore, della produzione di plusvalore. Autovalorizzazione del capitale.
Al contrario della definizione smithiana che vede la merce, e quindi il lavoro producente merci, in primo luogo come lavoro concreto e quindi come prodotto fisico, per Marx la merce - in quanto prodotto del capitale - cristallizza lavoro astratto e quindi è un prodotto sociale, ed è «materiale» da questo punto di vista (contro lo spiritualismo si deve precisare che lavoro astratto non è pura essenza, ma contro il materialismo volgare si deve precisare che l’uomo non è un uovo).
«La materializzazione ecc. del lavoro non va tuttavia concepita nel senso in cui la concepisce Smith. Quando noi parliamo della merce come lavoro materializzato - nel senso del suo valore di scambio - non intendiamo se non un modo di esistenza che ha luogo nella rappresentazione, cioè puramente sociale, che non ha niente a che fare con la sua realtà fisica; la merce viene rappresentata come un determinato quantum di lavoro sociale o di denaro. Può darsi che il lavoro concreto di cui essa è risultato, non vi abbia lasciato nessuna traccia» (Marx «Storia delle teorie economiche»). Non è la produzione di merci che contraddistingue il lavoro produttivo, nel modo di produzione capitalistico, bensì la produzione di plusvalore. La merce, in quanto prodotto di capitale, è un involucro che racchiude cristalli di valore.
Non c’è nessuna centralità conseguente all’essere lavoratori produttivi di plusvalore, c’è solo disgrazia e miseria, c’è solo produzione e riproduzione delle proprie catene e dei propri padroni. Essere lavoratori produttivi è oggettivo perché si diventa oggetti dei mezzi di produzione-capitale. Oggetti di oggetti. La classe operaia, in quanto forza lavoro, è riproduttrice di capitale, cioè di rapporti sociali che la subordinano alle cose.
Centralità del plusvalore significa centralità del dominio di una classe su di un’altra, centralità di questo rapporto sociale; ma questa centralità significa anche - e in antitesi - centralità della lotta di classe rivoluzionaria, centralità di questa trasformazione sociale.
Conseguente al mito riduzionistico della centralità produttiva della classe operaia è sempre stato il mito riduzionistico della centralità politica della classe operaia. (Per Marx l’uomo non è né principalmente un «costruttore di strumenti» né principalmente un «animale politico», ma è principalmente un «individuo sociale»).
Lenin parla di un oggetto politico specifico da distruggere: lo Stato borghese, ma accenna anche alla «dittatura del proletariato» come di un «semi-Stato» in via di estinzione. Non credo sia conveniente pensare alla rivoluzione proletaria, in ogni suo atto, come «semi-politica». Il proletario, sosteneva Marx, deve rivendicare un solo atto politico: quello di distruggere la società borghese: «ogni rivoluzione rovescia il vecchio potere: in questo senso è politica».
La politica è l’arte del dirigere, è l’arte del potere. In una società senza classi e senza Stato non ci sarà più bisogno di realizzare la nostra «natura umana» dirigendo e dominando altri uomini, altrimenti che accidenti stiamo facendo?
La centralità politica è dunque solo transitiva, è un ponte che occorre minare e fare esplodere non appena attraversato; per non tornare indietro...
Di queste macerie resta soltanto la centralità rivoluzionaria del proletariato (con tutte le differenze e le distinzioni; capitalisti commerciali, industriali e finanziari, sono un’unica classe: e così analogamente il proletariato); centralità che ha come scopo quello di affermare e realizzare i bisogni sociali immediati e i rapporti sociali possibili e che il proletariato può vendicare solo negandosi come forza lavoro e anche come classe. Centralità rivoluzionaria della classe non come in sé o per sé, ma contro di sé e fuori di sé, nell’essere processo della sua negazione e del suo superamento.
Occorre aggiungere per l’immediato, che centralità all’interno di un «sistema di potere» è sempre una centralità relativa a delle «coordinate di riferimento» e a condizioni determinate; ed è anche una funzione reversibile agli altri termini che fanno parte dello stesso sistema. Centralità non meccanicistica, ma dialettica, significa essere al centro, ma girare anche attorno agli altri che girano e girare tutti quanti assieme, espandendosi, attorno ad un altro centro che è sempre fuori della circonferenza. Questa è la dialettica delle spirali contrapposta alla dialettica delle sfere. La terra gira attorno al Sole, ma anche il Sole si gira rispetto alla terra e tutto il sistema solare gira attorno ad un immaginario (cioè non irreale) fuoco centrale della galassia di cui il sistema solare fa parte. Centralità rivoluzionaria è centralità del compito, centralità della trasformazione. Il compito centrale e rivoluzionario del proletariato non è quello di sostituire alla dittatura di una classe la dittatura di un’altra classe, ma quello di sostituire alle classi gli uomini e le donne liberati.
Perché il proletariato può assolvere a questo compito? Perché il proletariato produce plusvalore?
Non tanto e non soltanto. Perché il proletariato contiene in sé come potenza, come latenza, la fine delle classi e può trasformare questa latenza in atto in sistema e programma. Programma comunista e sistema organizzante e autorganizzante per la trasformazione che è sempre azione, atto, coscienza di trasformazione. Il proletariato è già una classe universale; mentre tutte le altre classi vengono annientate, il proletariato diventa sempre più una classe che non è una classe, ma è tutto il «genere umano».
Certo non bisogna pensare la tendenza come oltre il Limite; la tendenza è da questa parte, la tendenza è il limite. Ma la tendenza fa valere i suoi effetti (ad es. «la caduta tendenziale del saggio di profitto») come se fosse fuori del limite. Occorre pensare la tendenza dentro il limite e come il limite, ma occorre trovare un aperto dove si vede un limite. E mettersi in cammino per superare la Soglia.
Oggettivo e soggettivo hanno significato, ma non hanno senso. Hanno significato perché nel modo di produzione capitalistico c’è dicotomia, antinomia, tra lavoro morto-lavoro vivo, rapporti tra cose-rapporti tra uomini, forza lavoro-classe operaia; ma non hanno senso, almeno se si intende per senso una freccia direzionale che va da qualche parte.
Ogni dicotomia, antinomia, non va in nessuna direzione; significa nella relazione fra i suoi termini e riproduce soltanto questi termini e il loro eterno rapporto come un circolo vizioso; Hegel «scopre» meno di Kant la dialettica della mediazione, la rivoluzione proletaria dovrà scoprire la fine di queste dialettiche ingannatrici ed infingarde. Nessuno ha mai detto che la fine del modo di produzione capitalistico è anche la fine della dialettica infingarda? Eppure è così evidente!
Nel modo di produzione capitalistico l’oggetto è soggettivo e il soggetto è oggettivizzato. Sia l’oggetto che il soggetto sono funzioni che trapassano l’una nell’altra, o sono ruoli che vengono posti per essere tolti. (Il soggettivismo è pura ignoranza della «storia della filosofia occidentale», oltre a tutto il resto).
Non esiste un rapporto oggetto-soggetto che non sia storicamente e socialmente specifico.
E forse non esiste neppure un’eternità del rapporto e dei suoi termini.
Può sempre essere possibile designare in modo diverso o in altro modo.
L’oggetto: ciò che è stato fatto; il soggetto: il fare.
L’oggetto: la cristallizzazione delle relazioni e dei rapporti; il soggetto: la costruzione, la creazione, l’invenzione delle realizzazioni e dei rapporti.
Non ci sono oggetti e cose, ma fatti e processi. Oggetti e cose sono i residui dei fatti e dei processi. È del tutto perverso rappresentarsi un fatto ed un processo al di fuori delle forme che formano tali fatti e processi. E qui riappaiono oggetti e cose, ma solo per scomparire. Oggetti e cose non esistono, ma non sono un niente, un nulla. Il soggetto è sempre un soggetto giuridico, è il rivestimento ideologico dei ruoli e delle funzioni. Non sono i soggetti a fare, ma gli uomini e le donne reali concreti che fanno.
Le cose, i rapporti tra le cose, nel modo di produzione capitalistico sono i soggetti reali di cui gli uomini e le donne sono oggetto. L’operaio diventa mezzo del mezzo di lavoro; appendice e strumento del sistema delle macchine. Occorre l’inversione dialettica per riconoscere l’uomo-operaio come soggetto conoscente del suo essere oggetto, come coscienza soggettivo-pratica del suo essere oggetto del capitale. Come rottura e negazione del ruolo-soggetto. Ma questa inversione non rimette semplicemente al suo «vero» posto i termini oggetto-soggetto della relazione, crea nuove relazioni e quindi nuovi termini.
«...il fondamento realmente dato, il punto di partenza del processo di produzione capitalistico è stato il di ace fra il stesso, fra le condizioni oggettive del lavoro e la forza lavorativa soggettiva» (Marx «Il Capitale»). La dicotomia oggetto-soggetto è una produzione specifica dell’economia capitalistica e suo fondamento. Distruggere il fondamento!
3. Trasvalutazione del valore-lavoro
«...la legge del valore ha validità generale, nella misura in cui la possono avere le leggi economiche, per tutto il periodo della produzione semplice delle merci, quindi fino al momento in cui questa subisce una trasformazione con l’apparizione della forma capitalistica di produzione. Fino a questo periodo i prezzi gravitano attorno ai valori determinati secondo la legge di Marx, ed oscillano attorno a questi valori, cosicché quanto più la produzione semplice delle merci si sviluppa, più i prezzi medi di lunghi periodi non interrotti da violente perturbazioni esterne coincidono, con scarti trascurabili, con i valori. La legge del valore di Marx ha dunque una validità economica generale per un periodo di tempo che va dall’inizio dello scambio che trasforma i prodotti in merce, fino al XV sec. della nostra era» (Engels «Prefazione al III vol. del Capitale»).
Uno degli errori più balzani e più maniacali del riduzionismo è quello di basarsi, per analizzare il modo di produzione capitalistico, sullo schema della legge del valore senza voler capire che questo schema rappresenta solo la prima approssimazione alla realtà, non la realtà stessa. Nel modo di produzione capitalistico, pienamente sviluppato, la legge del valore non sparisce - come credono altri citrulli - ma resta come sottofondo: sopra di essa si erge la legge del plusvalore e del massimo profitto. Infatti le merci vengono scambiate ai loro prezzi di produzione (cioè al prezzo di costo - che è sempre minore del valore di una merce perché non vi viene calcolato il plusvalore - più il profitto medio).
La legge del plusvalore ha questo di particolare: non è una legge economica «pura» (dice Marx, in termini puramente economici, cioè dal punto di vista borghese); ma è immediatamente una legge sociale che regola e determina i rapporti tra classe operaia e borghesia.
Senza proletariato non c’è più legge del valore (dal XV sec. in sù, ovviamente!). Plusvalore e lotta di classe indicano essenzialmente lo stesso processo. Sono due facce di una stessa medaglia. La produzione di plusvalore e cioè la lotta di classe è la «legge assoluta» del modo di produzione capitalistico.
C’è una continuità/rottura tra valore e plusvalore. Il valore è qualcosa di «puramente» sociale «... nemmeno un atomo di materiale naturale passa nell’oggettività del valore delle merci stesse... le merci posseggono oggettività di valore soltanto in quanto esse sono espressioni di un identica unità sociale, di lavoro umano, e che dunque la loro oggettività di valore è puramente sociale, e allora sarà ovvio che quest’ultimo può presentarsi soltanto nel rapporto sociale fra merce e merce» (Marx «Il Capitale»).
Il capitale non è una cosa, ma un rapporto e un processo sociale fra le persone mediato da cose. È un rapporto sociale/storico di produzione. Detto in altri termini la legge del valore è un rapporto sociale tra le classi. (Così il profitto è un rapporto specifico che si instaura all’interno della classe dei capitalisti).
«Solo perché il lavoro nella forma di lavoro salariato e i mezzi di produzione nella forma di capitale sono dati come presupposto - quindi solo per effetto di questa specifica forma sociale di questi due fattori essenziali della produzione - una parte del valore (prodotto) si presenta come plusvalore e questo plusvalore come profitto (rendita), come guadagno del capitalista... che gli appartiene» (Marx «Il Capitale»).
La legge del valore resta come sostrato della legge del plusvalore, geneticamente la seconda deriva dalla prima e si eleva su di essa, ma è a partire dalla seconda che si può capire la prima e non viceversa. Per questo Marx scrisse prima il terzo vol. e poi il primo vol. del Capitale. Non deve sembrare perciò strano che i riduzionisti di tutte le epoche e di tutte le salse abbiano sempre venerato il valore del lavoro, appunto perché veneravano il valore e se quindi gli operai cessano di valorizzare il capitale è il lavoro-valore e il «valore del lavoro» che vengono a crollare, mentre cominceranno ad affacciarsi altri «valori», come ad es. l’invenzione dei rapporti sociali possibili. Trasvalutazione dei valori significa creare dei loro creatori.
4. Città-fabbrica-stato come sistema integrato
Non c’è un avvenimento in ultima istanza ma un rapporto che si sviluppa e che determina da un certo punto in poi in ultima istanza (sempre presunte e sempre in una relazione di retroazione dialettica con le altre istanze). Perché ci sia un rapporto di produzione ci devono essere rapporti sociali/storici che determinano questo rapporto di produzione e questo rapporto presuppone ed è presupposto da quei rapporti. C’è una inesauribilità della dialettica o delle pluridialettiche e delle polidialettiche.
Nella fase iniziale del modo di produzione capitalistico, luoghi di produzione, apparati statali ed ideologici, istituzioni e ambiti di vita sociale, fabbrica, Stato e città, vivevano esistenze contigue, ma separate. Il modello di fabbrica e la disciplina di fabbrica ad es. sorgono storicamente fuori del processo di produzione; la divisione del lavoro era già presente nella società prima di essere «scoperta» dentro la fabbrica. Nella società «post-moderna», invece, fabbrica-città-Stato formano un sistema integrato con funzioni differenziate. Non c’è appiattimento o riduzione o schiacciamento di una funzione sopra o dentro l’altra, ma integrazione e divisione funzionale-gerarchica dei compiti.
Nel modo di produzione capitalistico la società è un mezzo di cui la produzione di plusvalore è il fine. La socialità del processo di produzione è solo un medium per l’appropriazione privata. Il rapporto sociale diventa un momento del rapporto di produzione, la società diventa un’articolazione della produzione sociale, sussunta in essa; la fabbrica diventa centro e musica di tutti i rapporti sociali, modella e plasma tutta la società. Non è che fabbrica e società diventino una sola cosa o che la fabbrica si disperda nella società, oppure che la società diventi una fabbrica, o viceversa o triceversa. Bensì il rapporto sociale di produzione diventa responsabile di tutti i rapporti sociali e ne fa suoi ingranaggi, li mette al suo servizio.
La razionalizzazione dei rapporti capitalistici dentro la fabbrica si estende all’intera rete dei rapporti sociali. È l’organizzazione interna alla fabbrica che è d’esempio all’organizzazione generale dei rapporti sociali e dello Stato come regolatore e controllore di questi rapporti e della loro riproduzione.
L’impresa, presa come molecola autosufficiente, anche quella multinazionale, non può più governare il ciclo (i cicli di produzione), né il mercato, né la forza lavoro, per questo deve integrarsi con lo Stato (Stati) e nell’area (aree). La struttura delle holdings multiproduttive e multisettoriali, comporta una complessa, ma ferrea gerarchia dei vari settori e delle varie attività; nei vari settori e nelle varie attività. Tutto ciò richiede la mobilitazione permanente delle aree e degli Stati. Si pensi ad es. alla Fiat: alla convergenza/sconvergenza tra «casa madre» e i vari stabilimenti terminali, o alla coordinazione tra settore auto, nucleare, acciai speciali ecc., o fra le attività industriali, finanziarie, commerciali,ecc.
Le imprese multinazionali diventano Stati fra gli Stati e costruiscono città di officine e di attività. Così la metropoli, sede dell’impresa-capofila, diventa da un lato «capitale di un impero produttivo» e dall’altro un’azienda efficiente; e così lo Stato-nazione si trova sempre più impegnato nell’allargare i suoi uffici amministrativi e sempre più impegnato direttamente come grande impresa multinazionale.
Il governo dell’area diventa importante e anche più importante del governo dello Stato. (Lo ha dimostrato bene Agnelli con la operazione che va dai «61 licenziati», attraverso gli arresti di Marzo-Aprile, fino allo scontro dell’Ottobre 1980).
Non deve stupire che città e Stato possano essere termini equipollenti, ad una impresa multinazionale può essere più «vicina» una determinata area metropolitana che lo Stato-nazione. (Per Agnelli, Torino è certamente più importante di Roma).
«L’autonomia relativa» delle aree metropolitane e «l’autonomia relativa» della impresa multinazionale non significano certamente balcanizzazione o decentramento, ma riconcentramento che segue, però, non la logica dello Stato-nazione o del mercato interno, ma la logica degli apparati economico-finanziari, politico-militari, delle grandi holdings e dei vari organismi sovranazionali. Multinazionalizzazione - centralizzazione del controllo e del comando - informatizzazione del territorio dell’area - rafforzamento degli apparati sovranazionali - ristrutturazione imperialista dello Stato, non sono quattro cinque processi sconvergenti e difformi, bensì aspetti di un unico processo che triturando il vecchio lascia accanto ai nuovi e più alti grattacieli una serie di muri sbrindellati, mattoni scoloriti e granuli di ogni tipo.
Nella misura in cui lo spazio e il tempo diventano condizioni della produzione e della riproduzione e anche «oggetti di lavoro», occorre porsi in grado di cogliere gli intrecci, le interferenze, le multidimensionalità, le plurivalenze, non le giustapposizioni, ma le sovrapposizioni e le congiunzioni.;
In questo universo integrato non c’è più un posto da dove si può dire «da qui io posso partire».
All’interno di questo sistema città-fabbrica-Stato non solo non è necessaria l’ipotesi di rapporti sociali fra gli uomini, ma questi stessi legami devono essere rimossi e sostituiti da legami e da rapporti funzional-tecnici. All’interno di un insieme sistemico devono prevalere e prevalgono le funzioni sistemiche e i rapporti sistemici, chiunque non sia dentro queste funzioni e questi rapporti fa parte, automaticamente, di quella complessità e varietà proliferante che è necessario selezionare, ridurre, annichilire, laserizzare. (Un sistema deve aumentare la sua complessità riducendo la complessità, è questo il «grado zero» della teoria dei sistemi).
L’informatica - arma e veicolo di questo universo - prima di essere un insieme di tecniche e di macchinari, è un modo di pensare che produce una serie di schemi operativi, i quali sono fatti a misura della macchina (calcolatore), «suggeriti» dalla macchina stessa, dalla sua struttura, da come e per chi viene costruita e da come e per chi funziona. In questo senso si può dire che veramente la macchina pensi, in quanto riduce l’uomo a pensare a sua misura e invece di essere prolungamento del cervello dell’uomo riduce questo cervello e quest’uomo a sua immagine e somiglianza.
Il modo di funzionare della «chincaglieria» (Hardware) determina il tipo e l’ambito del software (materia grigia), sia per quanto riguarda la maniera di organizzare il sistema produttivo che per quanto riguarda il sistema sociale, o qualsiasi altro sistema.
Il ridurre i fenomeni ad un sistema serve per controllare i fenomeni mediante la costruzione di un sistema. Per arrivare a definire un sistema occorre passare attraverso la sua modellizzazione. Il modello non è una semplice analogia, esso permette di controllare il funzionamento del fenomeno/i, simulandolo in laboratorio, e di prevederne le varianti, le evoluzioni e di anticiparne e correggerne i difetti. Tutto ciò ha un punto oscuro: qualsiasi sistema è impensabile per il calcolatore, nel senso che la complessità di un sistema (cioè dei fenomeni che il sistema organizza) è così elevata che il calcolatore non può che considerarne una minima parte, a parte che la complessità e la varietà (dei fenomeni) si generano e si moltiplicano di continuo. Semplificare, ridurre, ritagliare il piede per farlo entrare nella scarpa, è necessità vitale per il calcolatore e quindi per i cibernetici sociali, mentre invece la realtà: l’uomo, la società, la natura, si accrescono continuamente di infinite complessità e di loro infinite possibilità. Per essere un sistema pensabile e quindi regolabile e manipolabile, l’uomo e la donna, non solo devono essere isolati dagli altri ma devono essere «isolati da se stessi». Ridotti a ruolo con un minimo di varianti e di funzioni rigidamente predeterminate. Ma questo non basta ancora ai nostri cibernetici sociali perché il controllo e la manipolazione non devono essere soltanto integrali, ma intrinseci. Cioè dentro l’individuo-ruolo deve essere «introdotto» un «dispositivo omeostatico» che blocca preventiva mente all’origine ogni possibilità di insorgenza di una coscienza del ruolo di se stesso, come individuo sociale.
Ma non sono tanto le variabili impazzite a preoccupare i «grandi ierofanti» dei sistemi, bensì le «onde anomale», le onde del futuro, le onde che vengono dal futuro, e che non possono essere né previste, né prevedibili. AI di sopra e al di sotto del sistema e dei suoi rigidi rapporti c’è tutto il resto, c’è tutto. C’è tutto ciò che sorge e si sviluppa ed è per questo invincibile.
5. La grande fabbrica multinazionale.
L’informatizzazione della produzione diventa informatizzazione del territorio e della area. Il processo produttivo si estende e si allarga non come spazio, ma nello spazio. L’impresa multinazionale deforma lo spazio-tempo. Si pensi ad es. al trasporto della forza lavoro e ai trasferimenti di forza-lavoro, oppure al trasporto e ai trasferimenti di materie prime, de semi-lavorati, dei prodotti, all’interno di uno stesso settore o tra settori nelle grosse holdings. Oppure alla ricomposizione e al montaggio finale dei vari prodotti, alla tecnologia o al know-how, oppure all’ingegneria finanziaria e al marketing ecc.
Alla grande fabbrica tradizionale si sostituisce l’impresa multidivisionale, multidimensionale; la grande fabbrica multinazionale. Non è più possibile comprendere i fenomeni contrapposti della concentrazione /riarticolazione/scorporamento/decentramento, senza comprendere i nessi che muovono questi fenomeni. Se si tiene fermo il concetto di gran fabbrica, la multidimensionalità dei fenomeni ci appare come un misterioso garbuglio dal quale - come in un gioco di prestigio - si possono «estrarre» le più strampalate ipotesi.
L’analisi dell’informatizzazione della produzione ci riporta alla tendenza principale del processo produttivo: la produzione di informazioni.
L’informazione non è comunicazione, di qui il nuovo feticismo.
L’informazione non ha solo una funzione di riproduzione sociale, ma anche quella di trasformazione o deformazione sociale in quanto incide sulle forme di coscienza e di razionalità. Il campo di intervento dell’informazione non sono soltanto i rapporti politici e sociali, ma proprio l’azione collettiva nel senso più ampio del termine.
«Lo sviluppo del capitale fisso mostra fino a quale grado il sapere sociale generale, knowledge, è diventato forza produttiva immediata, e quindi le condizioni del processo vitale stesso della società sono passate sotto il controllo del general intellect, rimodellate in conformità a esso; fino a quale grado le forze produttive sociali sono prodotto non solo nella forma del sapere, ma come organi immediati della prassi sociale, del processo di vita reale» (Marx, «Lineamenti...»).
L’informazione è un’astrazione che può venire misurata, comunicata, immagazzinata ed elaborata. L’informazione viene misurata in base al valore di «novità», cioè al grado di sorpresa che determina in chi la riceve. (Non c’entra nulla ma nella merce-informazione anche il valore d’uso cessa di essere un «oggetto materiale»). La produzione di informazioni può essere quantificata e resa misurabile, e quindi confezionata e venduta come merce, in base alla durata di tempo in cui il suo contenuto informativo produca conoscenza. È noto ormai, come alcune grandi multinazionali (elettronica, informatica...) non vendano più soltanto un prodotto-merce, ma vendano anche progetti di prodotti-merce. Con l’informatizzazione della produzione tutto è riducibile ad un segnale, anche la merce può essere ridotta ad un suo segnale e può essere venduta e comprata come simbolo di questo segnale.
Nel denaro «il valore delle cose è separato dalla loro sostanza», questo non sarebbe possibile se segni e simboli non fossero prodotti dalle relazioni stesse, dai rapporti sociali, e non fossero l’espressione e la «sostanza» di queste relazioni e di questi rapporti. La riduzione a segnale è, dunque, possibile perché il valore è un geroglifico sociale; non è il suo contenuto fisico che conta, ma il suo contenuto sociale e come qualsiasi contenuto sociale, la merce come il denaro, può essere rappresentata da un segno.
«In seguito, gli uomini cercano di decifrare il senso del geroglifico, cercano di penetrare l’arcano del loro proprio prodotto sociale, poiché la determinazione degli oggetti d’uso come valori è loro prodotto sociale quanto il linguaggio» (Marx, «Il Capitale»).
Il segno, nel caso del progetto-merce, diventa simbolo di merce-futura.
Il capitale deve dominare il futuro perché il plusvalore prodotto ha realtà solo se in un futuro, che può essere aleatorio, può essere realizzato. Il plusvalore del resto non è neppure una merce precisa, sta nelle merci, viene prodotto nel processo di produzione, ma viene realizzato nel processo di circolazione. Mentre con il credito il capitale domina il plusvalore futuro in quanto denaro, con l’informatizzazione e la merce-informazione, il capitale domina il plusvalore futuro come segnale e simbolo, scinde il segno sociale del valore-plusvalore dal corpo fisico del valore-plusvalore. Realizza un simbolo (progetto-merce) mediante un segno (credito-denaro).
Gli individui sono ora dominati da astrazioni. «L ’astrazione o l’idea non è però altro che l’espressione teoretica di quei rapporti materiali che li dominano». (Marx, «Lineamenti...»)
L’industria del futuro richiede una programmazione del tempo. Produrre per il futuro significa produrre il tempo. Il capitale attraverso la produzione del tempo condiziona gli uomini e le donne. L’uomo «carcassa del tempo» è escluso dal tempo.
Se quanto si è detto rispetto all’integrazione di Stato-fabbrica-città è verosimile: ristrutturazione del processo produttivo significa immediatamente ristrutturazione complessiva della riproduzione dei rapporti sociali capitalistici.
Ad ogni fase tutto si ripresenta diverso, seppur uguale, in una specie di moto perpetuo che gira intorno allo stesso centro. Produzione è immediatamente riproduzione, le condizioni della produzione, sono, in pari tempo, condizioni della riproduzione e viceversa. La riproduzione allargata è perpetuazione del rapporto di dipendenza dell ’operaio dal capitalista, essa Si presenta come concentrazione crescente dei mezzi di produzione e del comando sul lavoro. Il processo di produzione è presupposto «come un prius», il ciclo del capitale produttivo è immediatamente «non soltanto produzione, ma periodica riproduzione di plusvalore». La riproduzione è riproduzione delle classi.
Lo Stato entra nella riproduzione come responsabile della riproduzione delle classi. Lo Stato-funzione è questo farsi carico delle spese per la riproduzione della forza lavoro: dall’assistenza sociale alla scuola alle vie di comunicazione-trasporto ecc. La moneta rientra per intero nella sfera dello Stato, il quale è anche mezzo della circolazione delle merci e strumento per la realizzazione del plusvalore. Produzione e riproduzione si combinano come costituenti del capitale complessivo e dello Stato.
«Quando si parla dunque di produzione, si parla sempre di produzione ad un determinato livello di sviluppo sociale - della produzione di individui sociali» (Marx, «Lineamenti...»).
Riproduzione è al tempo stesso, necessariamente, conservazione dei rapporti sociali precedenti, distruzione delle vecchie forme e produzione di nuovi rapporti. L’atto della riproduzione non modifica solo le condizioni oggettive, ma gli stessi produttori.
La dissoluzione di un modo di produzione, su cui si basa una comunità, dissolve anche il singolo individuo nella sua «oggettività interiore».
«AI pari di tutti quelli che lo hanno preceduto, il processo di produzione capitalistico si svolge in condizioni materiali determinate, che sono al tempo stesso depositarie di determinati rapporti sociali, in cui gli individui entrano nel processo di riproduzione della loro vita. Queste condizioni, come questi rapporti, sono da un lato i presupposti e dall’altro i risultati e creazioni del processo di produzione capitalistico; essi sono prodotti e riprodotti da esso» (Marx, «Il Capitale»).
Accorgersi di una nuova forma è accorgersi di un nuovo contenuto, e il nuovo che è contenuto non è l’eterno ritorno delle categorie economiche borghesi, ma la biforcazione delle forme, lo sfaldamento delle forme che non riescono più a contenere nuovi contenuti. Le possibilità sono come dei buchi in una palla di cera. Da questi buchi, però si può uscire!
Aperta parentesi: non è che esista un «lavoro riproduttivo» sopra a quello produttivo come finge di credere O’Connor; non c’è un lavoro riproduttivo allo stesso titolo di un lavoro produttivo. C’è sempre una dialettica tra lavoro concreto e lavoro astratto, tra cose e rapporti. Si producono rapporti sotto forma di cose e manipolando le cose e non si producono affatto astrazioni sotto forma di rapporti. Ogni segno si richiama sempre ad un referente, pensare ad un referente senza segno sociale o segno senza referente materiale è credere che possa esserci una produzione di astrazioni per mezzo di astrazioni. Chiusa parentesi.
La grande fabbrica multinazionale può essere considerata come un sistema dinamico, aperto e non lineare, funzionante secondo il principio che Prigogine ha messo in luce: l’ordine mediante fluttuazione.
La fabbrica-capobastone, nella grande fabbrica multinazionale, non è però soltanto un centro di comando e di controllo, essa è questo solo nella misura in cui detiene il potere di riaggregare la produzione e il prodotto singolare, nella misura in cui detiene una tecnologia e una «conoscenza» superiore a tutti i livelli. Sostenere che ormai la produzione materiale si effettua nelle agenzie decentrate mentre il piano-monitor sarebbe privilegio della fabbrica centrale, è ritornare a Cartesio non a Spinoza, il quale ultimo era rigidamente monista.
La fabbrica centrale non centralizza, in poche parole, solo i significati, ma anche i loro veicoli: i significanti. La fabbrica-capofila non è soltanto depositaria dell’inizio (piano), ma anche della fine (operazione conclusiva) del ciclo produttivo. Ci sarà un «loculo» dove le lavorazioni verranno completate, dove - volendolo - si possa anche «vedere uscire» le Panda nuove e fiammanti, oppure no?! Anche ammesso che il centro «pianificatore» sia cartesianamente separato nello spazio dal centro «assemblatore», possiamo pur stabilire, spinozianamente, un nesso indissolubile tra questi «due centri» e vederli, nello «spazio logico», come un unico centro. La grande fabbrica multinazionale possiede la caratteristica di dispiegarsi attraverso uno spazio geografico difforme e discreto, ma il suo spazio logico è invece unitario e lineare.
6. Il processo produttivo come processo semiologico.
Analogicamente alla psicanalisi di Lacan, il processo produttivo può essere inteso come un significante di cui non c’è significazione; un significante di puro non-senso, in quanto il significante (la cosa, la merce) non può che rapportarsi ad un altro significante in una catena infinita. Ciò che non appare mai è la significazione (i bisogni sociali, gli uomini concreti) dell’essere-apparire. Altro dei significati nei loro significanti o come significati. Scambiare i significanti per i significati è l’abbaglio specifico contenuto in tutte le regioni della formazione sociale capitalistica.
La produzione di plusvalore rimanda ad un altro plusvalore già prodotto e richiede, presume, presuppone, nuovo plusvalore. Per il capitalista il capitale costante è superiore al capitale variabile, il fine scompare e appare il limite: il tempo della coazione a ripetere, la produzione per la produzione, produrre per poter produrre. Il plusvalore è il mezzo di se stesso ed è il fine di se stesso, il capitalista non ne è che la funzione: l’operaio... lo strumento. Il capitale produce in quanto mezzo il proprio essere fine di sé Produce solo il proprio limite, si produce come limite.
Attraverso l’informatizzazione dei processi produttivi tutto diventa riducibile ad un segnale, tutto deve poter essere riducibile ad un segnale. Segnale significa informazione e controllo, segnale significa comando, sugli uomini e sulle cose. Gli stessi uomini e cose sono riducibili (devono poter essere riducibili) a segnali e trasformabili in utensili animati del sistema delle macchine. «L'attività dell’operaio, ridotta ad una semplice astrazione di attività, è determinata e regolata da tutte le parti dal movimento delle macchine e non viceversa». (Marx, «Lineamenti...»)
Ridurre tutto a dei segnali vuol dire poter rappresentare e quantizzare i fenomeni, vuol dire poter trasformare ogni qualsivoglia fenomeno in ogni qualsivoglia altro fenomeno (di uguale o diversa qualità) o quadriceversa. I segnali possono, inoltre, essere raggruppati in reti logiche di controllo, in dispositivi di comando, che agiscono in tempo reale (cioè in tempo zero tra l’ordine impartito e la sua esecuzione). Le reti logiche del comando e del controllo sono reti retroattive e omeostatiche, sono alghenodi: anelli alghenodici. (Si veda ad es. la «Logistica» e i «Sistemi informativi» introdotti per la gestione e l’ottimizzazione della produzione alla Fiat)
Il principio regolatore del sistema delle macchine diventa principio determinante in ogni campo. Nel modo di produzione capitalistico l’operaio esiste «per i bisogni di valorizzazione dei valori esistenti» invece che, al contrario, «la ricchezza materiale esista per il bisogno di sviluppo dell’operaio». Dal punto di vista della macchina (il «Grande Fratello») il processo lavorativo è un rapporto tra significanti. Il dominio del segnale è il dominio dei calcolatori e della loro logica. Il sistema automatico di macchine viene «messo in moto da un automa, forza motrice che muove se stessa; questo automa è costituito da numerosi organi meccanici e intellettuali, di modo che gli operai stessi sono determinati solo come organi coscienti di esso» (Marx, «Lineamenti...»).
Il «primo motore» non è più come ai tempi di Marx, il vapore o come in seguito l’elettricità, ma... la parola. I calcolatori devono parlare, dialogare (trasmettere e ricevere), con il «management superiore» e tra di loro (interfacciamento); l’energia meccanica, elettrica ecc., è il rumore di fondo; per poter lavorare (raccogliere, selezionare, smistare, memorizzare, scambiarsi informazioni) i calcolatori devono «cooperare» e per cooperare hanno bisogni di nuovi e più sofisticati linguaggi.
La produzione di informazioni, di dati, di programmi ecc., sta diventando la «sovrastruttura» della produzione di plusvalore. La creazione di nuovi linguaggi (linguaggi macchina, linguaggi logici, algebrici, ecc.) riveste importanza notevole per fornire un supporto di riferimento entro il quale diventa possibile produrre nuova informazione-merce.
La «cooperazione» tra macchine tenta di sostituire la cooperazione tra gli uomini. I rapporti «sociali» tra cose giungono qui al punto di perfezione-esplosione. Ma non c’è di che preoccuparsi, nonostante la tecnodicea oggi imperante le macchine non cooperano... vengono collegate. E la produzione di nuovi linguaggi per le macchine potrebbe anche trasformarsi in creazione di nuovi rapporti di comunicazione tra gli uomini. Isolamento nello spazio e nel tempo, isolamento dallo spazio e dal tempo, è una delle conseguenze principali della produzione di plusvalore in quanto produzione di significanti. La fabbrica - luogo privilegiato della produzione di plusvalore - è anche luogo privilegiato della produzione di isolamento. L’isolamento, come modalità delle relazioni sociali borghesi, tracima dalla fabbrica alla società. Ma la fabbrica resta luogo di massima socializzazione possibile nell’universo capitalistico, dove la cooperazione tra gli operai imposta dal sistema delle macchine, si trasforma continuamente in processo di significazione. Altra: in sovversione operaia, in organizzazione rivoluzionaria.
Ogni individuo sociale è una moltitudine, ma è moltitudine finché resta «animale sociale». Se si toglie il sociale resta solo... animale!
Per questo Taylor-Ford amavano l’operaio «preso in isolamento» - il gorilla ammaestrato - e gli odierni «ingegneri dei sistemi» amano la «macellazione» del corpo dell’operaio, la frammentazione dei gesti, la separazione tra corpo e mente, tra sensi e attività, la valutazione per «posto di lavoro», la produzione «per isole». La «scienza dell’isolamento» contiene al suo interno anche la «scienza della cooperazione proletaria», la «scienza della rottura dell’isolamento», e ne è a sua volta contenuta. Non ci sono due scienze separate, ma lotta di classe all’interno della scienza; per questo si può e si deve percorrere il cammino inverso: dalla critica della «scienza dell’isolamento» fino alla «scienza della cooperazione proletaria». Ma sempre dal punto di vista della rottura e non della critica.
Nell’universo capitalistico non si può partire da nessun Qui perché questo Qui è il Qui della realtà: lo spazio-tempo, la razionalità, le strutture, le istituzioni del capitale. Ma dalla moltitudine «io» posso partire, io posso creare lo spazio-tempo del collettivo e della comunità. Da «qui» posso partire per’ inventare gli universi del possibile e per creare quel «mondo che siamo», un mondo dove tutto ciò che è Sopra è Dentro, dove l’altezza diviene profondità. E dentro è la circonferenza e fuori è il centro e avanzando ci si espande per conformarci al centro.
7. Proletariato metropolitano e operaio metropolitano.
Propongo le definizioni di proletariato metropolitano e operaio metropolitano non per stabilire delle formule, ma per proporre dei termini di un linguaggio comune da costruire collettivamente.
In seguito ad una serie di fenomeni, che si è cercato di illustrare nei paragrafi precedenti, la composizione di classe metropolitana è tutta da analizzare e da scoprire. Accanto ai produttori di plusvalore e dai produttori di plusvalore, comincia a sorgere una nuova figura: i produttori di rapporti sociali possibili.
I nuovi muratori che invece di costruire dei muri aprono delle finestre.
L’analisi di classe, che propone Marx nella sua opera, parte dell’operaio preso in isolamento come produttivo individualmente di plusvalore (perché così è posto dal capitale) e finisce con l’operaio collettivo, l’operaio combinato, produttore della riproduzione dei rapporti capitalistici, ma anche creatore delle finestre aperte verso i rapporti sociali possibili. Il metodo di Marx è: dall’inizio alla fine, partire dall’inizio per spiegare la fine, ma partire dalla fine per capire l’inizio. L’analisi parte sempre dalla formula-cellula, ma la sintesi è qualcosa di più dell’insieme delle cellule. Tanto più l’indagine è microscopica tanto più si adatta al singolo, al particolare, tanto meno la comprensione generale - macroscopica - sarà precisa e definita.
Il metodo dialettico dovrebbe procedere su ambedue le parallele contemporaneamente: una dal complesso al semplice e l’altra dall’elementare al complesso. Geneticamente sì passa sempre da un tutto a un tutto, paleontologicamente ogni totalità ridefinisce e riplasma la totalità precedente ed è quindi altra totalità. Il movimento della conoscenza/interpretazione è duplice (molteplice) e s’espande a spirale. È merito dei riduzionisti (dal «basso» e dall’«alto») averci fatto capire questo metodo.
Ci sono due tipi di riduzionisti: quelli che riducono tutto all’operaio singolo produttivo di plusvalore e quelli che riducono tutto all’operaio collettivo, sociale. Ambedue i punti di vista: quello iniziale e quello finale sono astrazioni al limite; astrazioni morte, se non vengono prese come modelli di partenza e d’arrivo del movimento reale e concreto. Modelli da far reagire, nel laboratorio del pensiero - mediante la forza d’astrazione - simulando gli scenari virtuali e possibili per poter afferrare e comprendere la realtà in divenire.
L’operaio produttivo in isolamento non esiste se non come parte di una comunità, di una classe; l’operaio complessivo, collettivo, resta sospeso nell’aria se viceversa non viene ricondotto alle concrete individualità, storicamente agenti, che lo compongono. Ogni piolo di una scala è un gradino, ma è gradino in quanto facente parte di una scala. Non c’è scala senza pioli, ma i pioli non sono gradini se non c’è una scala. Occorre però gettar via la scala dopo che si è saliti sui gradini, oltre la scala! L’operaio singolare è già la totalità in processo di tutti gli operai in quanto individuo, ma l’operaio complessivo non è semplicemente la totalità degli operai individuali. La dialettica non è soltanto polare, ma anche plurale. L’uomo (e gli uomini e le donne reali e concreti) non si riproduce in una dimensione determinata, ma produce la propria totalità («metatotalità») e come totalità sta nel movimento di una totalità che diviene.
Il proletariato metropolitano è perciò sia unità del molteplice a dominante operaia, sia totalità autosufficiente ed autodeterminata. L’operaio collettivo, l’operaio senza abilità, visto «salendo», è dunque operaio-massa; visto «scendendo», è operaio metropolitano. Salendo «vediamo» le molteplici figure che compongono il proletariato metropolitano (operaio-massa, operaio-marginale, extralegale ecc.); scendendo «vediamo» le molteplici varianti del proletariato metropolitano (vecchi e giovani, uomini e donne, indigeni e foresti, ecc.).
Come operaio-massa la sua determinazione fondamentale è quella di essere produttivo di plusvalore e di occupare gli spazi centrali della grande fabbrica multinazionale.
Come operaio-metropolitano è operaio combinato, operaio complessivo, ed occupa qualsiasi spazio all’interno della galassia della grande fabbrica multinazionale: dal fuoco centrale fino al buco nero.
Come operaio-comunista sì dedica, invece, alla distruzione del vecchio e alla invenzione del nuovo. Si dedica a vincere una partita a scacchi cambiando contemporaneamente le regole del gioco e cambiando anche il gioco.
I riduzionisti sostengono che il plusvalore è tempo di lavoro non pagato, mostrandoci, con questa definizione, il capitalista come un ladro miserabile, come uno che ruberebbe solo cose, soldi ecc. Il capitalista ruba cose, soldi ecc.; ma succhia attraverso questi la vita e il tempo dell’operaio. Il furto di tempo di lavoro è furto di tempo di vita; lo sfruttamento della forza lavoro è alienazione di tutto un mondo di sensibilità.
Nella metropoli non sono i bisogni della miseria che muovono, ma è la ricchezza del bisogno di rapporti sociali, umani, a creare il movimento. È ciò che gli operai vorranno fare che riflette ed esprime la coscienza del fare, non ciò che saranno costretti a fare in virtù del loro essere, ma ciò che vorranno essere in virtù del loro fare. La coscienza del possibile non è data dalla realtà, ma nella realtà; in quanto coscienza della trasformazione viene conquistata soltanto attraverso una feroce e prolungata battaglia culturale in cui l’individuo-comunità non è solo la freccia, ma anche il bersaglio della rivoluzione.
L’uomo è determinato in ultima istanza dalla sfera materiale e biologica (produzione e riproduzione), ma è ricostruito, riplasmato, rifatto, dalla cultura (cioè da se stesso); è ricostruito psicologicamente e socialmente dalla cultura intesa come insieme di pratiche storicamente e socialmente significative. L’individuo sociale è un prodotto sociale. La socialità si esprime sia nello sviluppo della base materiale per la riproduzione della vita, sia - soprattutto - nello sviluppo della comunicazione e del sapere sociale e dunque della lingua che ne è supporto e veicolo. La produzione dell’uomo è riproduzione sociale dell’umanità (l’uomo è un processo e precisamente il processo delle sue pratiche storico/sociali); in questa produzione e riproduzione una posizione centrale occupano gli «strumenti psicologici» e gli «strumenti sociali».
Trasformare il mondo esterno (naturale, sociale) è trasformare il mondo interno (psicologico), ma per trasformare il mondo esteriore occorre trasformare il mondo interiore.
8. Corporazioni controrivoluzionarie e controrivoluzione preventiva.
La proletarizzazione crescente e diffusa e «la soppressione del modo di produzione capitalistico nell’ambito dello stesso modo di produzione capitalistico» porta ad un «socialismo borghese».
La forza lavoro non solo deve negarsi come capitale, ma deve combattere se stessa in quanto capitale. La lotta si introietta: dentro la classe, dentro l’individuo.
La teoria della «doppia classe operaia» esprime imprecisamente, a mio parere, un fenomeno reale: la formazione di una «classe operaia di tipo superiore» coincide o tende a coincidere con il dissolvimento della proprietà nelle «società per azioni», nel «capitalismo di Stato» ecc. e all’apparire di «possessori dei mezzi di produzione» (managers) che non sono giuridicamente proprietari degli stessi.
Il capitalista non è necessario, il capitalista è una funzione di capitale, per cui al capitalista-proprietario può essere sostituito e viene sostituito il funzionario del capitale. I ruoli del proprietario e del dirigente, prima uniti, vengono scissi in due «persone» distinte: l’azionista e il dirigente. All’interno stesso dell’impresa il sistema delle macchine, spacca in due le funzioni operative: i controlli e i controllati. Quelli che controllano (quadri, capi, aristocrazia operaia, bonzi sindacali) non le macchine, ma le forze-lavoro appendici delle macchine e quelli che servono le macchine e sono a queste subordinati.
La distinzione proletariato non pericoloso/proletariato pericoloso, è, a mio giudizio, descrittiva e rischia più di confondere che di chiarire.
La borghesia, come tutte le classi morte, abbandona sempre più le sue prerogative, per mantenere intatti i suoi privilegi, e ne delega le funzioni agli «schiavi emancipati». Lo stesso fenomeno avveniva all’epoca del crollo dell’Impero Romano d’Occidente.
L’emancipazione di alcuni schiavi non elimina però la schiavitù: la estende e la perpetua. Questi schiavi emancipati sono gli «Essi in Noi». E sono anche dei fessi! La contiguità e coincidenza tra managers e controllori non crea un insieme omogeneo, ma insiemi raccogliticci di caste e di corporazioni. In quanto funzioni, tutti costoro non hanno un’identità che non sia quella della frazione di capitale che rappresentano, delle lobbies di cui sono «docili strumenti». Soltanto la «voce ridondante del padrone» riesce a ricostruire un’identità artificiale, a mobilitare queste caste e corporazioni controrivoluzionarie spezzettate e «l’una contro l’altra ostili» a causa dei loro meschini e futili interessi.
Per la classe operaia il «nemico interno» è lo stesso del «nemico esterno»: «Essi sono Loro» (la manifestazione dei capi Fiat).
Per promuovere uno schieramento sociale occorre un programma e una pratica sociale, questo sia per la rivoluzione che per la controrivoluzione. Ma la controrivoluzione preventiva, proprio come concetto, deve rimuovere il sociale, farlo sparire, non permettere che si arrivi a questo punto. Quando lo scontro di classe arriva ad investire il sociale la controrivoluzione preventiva è già fallita; ciò non dimostra però, che il movimento rivoluzionario abbia già vinto la guerra. Per non arrivare a questo punto lo Stato può utilizzare un vasto armamentario: la creazione degli stati d’animo, il feticismo dei mass-media (dove la notizia diventa il fatto e il fatto non è fatto se non è notizia), la tecnologia del controllo, la destrutturazione dell’io della coscienza, ecc.
La rivoluzione proletaria nella metropoli si svolge nello spazio-tempo rarefatto e spettrale di un universo dove ogni processo è ridotto ad uno stato di cose e questo stato di cose viene riempito di oggetti incolori. Dove tutto il sociale non appare che attraverso un segno politico, dove tutto il sociale si risolve nel politico e il cambiamento politico previene ed impedisce la trasformazione sociale.
Il progetto della borghesia imperialista di disgregazione della classe e della coscienza di classe si accompagna alla promozione di modelli normativi, modelli di riferimento, che suscitino un’identità artificiale rispetto alla quale far convergere sia i gruppi corporativi, sia tutti quegli individui gregarizzati e idiotizzati dalla frantumazione capitalistica del corpo e della mente e dalla loro scissione. La folla che viene, in questo modo, di volta in volta raccolta e intruppata, è estremamente fragile e psicolabile e serve da claque ai tecnici militari e civili della controguerriglia.
Il politico non è più che una forma in via di estinzione, la posta e la meta diventano i bisogni sociali immediati e i rapporti sociali possibili. La forma politica che la rivoluzione proletaria deve assumere non è per sé, ma contro il nemico. Lo Stato del capitale deve essere affrontato e battuto anche sul suo terreno, dunque politico.
La guerra di classe si risolve nel sociale, ma si decide nel politico.
Il politico è fondamentale per la borghesia che, attraverso il suo Stato, deve perpetuare ed imporre le condizioni della produzione, che sono date come condizioni «a priori»; per il proletariato è invece fondamentale farla finita con tutto questo.
Il sociale e il politico sono incommensurabili. Il sociale non si lascia rinchiudere in nessuna sfera. Occupa trasversalmente le regioni della struttura e della sovrastruttura. Esso è la misura della società. Il sociale è quella categoria dove affondano e/o lievitano tutte le regioni della struttura e della sovrastruttura. È forma e contenuto. La lingua è il sociale stesso.
La rivoluzione è politica contro lo Stato borghese, ma è sociale per il proletariato, è sia distruzione che creazione: distruzione della razionalità del reale e del reale come razionalità, costruzione dei rapporti sociali virtuali e possibili. A mo’ di aforisma si potrebbe parlare di una «doppia rivoluzione» (politico-culturale) e di una trascrescenza della rivoluzione politica in rivoluzione culturale. Non soltanto la lotta contro lo Stato borghese è una rivoluzione, ma anche il passaggio al comunismo è una rivoluzione sociale.
9. Al di là del limite: il tempo disponibile.
AI di là della barriera tecnologica della produzione di plusvalore, ci sta il regno della libertà.
«Il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna: si trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria... Al di là di esso comincia lo sviluppo delle capacità umane, che è fine a se stesso, il vero regno della libertà, che tuttavia può fiorire soltanto sulle basi di quel regno della necessità» (Marx, «Il Capitale»).
Il tempo di non lavoro, il tempo disponibile, sarà la misura della libertà ed il «valore» della transizione al comunismo.
«Ne sutor ultra crepidam» (= «non vada il calzolaio oltre la scarpa») è diventato, diceva Marx, una terribile follia.
Alla bandiera vetero-borghese del «diritto al lavoro» Lafargue rispondeva sprezzatamente che questa è la bandiera degli schiavi volontari. Gli operai devono rivendicare i vizi non le virtù delle classi dominanti e il sommo fra tutti i vizi: l’ozio!
Liberarsi dalla follia capitalistica del lavoro per riappropriarsi della follia dell’ozio e del gioco, per sciogliere la fantasia creatrice, per inventare la follia dello sviluppo onnilaterale dell’uomo; è questo il luogo e la posta della transizione verso il comunismo.
La polemica contro due scritti comparsi su Controinformazione offre l’occasione per approfondire l’analisi di alcune questioni: rapporti di produzione e nuove tecnologie, politica ed economia nelle società imperialiste, rivoluzione politica e rivoluzione sociale, abolizione dello stato ed estinzione dello stato, socialismo e maturità del comunismo, centralità della classe operaia e nuovi soggetti sociali, aristocrazia proletaria dei paesi imperialisti, natura di classe dell’URSS e delle democrazie popolari dell’Europa Orientale, rapporti dell’URSS con i paesi del Terzo Mondo, bilancio della esperienza storica di transizione dal capitalismo al comunismo, partito rivoluzionario e rapporto di scambio e di capitale.
Un periodo trentennale di sviluppo capitalistico è terminato. Dopo le distruzioni e gli sconvolgimenti politici e sociali prodotti dalla Seconda Guerra Mondiale, il capitale ha avuto circa trenta anni di crescita durante i quali nessuna rivoluzione proletaria ha potuto svilupparsi nelle metropoli imperialiste. L’inizio della seconda crisi mondiale per sovrapproduzione assoluta di capitale mette nuovamente all’ordine del giorno la rivoluzione proletaria per il comunismo. Ai compiti di questo periodo è dedicato questo libro, che si preoccupa di fare un bilancio dell’esperienza della lotta di classe nei paesi imperialisti e, sopratutto, un bilancio dell’esperienza della lotta di classe e delle forme della transizione dal capitalismo al comunismo nei paesi dove le forze rivoluzionarie del proletariato erano arrivate alla conquista del potere.
Questo libro è stato scritto per quei compagni che si. pongono la questione di trovare una via alla rivoluzione comunista nei paesi imperialisti e per quei compagni che avvertono il bisogno di andare oltre il berciare interessato dei borghesi e dei loro servitorelli per capire le possibilità del presente e i motivi delle vittorie e delle sconfitte del passato. Vuole essere un contributo allo sforzo comune.